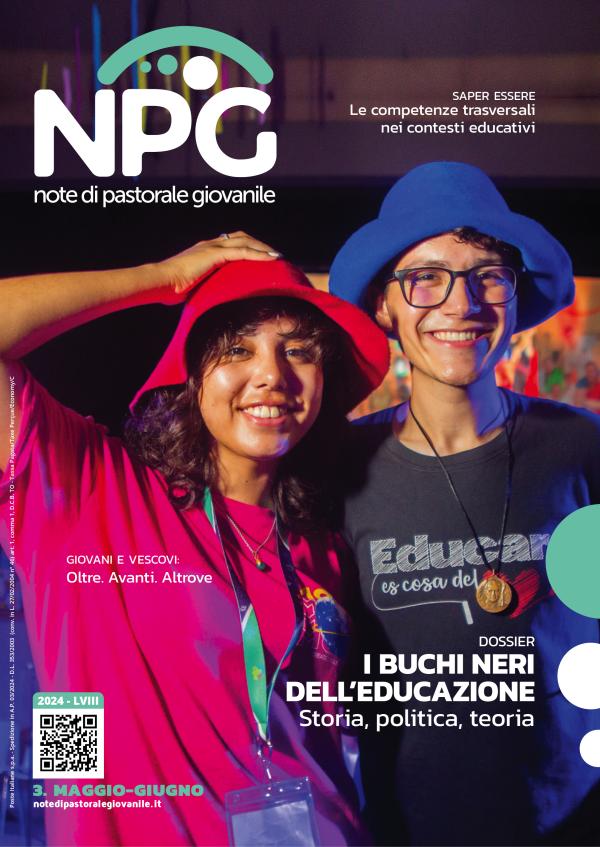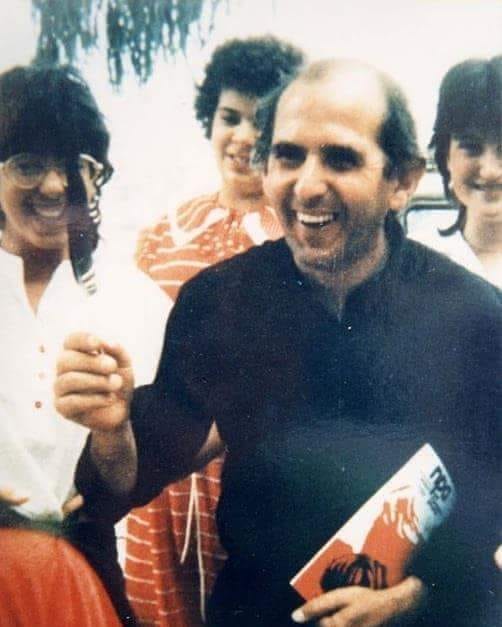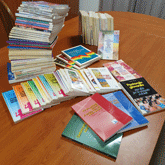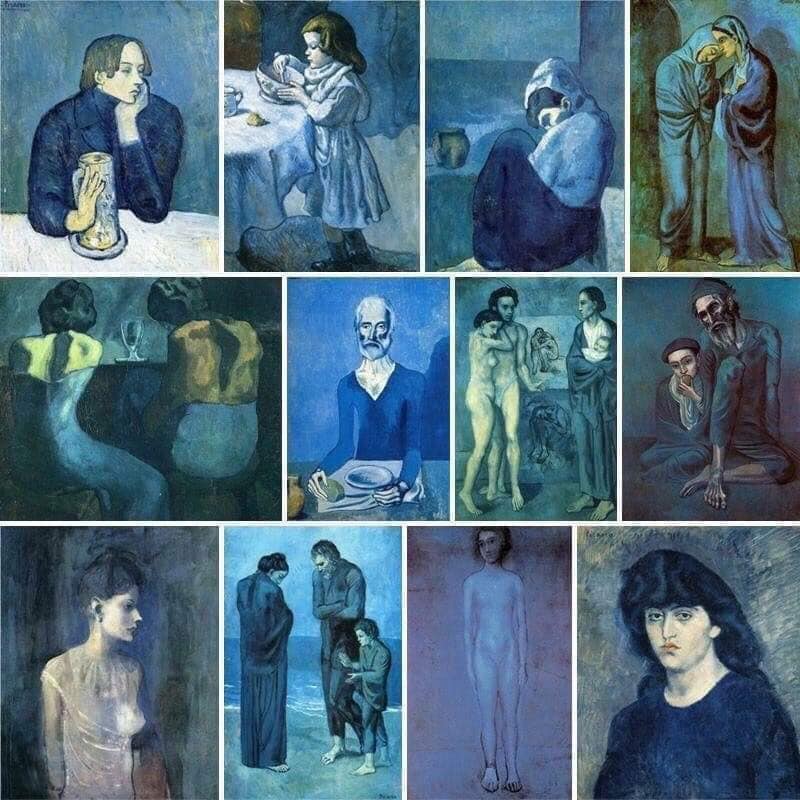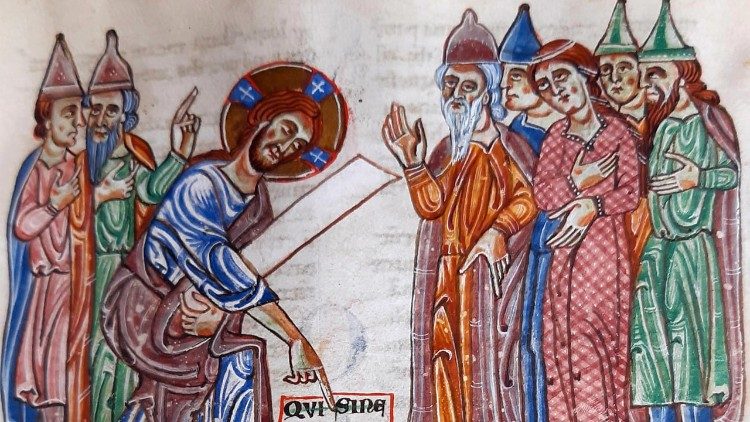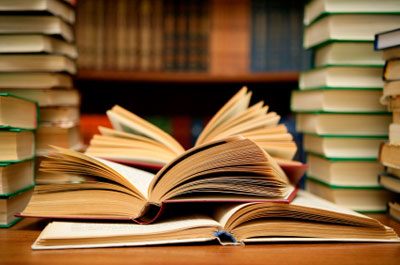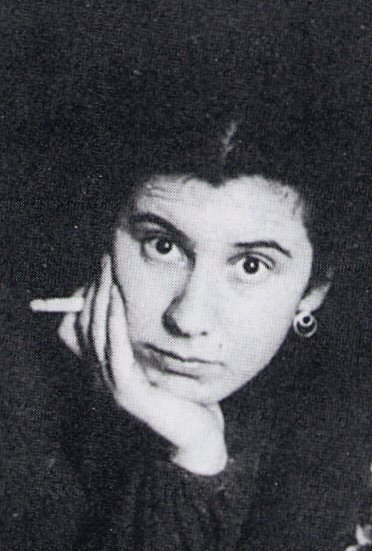Una sintesi a cura di Franco Floris
(NPG 1985-1-57)
IL CREDO DELL'ANIMATORE
1. Ogni uomo si porta dentro una sua storia. Crede in qualcosa o non crede più a nulla.
Questa «fede» condiziona intensamente la sua lettura del reale e i suoi progetti.
Noi ci sentiamo dentro una storia più grande di noi.
È nostra, ma ci supera e ci convoca.
Raccontiamo con la nostra vita questa storia, perché sogniamo che molti altri amici ritrovino in essa ragioni per vivere, per sperare, per impegnarsi, persino per morire.
Questa storia è la storia della passione di Dio per la vita dell'uomo. Una storia che si chiama Gesù di Nazareth, Maria, Paolo di Tarso, Francesco d'Assisi, don Bosco, Teresa di Calcutta, Franco, Paola, Ivana, Mario, Pietro... tu, io e tanti altri.
2. Trascinati da questa storia, crediamo alla persona di ogni uomo, prima di tutto.
Solo la persona è il nostro grande assoluto.
Sappiamo che viviamo in una situazione di crisi drammatica e complessa.
Sappiamo che la persona è al centro di una trama di relazioni politiche, economiche, culturali, che la condizionano e spesso la soffocano.
Sappiamo che non possiamo ritagliarci un'oasi felice, dove non rimbombino i problemi strutturali.
La storia a cui crediamo e che vogliamo raccontare ci ha convinti però di un fatto: rendere un uomo felice, restituendogli la gioia di vivere, è una piccola cosa nella mischia delle sopraffazioni, degli intrighi, degli sfruttamenti e delle violenze; ma è cosa tanto grande e affascinante, che vale la pena di perdere la propria vita per perseguirla.
3. Per questo crediamo nell'educazione.
E siamo disposti a scommettere sulla sua forza politica e sulla sua capacità di rigenerare l'uomo e la società.
Certo, le ragioni della crisi diffusa sono molte e complesse. Richiedono interventi molteplici e articolati.
Se l'educazione aiuta a vivere e restituisce quel futuro che è spesso defraudato, essa può far uscire dalla crisi.
4. La nostra scommessa per l'educazione non è un'opzione indifferenziata.
Troppo importante è l'uomo e la sua vita, per restare nel generico, facendo finta di ignorare in quanti modelli diversificati abbia preso corpo l'educazione.
Per noi educazione è animazione: l'animazione è lo stile con cui si fa educazione.
L'animazione non è un capitolo dell'educazione: è invece tutto il suo libro.
5. L'animazione è una antropologia. È cioè un modo di pensare all'uomo, ai suoi dinamismi, ai processi in cui gioca la sua maturazione.
Ecco la nostra scommessa sull'uomo, come l'abbiamo scoperta progressivamente nella storia che ci è stata narrata.
Ogni uomo è stato fatto capace di autoliberazione.
Per autoliberarsi è indispensabile assumere una coscienza riflessa e critica di se stesso, della propria storia, degli altri e del mondo.
Questa coscienza riflessa e critica è prodotta, sostenuta, incoraggiata dalla relazione interpersonale e soprattutto da quel modello di relazione educativa e comunicativa che è rappresentato dal rapporto di giovani e adulti.
6. L'animazione è anche un metodo: seleziona le risorse educative disponibili in una istituzione e le organizza scientificamente in un modello di relazione educativa e comunicativa, in una strategia fatta di tempi, di luoghi, di agenti, di processi, di strumentazioni.
La scelta antropologica è una scommessa: richiede il coraggio di credere, magari in solitudine, a determinati valori.
L'animazione come metodo, invece, viene appresa lentamente e faticosamente nelle «scuole di animazione».
7. L'animazione ha come obiettivo ultimo e globale la grande pretesa di restituire ad ogni uomo la gioia di vivere e il coraggio di sperare.
La storia in cui ci siamo trovati immersi, ci ha fatto scoprire in Gesù di Nazaret la ragione ultima, decisiva e irripetibile della nostra vita.
L'animazione tende strutturalmente perciò a far incontrare con il Signore della vita.
Non intendiamo strumentalizzare l'animazione per l'evangelizzazione, perché l'animazione è, come tutti i processi umani, una esperienza che possiede una sua intrinseca dignità e consistenza. Ma per realizzare meglio l'obiettivo dell'animazione, sentiamo il bisogno di testimoniare, con fatti e parole, la buona notizia che Gesù è il Signore.
8. L'animazione come metodo ha un grosso contributo da offrire anche nell'ambito specifico dell'educazione della fede.
Possiamo educare alla fede nello stile dell'animazione.
Lo affermiamo perché la scommessa sull'uomo tipica dell'animazione si porta dentro i germi dell'uomo nuovo che è il credente in Gesù Cristo, e perché le sue scelte metodologiche coincidono con quelle che caratterizzano i processi di educazione della fede esigiti dalla teologia dell'Incarnazione.
Sappiamo bene che educazione e educazione alla fede non sono la stessa cosa.
Esiste perciò un ambito di interventi specifico della fede. In esso l'animazione risulta preziosa ma radicalmente insufficiente. Essa perciò fa spazio all'imprevedibile potenza di Dio, concretizzata nell'azione liturgica e sacramentale della comunità ecclesiale.
9. L'animazione è una funzione che prende il volto concreto e quotidiano di una persona: l'animatore.
L'animatore è l'animazione in azione.
Animando, egli racconta la sua storia, perché altri come lui ritrovino la capacità di dare tutto di sé perché la vita si allarghi oltre i confini della morte.
Per fare questo, l'animatore si qualifica: studia, si prepara, esperimenta e verifica.
L'animatore è un tecnico.
Egli crede ad un progetto di vita; nel suo lavoro lo fa emergere continuamente.
È quindi un militante.
L'animazione è l'animatore, tecnico e militante nello stesso tempo.
Due parole come premessa
Se ci si guarda attorno, nel panorama delle istituzioni educative ecclesiali, un fatto «nuovo» risalta evidente: il diffondersi e il moltiplicarsi di scuole, corsi, settimane per la formazione degli animatori. C'è molta fiducia e molta speranza in questa nuova figura ecclesiale, quasi l'intuizione che la presenza dell'animatore nei gruppi e nelle realtà di base possa ridare voglia di camminare e di agire.
Le stesse istituzioni si sentono così sollecitate a ripensare il loro servizio ai giovani come intervento organico alla luce di un progetto che è appunto di «animazione» e che l'animatore assume e quasi incarna.
Si è così assistito a un duplice cammino convergente: da una parte gli animatori (che da tempo - magari senza troppi «riconoscimenti» - si danno da fare per far camminare il loro gruppo) sentono il bisogno di una preparazione solida e seria, per non sentirsi buttati allo sbaraglio, e si rivolgono alle «scuole» per una preparazione più adeguata; dall'altra le scuole che un po' dappertutto sorgono come aiuto, magari solo volute e imposte da qualcuno che ci crede, si organizzano sempre meglio ed escono dalla fase della prima sperimentazione, si sentono spinte a elaborare «curriculum» formativi per coloro appunto che intendono essere segno dell'amore della Chiesa per i giovani e con i giovani.
La rivista «Note di pastorale giovanile» da anni ha fatto propria la scelta dell'animazione culturale nell'educazione umana e cristiana dei giovani, non solo attraverso la rubrica «Formazione degli animatori», ma anche attraverso la piattaforma di idee offerta dai dossier e le concretizzazioni offerte dalle esperienze e dei sussidi.
Anzi, essa ha curato una serie di 20 quaderni (appunto, i «quaderni dell'animatore») con l'offerta di materiali per le scuole di animazione, centrati attorno ai cinque interrogativi di fondo:
- chi? (la persona dell'animatore);
- a chi? (i giovani destinatari);
- che cosa? (i contenuti educativi);
- come? (gli strumenti e le tecniche);
- perché? (restituire a ogni uomo la gioia di vivere e il coraggio di sperare, fino a incontrarsi con il Signore della vita).
Questi quaderni sono da tempo esauriti, sostituiti da una serie di libri (pubblicati dalla Elle Di Ci) che vogliono offrire un quadro di fondo organico e non troppo specialistico.
Pensiamo tuttavia utile ristampare in un libretto a parte il famoso «Q20», una specie di sintesi di base che offre fin dall'inizio il quadro generale, all'interno del quale i singoli nuovi contenuti trovano posto e significato.
Non è un contributo alla pigrizia o una scorciatoia rispetto allo studio e all'impegno di riflessione e assimilazione: pensiamo tuttavia che il quadro vada offerto «prima», piuttosto che faticosamente ricostruirlo alla fine.
L'esperienza di tanti anni di scuola ci ha confermati in questa supposizione; e la richiesta di tanti animatori che si cimentano in questo cammino va appunto in questo senso.
Abbiamo lasciato i riferimenti agli altri quaderni (dall'1 al 19) Per chi volesse, qualcuno può ancora essere rintracciato al «Centro salesiano pastorale giovanile» via Marsala 42 00185 Roma). Essi danno un 'idea dell'intreccio e della collocazione dei singoli temi, l'organicità di una proposta.
Prima di presentarla in una sintesi globale e discorsiva, accenniamo ad alcune «precomprensioni» di fondo, che costituiscono quasi «lo stile» dell'animazione stessa.
Di queste precomprensioni, spesso non dichiarate, ne vogliamo sottolineare alcune;
- l'attenzione ai giovani come «generazione della vita quotidiana»,
- l'educazione come modo per riattivare la comunicazione tra giovani e cultura a partire dalla valorizzazione dell'esistente,
- il proporre un cammino di fede che esalta l'amore alla vita come luogo in cui riconoscere il Signore della vita,
- il gruppo giovanile come spazio privilegiato di animazione ed esperienza cristiana,
- il ripensare le proposte di educazione ed evangelizzazione in una logica ermeneutica.
Ma ecco l'articolazione del quaderno.
Nella prima parte vengono evidenziate attorno a cinque «scommesse» le precomprensioni di fondo del nostro progetto.
Nella seconda parte vengono offerti in sintesi quattro grandi temi dell'animazione, così come sono stati presentati nei «quaderni»: l'analisi della condizione giovanile, la proposta dell'animazione culturale, l'educazione alla fede nello stile dell'animazione, la figura dell'animatore.
Nella terza parte, più diffusa delle altre, si parla del metodo, raccogliendolo attorno ai seguenti nuclei:
- un modo di accostarsi ed accogliere i giovani;
- un modo «educativo» di intervenire nel mondo giovanile;
- il gruppo come luogo privilegiato di animazione;
- l'esperienza come «unità di lavoro» dell'animazione;
- gli strumenti dell'animazione.
1. LE SCOMMESSE DELL'ANIMAZIONE
Il quaderno prende avvio da due esigenze.
La prima: esigenza di una rilettura d'insieme del cammino svolto nei quaderni alla ricerca dei fili sotterranei che li collegano. Lo faremo dando risposta ai cinque interrogativi sollevati nel Q1 al momento di presentare il progetto.
La seconda: esigenza di presentare un quadro organico, anche se per forza di cose veloce, sul metodo dell'animazione perché nei precedenti quaderni tale sintesi non ha avuto luogo.
* Perché fare animazione? (Q1, 1-3)
Raccoglieremo la risposta a questo interrogativo attorno a cinque «scommesse», del resto già dichiarate con altro linguaggio nel «credo dell'animatore».
* Che cosa è e propone l'animazione? (Q5-6)
La risposta viene data in due tempi:
- alla luce delle «coordinate culturali» che caratterizzano la nostra proposta, vengono evidenziati l'obiettivo generale e le tre aree di intervento per un'animazione dei giovani che si qualifichi come «culturale»;
- alla luce della teologia dell'Incarnazione e degli stimoli dell'animazione culturale vengono evidenziati la logica educativa, l'obiettivo generale e l'itinerario di una educazione alla fede dei giovani.
* A chi si rivolge l'animazione? (Q7-8 e Q 9-11)
La risposta viene data rileggendo i quaderni della seconda serie, alla ricerca delle principali categorie per leggere l'attuale momento culturale e la condizione giovanile.
* Chi fa animazione? (Q1-4)
Viene infine precisata la identità personale dell'animatore ad un duplice livello: il livello del cammino umano che l'animatore è chiamato a fare e il livello della sua spiritualità.
* Come fare animazione? (Q16-19)
A questo interrogativo hanno risposto i quaderni della quarta serie approfondendo alcuni ambiti del metodo dell'animazione, come: cosa è gruppo, la relazione fra animatore e gruppo, il gruppo nella chiesa e nel territorio, la programmazione educativa.
Nonostante tali contributi il discorso sul metodo è rimasto un poco frammentario. Nelle pagine che seguono si cerca di riorganizzare, raccogliendo gli stimoli dei vari quaderni ed integrandoli con altri, una riflessione d'insieme sul metodo. Anche se, come si vedrà, neppure questa sintesi è sufficiente. Ulteriori approfondimenti sono necessari.
La nostra ricerca non è stata (posto che fosse possibile) neutrale, ma orientata fin dall'inizio da una serie di precomprensioni o scommesse.
Non avevamo, in altre parole, solo delle attese, dei bisogni o dei problemi, ma anche alcuni «postulati» a partire dai quali muoverci. Come ogni postulato, anche le nostre precomprensioni o scommesse non sono del tutto dimostrabili. Esse si offrono, con una originale evidenza, e richiedono l'accettazione (o meno) per andare oltre. Indimostrabile, tuttavia, non vuol dire «campato per aria» o senza senso, ma invece che richiede un'adesione che è un «rischio calcolato».
Quali sono dunque le nostre precomprensioni? (Q1, 1-3)
Le abbiamo dichiarate fin dal principio nel «credo dell'animatore». Esse sono riconducibili a cinque.
1.1. PRIMA SCOMMESSA: CREDIAMO NELLA «PASSIONE DI DIO» PER L'UOMO
La prima precomprensione nasce dall'esperienza cristiana in cui ci muoviamo. Lo dicevamo nel «credo»: «Noi ci sentiamo dentro una storia più grande di noi. È nostra ma ci supera e ci convoca. Raccontiamo con la nostra vita questa storia, perché sogniamo che altri amici ritrovino in essa ragione per vivere, per sperare, per impegnarsi, persino per morire. Questa è la storia per la passione di Dio per la vita dell'uomo. Una storia che si chiama Gesù di Nazareth» (Q1, 1).
La fede cristiana non ha solo ispirato la nostra ricerca ma l'ha anche orientata: ci preoccupiamo dell'uomo e «crediamo» nell'uomo, perché «la passione di Dio per l'uomo» ci ha convinti della grandezza dell'essere uomo, della sua grande e misteriosa dignità, del suo valore «religioso». Rivolgerci all'uomo è per noi condivisione della passione di Dio per l'uomo, della «salvezza» di Dio all'uomo in Gesù di Nazareth. «Una cosa si coglie con chiarezza (in Gesù): la sua condizione di uomo appassionato per una causa... la sua figura di uomo che ha consegnato tutto ciò che aveva, tutte le sue energie - corporali, psichiche, intellettuali, spirituali, ecc. - al servizio di questa causa» (Q3, 5-8).
Qual è in concreto questa causa? «Per Gesù il Regno di Dio equivale alla pienezza di vita degli uomini, di ogni singolo uomo e dell'umanità intera». (Q3, 8)
La pienezza di vita non va intesa in senso riduttivo. Gesù non la circoscrive ai soli aspetti cosiddetti spirituali, quali per esempio il perdono dei peccati, ma la apre anche agli aspetti materiali, come la guarigione del corpo. E nemmeno la limita alle sole dimensioni individuali, ma la estende pure ai rapporti interpersonali e sociali. Ancora, benché parli di una realizzazione futura e piena del Regno, con le sue parole e le sue azioni lo anticipa già parzialmente al presente.
La passione per l'uomo e per la sua pienezza di vita in Gesù non si limita a guarire i malati. Egli annuncia a tutti la «buona novella». Senza questo «messaggio» non si comprende Gesù (Q3, 10-11).
Tuttavia il suo non è un generico «messaggio». Esso infatti «viene incontro all'aspirazione più profonda e radicale di ogni essere umano, individuale e collettivo, l'aspirazione cioè a vivere e a vivere in pienezza, con un'esperienza degna di questo nome» (Q3, 10). L'annuncio di Gesù viene a dire che «tale aspirazione non è né assurda né vana, ma piena di senso; e che essa non è destinata a risolversi definitivamente nel nulla, ma viceversa può avere - se l'uomo stesso lo vuole - una risposta positiva. E tutto ciò perché Dio, il Dio Vivente, è interessato a garantirne la realizzazione» (Q3, 10).
Noi riconosciamo di essere raggiunti da questa esperienza esaltante. La passione di Dio per l'uomo è giunta fino a noi e ci ha coinvolti fino a convincerci che l'unico modo serio di vivere è fare nostra la sua causa.
A servizio del Regno di Dio come pienezza di vita fra gli uomini, ecco la prima scommessa alla base della nostra ricerca sull'animazione dei giovani.
1.2. SECONDA SCOMMESSA: CREDIAMO NELL'EDUCAZIONE
La seconda scommessa alla base dei quaderni è che oggi val la pena dedicarsi all'educazione delle nuove generazioni.
Oggi più di ieri, in un certo senso.
Dal punto di vista dell'orizzonte in cui collochiamo questa scommessa, educare i giovani è, a nostro avviso, un modo originale di servire oggi la causa del Regno di Dio.
Intendiamo il termine «educare» in senso stretto, come insieme delle attività che gli adulti in modo intenzionale e metodico organizzano per la formazione dei giovani. Proprio questa attività ci sembra un modo profetico di accrescere la pienezza di vita fra gli uomini (Q1, 21-24).
Dal punto di vista invece della società e dei giovani, fare l'educatore oggi è accettare una grande sfida.
Questa sfida la si coglie per intero se si tiene conto della attuale situazione dei giovani nella società. Condividiamo quello che ha scritto G. Milanesi nel Q12: «vivere da giovani nella società italiana è difficile» (Q12, 13). I giovani sono oggettivamente costretti a vivere nella precarietà, subire pesanti condizionamenti economici, culturali, familiari, sociali e politici. Sono costretti a convivere con una prospettiva di vita limitata, che taglia le ali all'utopia e rimette continuamente i sogni nel cassetto in attesa di tempi migliori che non giungono mai (Q12, 3-9).
Del resto la capacità dei giovani di reagire alla situazione non sembra molta. Sembra piuttosto prevalere una accettazione passiva della emarginazione, una scarsa capacità di innovazione culturale e politica, un modo frammentato di organizzare la propria esistenza (Q12, 13-17).
In questa situazione abbiamo colto una «sfida» come uomini e come cristiani. Senza nutrire, sia chiaro, false illusioni. Ci rendiamo conto che l'educazione è sempre uno strumento «povero», rispetto ai tanti problemi dei giovani. Con lo stesso Milanesi riconosciamo che i giovani potranno essere «protagonisti» solo a condizione di un netto miglioramento del quadro strutturale - e dunque economico, politico e culturale - della società italiana. Tuttavia crediamo che questo sarebbe insufficiente se insieme non si lavorasse per una nuova coscientizzazione ed educazione dei giovani (Q12, 17).
Ecco allora la nostra scelta: consapevoli che l'educazione non risolve affatto tutti i problemi dei giovani, sottolineiamo che può dar loro un apporto notevole: aiutarli a ritrovare il coraggio di vivere, convincerli che val la pena di vivere e che ogni situazione è, in qualche modo, redimibile.
1.3. TERZA SCOMMESSA: CREDIAMO NELL'ANIMAZIONE
«La nostra scommessa per l'educazione non è un'opzione indifferente. Troppo importante è l'uomo e la sua vita, per restare nel generico, facendo finta di ignorare in quanti modelli diversificati abbia preso corpo l'educazione. Per noi educazione è animazione: l'animazione è lo stile con cui si fa educazione. L'animazione non è un capitolo dell'educazione: è invece tutto il suo libro» (Q1, 2).
L'animazione è la terza grande scommessa del nostro progetto.
Mentre rimandiamo ai Q5/6 per una descrizione compiuta di cosa si intenda per animazione, sottolineiamo che non si deve pensare l'animazione come una attività a sé stante, a fianco di altre attività umane, ma piuttosto una «qualità», quella che possiedono molte «azioni umane connesse all'azione di dare, conservare, sviluppare la vita, nella sua dimensione individuale e sociale, materiale e spirituale» (Q5, 7).
Dire che le attività umane possono essere «animate» è allora «scommettere» che la vita, la libertà, l'amore possono redimere, compenetrandola, qualsiasi situazione umana: è scommettere che, nonostante lo scacco ed il fallimento, l'uomo può sempre «onorare la vita». In ogni situazione (Q5, 10).
Tale scommessa l'animazione la esprime in un atteggiamento globale che possiamo dire di «amore per la vita», ed in particolare la esprime in un atteggiamento fiducioso verso la cultura, verso le nuove generazioni, verso l'educazione.
* Fiducia anzitutto verso la cultura, in quanto luogo in cui l'uomo accoglie e costruisce la sua avventura di senso nella storia.
Questa fiducia, che è tutt'altro che accettazione supina e passiva di tutti i prodotti culturali, l'animazione la vuole giocare con forza nell'attuale crisi culturale, affermando che anche oggi l'uomo è in grado di dare alle sue azioni il sapore della vita (Q5, 20 ss). Una fiducia del resto «sotto condizione»; l'esito non è garantito, ma frutto di scelte culturali precise, come la riscoperta dell'uomo nella sua complessità, il riaggancio della ricerca odierna alla tradizione e alle radici culturali, la riconquista del linguaggio umano in tutta la sua ricchezza, il rispetto del pluralismo ma senza cadere in comodi irenismi, la valorizzazione di tutti i soggetti culturali, la capacità di riesprimere in forme culturali nuove i valori di fondo della cultura, attraverso processi ermeneutici attenti al «già fatto» ma in vista del «da fare» e dunque dell'inespresso della cultura.
* Fiducia poi nell'educazione come animazione.
L'animazione rifiuta modelli educativi puramente induttivi (o maieutici), come pure modelli educativi di tipo autoritario (Q5, 8). Presentare l'educazione come un semplice decondizionare dalle influenze della società, un liberare le energie recondite nelle nuove generazioni, un pensare all'animatore come ad un giardiniere che guarda sorpreso la piantina appena nata, la protegge e la innaffia con cura, è una concezione povera di educazione.
Non meno povera è una concezione che vede nel passato, nella tradizione, la fonte di ogni sapere e verità, e cerca i metodi meno indolori - magari contrabbandandoli per animazione - per «far passare» tali vecchi contenuti.
Positivamente l'animazione è invece modello educativo basato sullo scambio tra generazioni, regolato da alcuni criteri (Q5, 9-10).
Il primo è che le nuove generazioni devono apprendere, prima che gli stessi contenuti di una cultura, gli strumenti per apprendere e i linguaggi per comprendere tale cultura. Se non si possiedono gli strumenti (e acquisirli è fatica e studio) non si può affatto dialogare tra generazioni (Q5, 21).
Il secondo criterio è che i contenuti della tradizione vanno appresi attraverso un procedimento ermeneutico in cui entrano in reazione circolare attese, intuizioni e problemi delle nuove generazioni, con valori, concezioni di vita, atteggiamenti della cultura (Q5, 23). Per ritornare all'immagine della pianta, l'animazione vede l'educazione come «innesto» che utilizza le energie della pianta ma le orienta su una precisa direzione: produrre frutti buoni. In questo modo non solo si valorizza il passato ed il presente, ma anche si pongono le basi per il futuro della società e della cultura (Q7, 16-17).
1.4. QUARTA SCOMMESSA: CREDIAMO NELL'ANIMAZIONE PER EDUCARE ALLA FEDE
L'animazione si propone, lo si è visto, di «restituire ad ogni uomo la gioia di vivere e il coraggio di sperare» (Q1, 2).
Su questo obiettivo occorre soffermarci un attimo per sottolineare che restituendo la «gioia di vivere» alle nuove generazioni, l'animazione tende strutturalmente ad allargare gli spazi della vita contro gli spazi di morte; in altre parole, a consolidare il Regno di Dio nella storia. Non solo; indirettamente ma oggettivamente l'animazione tende a far incontrare le nuove generazioni con il Signore della vita.
Come credenti non ci basta però un incontro con Dio sul piano del modo globale di vivere la vita. Certo è un grande obiettivo abilitare i giovani ad «amare la vita», ma non basta per mettere la parola fine alla voglia di comunicare ai giovani la ricchezza della vita. In noi si fa intenso l'imperativo di annunciare ai giovani la «buona notizia che Gesù è il Signore» (Q7, 4 ss).
A questo punto ci siamo posti la domanda: cosa vuol dire educare alla fede, e come? La domanda ne genera infatti, e subito, delle altre: ma si può educare alla fede? non è forse la fede dono di Dio? e, posto che si possa educare alla fede, quale «pedagogia» è in grado di educare alla fede?
Nel rispondere a questa domanda siamo arrivati ad alcune affermazioni. Le riportiamo (Q7, 13).
Certo non si dà educazione diretta e immediata alla fede, che rimane dono gratuito di Dio, frutto del dialogo misterioso tra Dio e l'uomo nell'intimità dell'esistenza personale. Ma questo incontro nell'intimità dell'esistenza è «servito, sostenuto, condizionato dalle mediazioni umane che hanno la funzione di attivare il dialogo e predisporre all'accoglienza». Le mediazioni pastorali hanno dunque una funzione molto importante: senza di esse (normalmente) non si realizza il processo di salvezza.
Di conseguenza parliamo di una precisa «educabilità della fede» e intendiamo «educazione» nel significato tecnico sollecitato dalle scienze dell'educazione.
Quale stile educativo è allora capace di garantire la riuscita di questo originale «scambio tra giovani e fede»?
A nostro avviso, l'animazione rappresenta il modello educativo ideale per realizzare le esigenze che scaturiscono dalla dimensione educabile della fede (Q7, 14).
Quali esigenze? Accenniamo velocemente:
- la dignità assoluta e il mistero di ogni persona;
- il riconoscimento della presenza dello Spirito in ogni persona;
- l'affermazione che non c'è crescita della persona se questa non viene «innestata» nella tradizione culturale e religiosa;
- l'affermazione che la crescita della persona e del Regno di Dio è frutto sempre della «collaborazione» tra l'uomo e Dio;
- la presenza di «adulti» come testimoni di un'esperienza irriducibile alla ricerca dei singoli soggetti.
Tutte queste esigenze si ritrovano e vengono esaltate da processi educativi ispirati all'animazione.
Per questo, l'animazione è strumento privilegiato non solo per educare, ma anche per intervenire nell'educazione alla fede.
1.5. QUINTA SCOMMESSA: CREDIAMO NEGLI ANIMATORI
Il nostro progetto ha una pretesa: sollecitare uomini e donne ad assumere un compito ed un ruolo dentro la società e dentro la chiesa: animatore. «Animazione dice animatore, una persona concreta». «L'animatore è l'animazione in azione» (Q1, 3).
Crediamo che, all'attuale momento sociale ed ecclesiale, i giovani abbiano bisogno di educatori che vivano la loro funzione nello stile di animazione.
Più in concreto ecco le nostre attese.
Nell'attuale crisi sociale ed ecclesiale, i giovani lanciano una «sfida silenziosa». Ci vuole qualcuno che la raccolga in prima persona, anche se a nome di tutta la società e della chiesa, e si dedichi, come volontario (e dunque nel tempo libero dal lavoro) o come professione (e dunque a tempo pieno), all'animazione dei giovani.
Questi animatori non li pensiamo «cani sciolti», ma «ponte» consolidato, attraverso il loro inserimento in strutture e comunità educative, tra i giovani da una parte e società-chiesa dall'altra (Q18, 4-11).
Essi hanno dunque una doppia funzione animatrice: verso i giovani e con i giovani, verso e con la società-chiesa. Nei loro confronti si fanno portatori non di una generica solidarietà, ma di «progetti», elaborati con competenza e professionalità, di animazione culturale e proposta di fede alle nuove generazioni.
Ci rendiamo conto che questa figura ha oggi dei contorni molto sfumati e, a volte, confusi. Intendiamo lavorare per un suo consolidamento e riconoscimento sociale ed ecclesiale.
A questi animatori chiediamo competenza e testimonianza. Con altre parole, per noi l'animatore è un tecnico-militante (Q1, 3).
Parliamo di militanza per sottolineare che l'animatore si sente a servizio di una causa per la quale intende dare se stesso. Non è un compito facile: richiede coraggio di credere, magari in solitudine, a determinati valori, a un progetto di vita.
La militanza è un fatto di testimonianza: di valori culturali e di esperienza cristiana, di passione per l'uomo e la vita, e di confessione che Gesù è il Signore della vita, e che dunque la vita non è una «passione inutile»...
D'altra parte l'animatore è per noi un tecnico, un «professionista» dell'animazione. Animazione non è spontaneismo o buona volontà, ma uno stile educativo che va sperimentato nell'azione concreta a fianco di altri animatori, studiato nelle «scuole di animazione», ripensato mentre si fa animazione per «apprendere dall'esperienza». Noi crediamo ad un animatore che si qualifica: per questo è un tecnico (cf NPG 1/84: "Una scuola per la formazione degli animatori").
2. LA PROPOSTA EDUCATIVA DELL'ANIMAZIONE CULTURALE
Presentando le cinque scommesse abbiamo risposto ad una delle cinque domande iniziali: perché fare animazione?
Nelle pagine che seguono, a volte in modo sintetico a volte in modo più diffuso, offriamo una risposta alle domande: a chi fare animazione?, che cosa propone l'animazione?, chi fa animazione? Rimandiamo al capitolo seguente la risposta al come fare animazione.
2.1. ALCUNI NODI NELLA LETTURA DELLA CONDIZIONE GIOVANILE
«A chi si rivolge l'animazione?». I quaderni hanno offerto una lettura della realtà sociale e giovanile, sottolineando più volte che si trattava di una lettura scientifica in uno «sguardo educativo» che tutto filtra dal punto di vista della crescita delle persone (Q1, 27).
Vediamo i nodi principali della situazione, facendo riferimento ai quaderni della seconda serie.
Alcune riflessioni riguardano l'analisi della società e della cultura (Q12-15).
Ecco alcune affermazioni chiave.
Riconosciamo di attraversare un'epoca caratterizzata dal cosiddetto «tramonto delle ideologie (in particolare l'ideologia del progresso e quella del cambio sociale), dalla crisi del quadro di insieme di idee e valori che permettevano al singolo di sentirsi rassicurato circa il senso della vita e della storia, dalla faticosa ricerca di nuove strade per uscire dalla crisi valorizzando soprattutto alcune istanze legate alla soggettività personale e alle rivendicazioni dei bisogni del soggetto (Q14, 3 ss). Ad esempio: le istanze della individualità e dell'interiorità personale o delle relazioni interpersonali e amicali, rispetto all'invadenza del pubblico, del politico, dell'ideologico o del cosiddetto oggettivismo scientifico; oppure le istanze del mondo emozionale e inconscio, rispetto ad una rigida e astorica supremazia di una coscienza e di una razionalità troppo «chiare e distinte», fonti e vittima, allo stesso tempo, di spinte ambientali, repressive e antiemancipatorie (Q14, 7).
Il nodo centrale della crisi, vista dal punto di vista della soggettività personale, sembra essere la perdita della identità storico culturale, cioè del radicamento del singolo in una cultura che gli dia vita (Q5, 12-13).
Il risultato è un «uomo indifeso rispetto all'angoscia che la vita provoca al di là delle apparenze di felicità. Indifeso perché si ritrova come un naufrago abbandonato in un territorio, in un'isola ricchissima, ma priva di segni leggibili di vita umana». L'uomo, di conseguenza, è spesso incapace di «fornire una profonda e duratura collocazione in un orizzonte di senso, che aiuti a capire se stessi e la propria esistenza al di là dei limiti e dei confini dell'oggi».
Assistiamo così, soprattutto nei giovani ma non solo in loro, ad una sorta di nichilismo di corto respiro, pratico, di debole intensità (Q13, 15), che si manifesta come attaccamento alla concretezza della vita ma insieme come incapacità di riconoscerle un vero senso (Q14, 9-13). «Il quotidiano è visto come luogo di banalità da accettare con spirito di sacrificio e di adattamento, senza entusiasmo, sperando che un giorno una vita sommamente più ricca possa irrompere all'improvviso salvando dalla routine» (Q7, 7).
Alcune espressioni di questa crisi del senso è facile rintracciarle nel modo di vivere dei giovani. Sottolineiamo soltanto alcuni atteggiamenti, mentre rimandiamo ad una lettura attenta del Q12 e del Q13:
- un certo eclettismo culturale, frutto di un «adattarsi» alla situazione attuale che non è tanto di pluralismo quanto di confusione culturale (Q12, 8-9);
- una crisi della progettualità e dell'investimento consapevole sul futuro: si vive nel presente ed in un presente frammentario (Q13, 14-16);
- il frequente chiudersi nel soddisfacimento dei bisogni immediatamente percepiti dal soggetto, senza un confronto critico con i valori, abbandonandosi al «primato del fare esperienza» su ogni altro criterio di azione (Q14, 11-12; Q13, 19);
- un'aggregarsi prevalentemente tra pari e coetanei e un impoverimento del rapporto con le generazioni che li hanno preceduti, anche se spesso nascosto da una tolleranza relazionale che rassicura gli adulti e in particolare la famiglia (Q15, 5-9; Q5, 15-17; Q13, 19-22)
Si potrebbe continuare, ma è più corretto rimandare ai quaderni per non rischiare sottolineature parziali.
Prima di passare oltre tuttavia, è necessario rimarcare che l'animazione non si limita ad una lettura «in negativo» come quella ora accennata, ma va oltre per vedere nell'attuale momento culturale anche dei precisi segnali di apertura ad un modo di vivere che faccia realisticamente i conti con la crisi ma non si adagi ad essa (Q1, 27-28).
La lettura che l'animazione fa della situazione è una lettura spesso dura e critica, ma non per questo senza speranza. Valorizza invece i segnali di novità come luogo da cui cominciare il cammino educativo. Ritorneremo su questo quando parleremo della «accoglienza» nel capitolo sul metodo.
2.2. COORDINATE CULTURALI E OBIETTIVI DELL'ANIMAZIONE
A questi problemi l'animazione risponde con una sua proposta culturale ed educativa. Siamo al che cosa propone l'animazione.
Vediamo successivamente:
- le coordinate culturali che qualificano la nostra riflessione;
- l'obiettivo generale per l'animazione dei giovani oggi;
- tre aree strategiche di intervento per raggiungere l'obiettivo.
2.2.1. Le coordinate culturali
L'animazione è, come si è detto in precedenza, una sorta di «filosofia della vita» fondata sulla scommessa che, nonostante tutto, per ogni soggetto «val la pena vivere». L'animazione fa sua una filosofia dell'amore alla vita.
Che i giovani possano arrivare a questo non è tuttavia per l'animazione un dato ovvio. Richiede invece una metodica e intenzionale attività educativa che si qualifichi per la scoperta (o riscoperta) di tre grandi coordinate culturali (Q5, 20-27). Senza di esse una attività anche educativa non può dirsi ancora di animazione in senso stretto, in quanto rischia di non sviluppare a fondo l'amore alla vita (Q6, 3-5).
Vediamo dunque le tre coordinate.
La cultura come organismo vivente
La prima è la riscoperta della cultura come un «organismo vivente» e del linguaggio come luogo prioritario in cui la cultura si esprime e vive, si comunica e si trasforma (Q5, 20-23).
Dire che la cultura è un organismo vivente è dire che è un soggetto in evoluzione, dotato della possibilità di lasciar cadere alcuni elementi e di assumerne altri capaci di dare nuova vita allo stesso organismo.
Il meccanismo attraverso cui questo avviene è la comunicazione tra parti, funzioni, gruppi all'interno della cultura. Senza un buon livello di comunicazione la vita non circola nella cultura, la quale pertanto è attenta, da una parte, a coordinare le varie funzioni perché si sentano parte di un tutto e, dall'altra, a rispettare lo specifico, l'originalità delle singole parti, funzioni, oggetti culturali.
Perché uno possa prendere parte alla comunicazione dentro la cultura e possa di conseguenza dare vita anche a se stesso (e dunque maturare una identità culturale) è indispensabile che apprenda la lingua della cultura in cui vive, rendendosi competente sia nel linguaggio logico-razionale, sia in quello simbolico-evocativo. Apprendere la lingua è indispensabile non solo per inserirsi nella cultura e maturare la propria identità come «identità culturale», ma anche per sollecitare la cultura ad esprimere nuove forme e stili di vita.
L'uomo come sistema complesso e aperto
La seconda coordinata è quella dell'uomo come sistema complesso e aperto (Q5, 24-27).
Parlare di sistema è parlare di un tutto in cui interagiscono delle parti la cui vita è inscindibile da quella del tutto. Un esempio è già quello della cultura e delle diverse funzioni al suo interno.
Il concetto di sistema, oltre che alla cultura nel suo insieme, l'animazione lo applica alla crescita del soggetto.
Da una parte denuncia tutte le antropologie e pedagogie che «sezionano» il soggetto, separando l'intelligenza dal sentimento o la corporeità dalla fantasia. Per l'animazione il soggetto va sempre considerato come un tutto.
A due titoli.
Anzitutto rispetto alla complessità interna del soggetto: ogni intervento educativo deve fare attenzione al fatto che riguarda il giovane nel suo insieme. Un intervento in un ambito specifico, ad esempio intellettuale, non può non avere riflessi su tutta la vita del soggetto.
In secondo luogo rispetto alla complessità «ambientale»: il soggetto è sempre parte di un sistema territoriale, familiare, sociale... Ogni intervento educativo deve mirare a cambiare non solo il singolo ma i vari sistemi di cui il soggetto fa parte.
Da questo punto di vista l'animazione è una proposta educativa di tipo politico.
Il sistema uomo, oltre che un sistema complesso, è un sistema aperto, in quanto continuamente scambia energia e informazione con altri sistemi.
Come per tutti i sistemi aperti non vale il principio del determinismo (= ad una data causa corrisponde sempre un determinato effetto) ma il principio della equifinalità (= ad una causa possono corrispondere diversi effetti; mentre lo stesso effetto può essere raggiunto ponendo in atto cause diverse tra loro).
Nel parlare dell'uomo come sistema aperto l'animazione culturale sottopone agli educatori due considerazioni.
La prima è che, in fondo, il risultato del lavoro educativo è sempre imprevedibile e quindi non va mai misurato con criteri efficientistici. La seconda è che il giovane, anche quello di oggi, ha sempre un margine non indifferente di libertà e di scelta, e quindi di responsabilità. Neppure i giovani d'oggi sono del tutto «programmati». In nessuna occasione.
Il legame profondo dell'uomo con la trascendenza
La terza coordinata è il riconoscimento del legame profondo dell'uomo con la trascendenza, e quindi la necessità di abilitare il giovane a vivere attivamente questo legame, riconoscendosi in una fede religiosa, o anche solo in un valore assoluto o in una qualche utopia, che possano costituirsi come punto di vista, oltre l'esperienza quotidiana, da cui imparare a leggere e valutare la vita, e a partire dal quale programmare il futuro personale e collettivo (Q6, 3-5).
Un'identità giovanile che non affondi le radici in una fede, in un valore, in un'utopia che siano criterio ultimo di esistenza, rischia di essere in balìa di se stessa.
L'animazione si oppone a concezioni pedagogiche che emarginano la dimensione religiosa della vita. Ma, d'altra parte, evita di «religiosizzare» la intera esistenza, riconoscendo l'autonomia delle riflessioni e degli strumenti che nei vari ambiti l'uomo utilizza per leggere la realtà, per valutarla, per programmare il futuro.
2.2.2. L'obiettivo generale
Alla luce di queste coordinate antropologiche sono stati individuati progressivamente l'obiettivo generale, le aree di intervento, gli obiettivi intermedi suddivisi nelle aree, per un progetto di animazione giovanile (Q6, 6-9).
L'obiettivo generale è stato indicato in questi termini: «abilitare il giovane a costruire se stesso all'interno dell'avventura di senso che, dall'origine dell'uomo, percorre senza posa il mondo».
L'obiettivo si propone di aiutare il giovane a essere «uomo con» e «uomo per», e dunque di «radicarsi» per «partecipare» (Q6, 6).
«Uomo con, anzitutto. Con gli altri uomini, quelli che prima di lui hanno vissuto e gli altri uomini che dopo di lui vivono.
Con il mondo disegnato dalla natura e dal linguaggio. Con la propria irriducibile solitudine. Con la speranza di ciò che esiste laddove tutto è silenzio.
Uomo per, di conseguenza. Per l'amore che nel mondo si manifesta nell'amore per la vita. Per la povertà che è ricchezza di senso del quotidiano. Per la storia come dono di salvezza dalla caduta avvenuta prima della storia. Per tutto ciò che può scaldare il cuore della utopia» (Q6, 6).
Alcune osservazioni veloci.
Centrare l'obiettivo sulla costruzione dell'identità significa tentare di dare una risposta agli interrogativi sollevati dalla attuale crisi culturale e dalla difficoltà conseguente dei giovani a darsi una identità.
Il giovane può raggiungere una sua identità non in quanto si autocontempla chiudendosi in se stesso, ma in quanto attiva un sempre più intenso «scambio » tra il suo vissuto personale e la cultura che gli offre strumenti, contenuti, punti di vista con cui confrontarsi per provare ad «individuarsi».
Va sottolineato anche il livello a cui l'animazione intende collocarsi rispetto alla costruzione dell'identità. Troppo spesso l'identità viene a essere «risolta» al livello degli strumenti dell'operare, delle norme da osservare, dei ruoli sociali da occupare, delle appartenenze sociali da moltiplicare... Non è sufficiente. Anzi non è neppure possibile: in qualche modo l'identità giovanile nell'attuale situazione rimarrà «frammentata».
L'animazione del resto non è in grado di risolvere un problema di cambio culturale e conseguente crisi di identità di così vasta portata. Il suo è un concreto aiuto piuttosto alle nuove generazioni per sopportare il trasferimento e vivere con una identità «a debole intensità, anche continua».
Tale aiuto o contributo è al livello del «senso della vita», e dunque della riscoperta dell'amore alla vita, al livello dell'essere profondo dell'uomo.
2.2.3. Le tre aree strategiche
Per raggiungere l'obiettivo generale l'animazione individua tre aree di intervento, tra loro in relazione, che sviluppano dimensioni tipiche dello stesso obiettivo generale (Q6, 6-9).
Indichiamo velocemente le tre aree. Ricordiamo soltanto che per ogni area il Q6 offre una serie stimolante di obiettivi intermedi.
Dalla ricerca di soggettività al radicamento culturale
L'animazione si propone, anzitutto, di aiutare i giovani a non rinunciare alla loro ricerca di oggettività, ma a farla crescere radicandola nella cultura «in cui vivono», perché solo in questo modo essi possono dire per intero la loro ricchezza (Q6, 9-15).
Parlare di ricchezza è, per l'animazione, parlare di «mistero di unità nella diversità». Per capire questo è necessario pensare alla situazione dell'attuale cultura in cui diversi modelli e proposte si incrociano e sembrano elidersi.
L'animazione è consapevole di dover fare unità, cioè di dover aiutare il giovane a costruirsi come un «centro esistenziale», ma non a scapito della ricchezza delle forme culturali e dunque del pluralismo che connota la cultura oggi.
La grande pretesa dell'animazione è far crescere dei giovani che sapranno essere se stessi «dialogando» tra i vari ambiti e le varie proposte culturali. Obiettivo è lo sviluppo di un profondo dialogo interiore, tra le diverse esperienze che il giovane vive, per intrecciare un «filo rosso» che le leghi insieme. Questa capacità ha poi a che fare con il «mistero», cioè rimanda il giovane a chiedersi cosa sia la vita in tutto questo effervescente moltiplicarsi di forme culturali, le quali se da una parte possono soffocare il soggetto, dall'altra lo arricchiscono continuamente, a patto che sappia mantenere una unità interiore.
Dalla esperienza di solidarietà alla partecipazione sociale
L'animazione si rende conto della crisi dei modelli di partecipazione, giovanile ma non solo, che sono venuti a tramontare in questi anni, per molti versi perché incapaci di alimentare il vissuto personale dei «militanti» (Q6, 15-20).
L'animazione, prendendone atto, vuole indicare un cammino educativo che abiliti ad una uova partecipazione.
Così formula il suo obiettivo: «abilitare ad una nuova responsabilità e capacità di progettare futuro, in un rinnovato equilibrio tra personale e sociale».
Il punto di partenza è la solidarietà che i giovani sono in grado di sperimentare negli ambiti di gruppi primari, della comunità, della stessa famiglia. In questi ambiti, molto centrati a dimensione relazionale, è possibile attivare processi che conducono alla scoperta di sé senza averne più paura, alla presa di coscienza della «sofferenza» presente nelle situazioni, la disponibilità personale a lottare perché questa sofferenza e le cause che la provocano vengano eliminate.
Lo sperimentare in modo concreto la solidarietà attiva nella sofferenza, accresce poi la capacità di prendersi sempre ulteriori responsabilità, rafforza la continuità, spinge alla collaborane con gli altri, stimola all'analisi delle cause dei problemi, fa prendere atto delle connessioni economiche e politiche di tanta sofferenza dell'uomo, allarga progressivamente gli orizzonti dai piccoli (ma non meno importanti) problemi di solidarietà quotidiana ai grandi problemi dello sviluppo e del sottosviluppo, della fame nel mondo e dello sfruttamento dei popoli...
Dalla invocazione silenziosa al riconoscimento esplicito di una «fede»
Non si parte anche in questo caso dal nulla. L'animazione riconosce infatti nei giovani una «invocazione» diffusa, anche se inconsapevole, di trascendenza, di speranza, di pace, di giustizia. Ma è, spesso, un «segnale debole» da intensificare ed educare (Q6, 21-27).
Se non si dilata questa dimensione dell'esistenza, l'obiettivo generale resta confuso, perché non si dà senso ultimo alla vita se non aprendosi ad una fede o scommessa esistenziale.
In questa direzione l'animazione si propone principalmente di dilatare la gioia e la sofferenza nei giovani. Aiutandoli a far esperienza di gioia e di sofferenza ci si propone di abilitarli a non «accontentarsi» di quanto già vedono e vivono, ma ad «aspettare altro». Un altro tuttavia che si pone su un piano qualitativamente diverso dalle cose che la vita già offre, anche se in quelle stesse cose è sepolto come un tesoro sottoterra.
Per fare questo l'animazione non ha paura di chiedere ai giovani di preservare attivamente gli spazi intimi della persona, quelli di una solitudine che crea distacco dalle cose, dalle persone, da se stessi, non tuttavia per trovare un senso nell'annullamento della realtà, ma per veder in un solo sguardo, lo «sguardo contemplativo», la vita.
Questo sguardo contemplativo, dentro cui si riesce a cogliere l'indicibile della vita, viene acquisito nel momento in cui il giovane si riconosce attivamente in un valore, in una fede, in una utopia e riesce a dar loro un volto, un nome, una consistenza autonoma rispetto alla sua vita personale. Riesce, ai livelli più profondi, a chiamare tutto questo con il nome di Dio che riconosce creatore e Signore della vita.
2.3. L'ANIMAZIONE PER EDUCARE I GIOVANI ALLA FEDE
Il che cosa dei quaderni non si esaurisce con la proposta educativa, ma si apre ad una originale proposta di evangelizzazione delle nuove generazioni.
Tale proposta viene approfondita in alcuni quaderni di cui ora presentiamo i contenuti. Lo faremo tuttavia molto velocemente, tanto per evidenziare il filo sotterraneo che li collega (Q7-11).
2.3.1. L'orizzonte e l'obiettivo generale della evangelizzazione
L'anello di congiunzione tra animazione ed educazione alla fede è il Q7 di Riccardo Tonelli. Importante è come egli imposta il discorso (Q7, 4-13).
Dopo aver riconosciuto l'autonomia dell'animazione culturale, in quanto scienza educativa, dalla teologia pastorale, egli si chiede se l'educazione alla fede possa «utilizzare» l'impostazione e metodologia dell'animazione culturale.
Alla luce della teologia della Incarnazione, la sua risposta è positiva e ne trae tre conseguenze.
La prima conseguenza è che la utilizzazione dell'animazione come stile per educare alla fede richiede di ridefinire il modo stesso di procedere della pastorale giovanile che deve «ricentrarsi», assumendo una «logica educativa» nell'elaborare contenuti, programmi, tappe, cammini... (Q7, 15-26)
In secondo luogo viene a ridefinirsi lo stesso obiettivo generale della educazione alla fede. Tonelli lo presenta come «abilitare i giovani a pronunciare un sì pieno e impegnativo alla propria vita, fino ad accogliere il Signore della vita, celebrandolo nella comunità di coloro che lo confessano come il loro Signore» (Q8, 12).
2.3.2. Un itinerario di educazione alla fede
La terza conseguenza è il ripensamento dell'itinerario di educazione alla fede (Q8, 3-5).
L'itinerario, inteso come l'insieme delle modalità attraverso cui colmare il distacco tra la situazione giovanile e l'obiettivo, si presenta come un cammino di tre fasi al cui interno i giovani vanno abilitati ad alcuni «movimenti» o tappe intermedie. Per motivi di spazio, ci limitiamo ad indicare le tre fasi. Per i movimenti rimandiamo al Q8.
Verso l'invocazione come fondamentale domanda di vita
La prima fase è caratterizzata dall'esigenza di restituire ad ogni persona la propria soggettività, attraverso la percezione delle domande che la investono e la loro canalizzazione nell'esperienza di «invocazione», come verità esistenziale dell'uomo (Q8, 16-18).
Si muove in un'area ancora di «educazione», facendo ricorso all'incontro tra esperienza giovanile e cultura, con tutto ciò che questo comporta di domanda sul senso della vita. Siamo, in altre parole, nell'ambito dell'animazione e della sua terza area di intervento, dedicata alla liberazione della trascendenza dell'uomo.
Verso l'incontro personale con Gesù il Signore della vita
L'invocazione trova molte possibilità di risposta (Q8, 18-23).
I credenti hanno la pretesa di trovare in Gesù Cristo la risposta più piena e determinante. Per questo sentono il bisogno di offrirla, per aiutare a vivere.
In questa seconda fase il giovane, nell'incontro con una comunità credente, riceve una «proposta» che lo interpella e lo provoca ad una scelta. Non è una proposta verbale, ma piuttosto un globale coinvolgimento nell'esperienza della comunità, perché solo al suo interno la proposta di Gesù Cristo può risultare capace di accogliere e saturare l'invocazione verso una ragione «ulteriore» di senso e di vita.
Verso una vita nuova
Al centro di questa terza fase sta il ritorno alla vita quotidiana, una volta che la si è compresa dalla prospettiva di senso espressa nell'evangelo di Gesù (Q8, 24-25).
L'incontro con Gesù è affermazione primordiale che la vita ha senso e lo ha per «offerta-dono» gratuito di Dio. Ne consegue che la crisi di senso non è l'ultima parola sull'oggi, ma che al contrario «la crisi non può essere assunta fino in fondo, lì dove essa è negazione senza appello. La fede deve viverci dentro la crisi, non morirci dentro» (Q10, 23). «Vita quotidiana non significa fede che accetta il nonsenso come parola definitiva, ma fede che dentro l'esplosione del nonsenso dice il suo "però!: malgrado tutto - contraddizioni, sconfitte, alienazioni, cadute di utopie - io continuo a credere"» (Q10, 24).
Tutto questo si traduce nella ricerca di un «nuovo stile di vita». E riconduce, in fondo, al vivere la stessa proposta culturale dell'animazione come «spiritualità». Lavorare per gli obiettivi dell'animazione è lavorare per questo «nuovo stile di vita» (Q11, 18-26).
2.3.3. Tre approfondimenti dell'itinerario
Al discorso fondamentale dell'educazione dei giovani alla fede e all'itinerario seguono altre riflessioni così articolate.
* Nel Q9 Tonelli si interroga sul dove e come, a questo punto, i giovani possono vivere l'essere chiesa. Egli ritrova attorno all'esperienza del gruppo un modo originario di vivere la chiesa: il gruppo giovanile ecclesiale è il luogo primordiale in cui i giovani possono fare esperienza concreta di chiesa (Q9, 11).
Nello stesso quaderno l'autore risponde a una domanda non meno cruciale: quando un gruppo giovanile è ecclesiale? La risposta, che mette in discussione alcuni modi di definire la ecclesialità dei gruppi, è la seguente: il metro per misurare l'ecclesialità non è solo la presenza o meno dei signa ecclesiae (parola di Dio, sacramenti, un prete nel gruppo...), ma anche i signa regni (il servizio alla pienezza di vita fra gli uomini) (Q9, 12-13).
* Nel Q10 Giannino Piana invece si chiede come riformulare una proposta morale, da credenti, per i giovani di un'epoca culturale fatta di esasperata soggettività e di frammentazione. Il suo è un contributo decisivo per dare consistenza alla terza fase dell'itinerario alla fede: «verso un nuovo stile di vita» (Q10).
* Nel Q11 infine Armido Rizzi esplora, alla luce di quel criterio base di tutto il nostro progetto che è l'ermeneutica, come abilitare i giovani a leggere la vita quotidiana alla luce della parola di Dio, e la stessa parola di Dio alla luce della vita quotidiana. Offre preziosi stimoli per riformulare la seconda e la terza fase dell'itinerario alla fede (Q11).
2.4. L'ANIMATORE COME PERSONA IN CAMMINO
Un altro degli interrogativi di partenza a cui rispondere è: chi fa animazione?
Dell'animatore se ne deve parlare da due punti di vista: in quanto persona con i problemi di identità umana e cristiana, e in quanto svolge un ruolo preciso dentro un gruppo giovanile. In queste pagine ci limitiamo ad accennare all'animatore in quanto persona. Del ruolo dell'animatore del gruppo parleremo più avanti nel capitolo sul metodo.
Ovviamente le due dimensioni della vita dell'animatore sono in stretta relazione, ma non vanno confuse.
Se vogliamo individuare con una immagine la figura dell'animatore, ci sembra si possa dire che è un «uomo in cammino»: ha già fatto un poco di strada, sa di non essere arrivato, cerca di individuare e percorrere strade nuove, sempre più rispondenti al suo amore alla vita e alla sua passione educativa e, per un cristiano, evangelizzatrice.
Indichiamo i due grandi sentieri che individuano l'animatore come «uomo in cammino»:
- la maturità personale dell'animatore e la sua competenza professionale;
- la spiritualità dell'animatore.
2.4.1. La maturità dell'animatore e la sua competenza professionale
* Anzitutto il contesto: parlare di «maturità personale dell'animatore» non vuole per noi dire parlare della maturità umana in generale. Parliamo invece della maturità che viene ad accumulare l'animatore mentre svolge il suo servizio e ne ricerca il senso; parliamo della maturità dunque che viene dall'«apprendere dall'esperienza» in atto; parliamo della maturità come conquista quotidiana di un equilibrio dinamico tra le diverse sfere e ambiti di vita personale (Q2, 3-7).
All'animatore è richiesto, in primo luogo, di dare risposte sempre nuove, costruendo del resto su quelle già elaborate, alla sua identità personale. Questo è possibile se fa suoi alcuni atteggiamenti (Q2, 8-11):
- la capacità di essere veritiero, ma buono, con se stesso;
- la capacità di apprendere dal ruolo che svolge come animatore;
- la capacità di tollerare l'ambiguità e elaborare la conflittualità connessa al suo ruolo (Q2, 21-24).
La maturità dell'animatore cresce, in secondo luogo, in proporzione alla sua capacità di riconoscere e dar senso al fare animazione (Q2, 11-15). Da questo punto di vista è essenziale che egli ritrovi nel suo servizio una «fonte di felicità», che nasce dalla consapevolezza di «vivere in pieno la vita». Non c'è vera animazione se, almeno per un poco, l'animatore non vi ritrova il sapore della vita (Q2, 21-25).
* L'animatore è un testimone, ma un testimone «con competenza» (Q1, 3). Lo abbiamo dichiarato più volte.
Questa competenza non è qualcosa di aggiunto alla sua maturità umana e spirituale, ma il modo operativo di concretare la sua testimonianza.
Come acquisire questa «competenza professionale?». Non vogliamo farne un fatto di «studio» e conoscenza astratta.
Il primo e principale luogo di acquisizione di competenza è l'esperienza concreta e sofferta di animazione (Q1, 24-30).
Non pensiamo al semplice ripetersi di gesti e pratiche di animazione. Troppo spesso tale pratica si rivela incapace di «arricchire» chi la compie. Il vero nodo è «apprendere dall'esperienza» (Q1, 26).
Tuttavia solo attraverso lo studio si può avere, per un verso, una conoscenza più ampia ed esatta della realtà educativa, e, per altro verso, si può conseguire il formarsi di competenze professionali, corrispondenti alle esigenze storiche e aperte criticamente all'avvenire (Q2, 9).
In questo «studio» la formazione degli animatori richiede di integrare:
- una prospettiva concettuale, che offre una visione della vita e delle strutture culturali e religiose di riferimento;
- una prospettiva tecnico-operativa, che offre tecniche e strumenti di lavoro;
- una prospettiva relazionale, che abilita a interagire con gli altri in una logica educativa;
- una prospettiva spirituale, che offre l'orizzonte in cui l'animazione ritrova il suo senso ultimo e religioso (Q2, 25-26; cf NPG 1/84).
2.4.2. La spiritualità dell'animatore
Un altro aspetto dell'identità dell'animatore è la sua «spiritualità». L'ipotesi di partenza è che chi lavora come educatore e come evangelizzatore non può non rimanerne segnato dal punto di vista spirituale.
A due titoli: da una parte, è necessaria per l'animatore una visione spirituale che permetta di cogliere il senso ultimo e definitivo dell'animazione; dall'altra, il fare animazione deve essere un luogo privilegiato di «nutrimento» spirituale dell'animatore. In altre parole, la sua esperienza spirituale deve maturare essenzialmente mentre fa animazione e non a fianco o in momenti separati dal fare animazione.
Per verificare questa ipotesi abbiamo proceduto in due momenti. Nel Q3 è stata offerta una riflessione teologica che utilizzando la categoria del Regno di Dio come pienezza di vita tra gli uomini permette di vedere nell'attività di animazione un modo concreto di riconoscere l'azione di Dio tra gli uomini e di collaborare alla costruzione del suo Regno (Q3, 5-9).
Nel Q4 invece abbiamo esplicitato le modalità operative con cui l'animatore è chiamato a vivere la sua spiritualità che abbiamo riconosciuto come «spiritualità della Incarnazione», distinta da altri modelli di spiritualità anche oggi presenti nella chiesa. Essa per l'animatore si caratterizza, a partire da una profonda accettazione di sé, dalla sua passione per la vita e dalla sua passione educativa, come fede impegnata a interpretare gli eventi della vita alla luce dell'azione di Dio nella storia; come speranza impegnata a «penetrare» l'invisibile nascosto nel quotidiano; come carità impegnata nel servizio agli altri (Q4).
Tale vissuto spirituale viene a sua volta espresso e celebrato nella preghiera, nella liturgia, nella consapevolezza dell'animatore di svolgere un autentico «ministero ecclesiale».
3. IL METODO DELL'ANIMAZIONE CULTURALE
La nostra sintesi prende ora in considerazione i quaderni che esplicano, da diversi punti di vista, il metodo dell'animazione. Sono i quaderni in cui si risponde all'interrogativo: «Come fare animazione?». A questi quaderni dedichiamo più spazio per dare non solo una sintesi del materiale emerso, ma anche nuovi spunti di riflessione.
Aggiungiamo che neppure con queste pagine riteniamo conclusa la nostra ricerca sul metodo. Molti aspetti sono rimasti nella penombra e dovranno essere affrontati nel futuro da Note di pastorale giovanile.
Fin dall'inizio abbiamo presentato l'animazione, oltre che come un'antropologia e una proposta culturale ai giovani, come un metodo educativo.
Per metodo educativo intendiamo «la capacità di selezionare le risorse concretamente disponibili e organizzarle in un modello di relazione educativa fatta di tempi, luoghi, agenti, processi, strumentazioni» (Q1, 2).
Il metodo si pone all'incrocio tra tre «mondi»:
- l'esperienza attuale dei giovani, la situazione concreta in cui vivono ed in cui esprimono «domande educative»: questo è il punto di partenza;
- gli obiettivi che l'animatore si pone ripensando, nella concreta situazione, l'animazione culturale: questo è il punto di arrivo;
- l'insieme delle operazioni per far sì che si avvii un cammino e lo si conduca avanti con coerenza per permettere ai giovani di raggiungere gli obiettivi educativi.
Parlare di metodo non è ricercare delle ricette facili, delle formule magiche, ma piuttosto è fornire all'animatore u .a attrezzatura, un bagaglio, un insieme di orientamenti operativi pensati nella stessa logica e direzione. Una volta appreso il metodo, il cammino da percorrere concretamente è in fondo ancora da inventare e in fondo è prefissato. Per fare un paragone, insegnare un metodo è come insegnare i fondamentali del calcio o della pallacanestro, i movimenti principali ad uno sciatore, le astuzie tattiche ad un giocatore di scacchi. Una volta appresi questi insegnamenti il giocatore non sa ancora giocare e, tanto meno, come impostare una singola partita. Solo con l'esperienza, «facilitata» dalle attrezzature acquisite, si impara a giocare. E questo comporta fatica, errore, muoversi per tentativi, fantasia. Animare in effetti è certo frutto di tecnica e di competenza, ma rimane pur sempre un'attività artistica.
Quello che diremo nelle pagine seguenti sono allora gli orientamenti di fondo di un metodo dell'animazione culturale dei giovani. Essi possono essere raccolti intorno a cinque punti:
- un modo originale di accostarsi ed accogliere il mondo giovanile;
- un modo di intervenire centrato su una specifica comunicazione educativa;
- il fare del gruppo giovanile il luogo privilegiato dell'animazione;
- l'utilizzare le esperienze come unità di lavoro;
- il servirsi di alcuni «strumenti».
3.1. UN MODO DI ACCOSTARSI ALLE NUOVE GENERAZIONI
Il metodo dell'animazione è conseguente alla sua antropologia. Questa determina, in primo luogo, il tipo di «impatto» tra animazione e giovani.
Vediamo alcune caratteristiche di tale impatto.
3.1.1. Fiducia e accoglienza
L'animazione fa sua la scommessa che, anche nel nostro tempo, «val la pena vivere» e che la vita, nonostante tutto, può essere vincitrice sulla morte (Q5, 10).
Questa scommessa dà origine ad un «amore alla vita» nella sua concretezza, ovunque questo si manifesti. Fare animazione è mettersi a servizio di questa vita nascente e diffusa (Q8, 17-18).
L'animazione come metodo, a partire da questa scommessa, implica un modo originale di accostarsi al presente e alle nuove generazioni:
- ottimismo e fiducia indimostrata nel futuro dell'uomo: non come fiducia in un progresso illimitato, ma come affermazione che ogni situazione umana è redimibile e quindi può trovare o ritrovare un senso;
- apertura a ciò che di nuovo l'uomo produce a livello culturale, a patto che il nuovo acquisisca una qualità: il radicamento nella tradizione, condizione necessaria anche se non sufficiente di umanizzazione;
- preferenza per ciò che unisce più che per ciò che divide, senza cadere in superficiali irenismi culturali e religiosi, che altro non sono che una forma grossolana di relativismo;
- disponibilità alla collaborazione con tutti riconoscendo la dignità della loro coscienza;
- accoglienza incondizionata dei giovani e delle loro esperienze come luogo educativo in cui la ricerca giovanile può incontrarsi con i valori della cultura;
- «sguardo educativo» che, pur notando criticamente i risvolti negativi, scommette sulla forza liberante dei germi di vita nei giovani, se «innestati» nella esperienza culturale e religiosa;
- fiducia in tutto ciò che è «povero», sia nei giovani che negli adulti, perché in ogni situazione all'uomo è possibile compiere quel passo in avanti che può redimere la sua esistenza, in qualunque situazione egli si trova.
3.1.2. Ricerca dei «temi generatori»
L'accoglienza non è un atteggiamento passivo e, tanto meno, l'atteggiamento strumentale di chi vi vede un creare le premesse per poi «vendere» a scatola chiusa i propri prodotti culturali e/o religiosi.
L'accoglienza è invece un atteggiamento «attivo» che ricerca, riconosce, valorizza il nuovo nell'attuale cultura giovanile.
Accoglienza è ricercare, per dirla con Freire, i «temi generatori», cioè quelle intuizioni sul futuro che nascono da una sofferta partecipazione al presente e da una meditazione sulle proprie radici culturali (cf NPG 1/83: "Temi generatori nella pastorale giovanile").
I temi generatori sono, come ha scritto lo stesso Freire, frutto di un'epoca, ma i giovani ne sono gli immediati portatori, anche se in forma inconsapevole e passiva.
Questi «sentieri» verso il futuro sono decisivi per l'animazione, perché sono il vero luogo da cui cominciare l'attività educativa. Se l'animatore non individua i temi generatori della sua epoca e dei giovani in specie, la comunicazione educativa rimane nel generico.
Da notare tuttavia che questi temi appaiono, anche oggi, come dei «segnali a debole intensità», in quanto vissuti senza grandi slanci ma con una forte disponibilità alla concretezza educativa.
Quali possono essere questi temi generatori nella nuova cultura giovanile, pur nella frammentarietà della loro espressione?
Ne indichiamo essenzialmente tre: la ricerca di soggettività, il desiderio di solidarietà, l'apertura dell'invocazione.
* La solidarietà si esprime in gesti differenti e concreti: capacità di immedesimarsi nell'altro e attenzione alla sua «sofferenza», valorizzazione della persona e rispetto della sua coscienza, promozione degli handicappati e degli anziani, concretezza nel servizio agli altri...
Molti giovani vivono queste esperienze come qualcosa di intensamente nuovo rispetto ai modelli del recente passato. In questa novità essi sperimentano la possibilità di affrontare le tradizionali tensioni tra pubblico e privato, tra collettivo e personale, tra istituzioni e «mondi vitali».
* La riscoperta della soggettività inalienabile di ogni persona si esprime concretamente nella valorizzazione della quotidianità, nel bisogno di riscattare la persona da ogni defraudazione, nella ricerca di identità e di senso...
Anche queste esperienze esprimono un luogo di «riconciliazione» tra valori che spesso sono stati vissuti come contrapposti: legge e libertà, oggettività e responsabilità personale, norme e persone, impegno per gli altri e autorealizzazione.
* Il senso del mistero, il bisogno d'invocazione e la ricerca di trascendenza. Lo conferma la vita di gruppi e movimenti.
Lo esprime la storia di tanti giovani che vogliono uscire dalla crisi della secolarizzazione e dei grandi messianismi ideologici. La stessa riscoperta della soggettività e i nuovi modelli di solidarietà rappresentano per questi giovani il luogo privilegiato in cui ridire l'esperienza etica e riconquistare una esistenza credente.
Molti giovani stanno così inventando uno spazio vitale di religiosità che aiuta a superare la disperazione della triste chiusura nell'immanente o il non meno triste «consumo» di cose religiose.
Abbiamo provato ad elencare alcuni temi generatori. Vanno verificati, approfonditi, integrati, distinguendo il modo di esprimerli per fasce di età e per subculture giovanili. La loro individuazione e verifica è però possibile solo se l'animatore vive con i giovani e ne condivide l'esperienza quotidiana, lasciandosi provocare dal loro modo di pensare, di impostare i problemi e ricercarne le soluzioni, dal loro modo di agire e verificare l'azione.
3.1.3. La dignità educativa di ogni interesse giovanile
L'accoglienza è in terzo luogo riconoscimento della dignità educativa di ogni interesse e attività giovanile: attività religiose, culturali, sportive, educative, ricreative...
I temi generatori quasi mai si presentano nei giovani in forma concettuale riflessa. Più spesso sono da ricavare, in modo frammentario, dal vissuto giovanile, dagli interessi e dall'attività a cui i giovani si dedicano (Q8, 17-18).
Va ripresa qui l'affermazione che l'animazione non è una attività a parte, ma una «qualità» che le attività possono acquisire o meno: tutte le attività giovanili possono acquisire la qualità dell'animazione, che è poi la qualità della vita.
Sono luogo educativo tutte le attività giovanili senza preclusioni e senza pregiudizi. Non ci sono attività serie e altre meno serie. L'animazione può riguardare lo sport e il gioco, l'assistenza agli handicappati e il servizio al terzo mondo, la scuola e il lavoro. Tutte queste attività sono accolte dall'animazione, se i giovani vi sono interessati, come luogo in cui elaborare l'identità personale e fare cultura.
Un accenno soltanto al soggetto che accoglie. Esso è certamente un animatore come persona; ma è anzitutto una comunità educativa ed una comunità di credenti. Essa è certamente una accoglienza sul piano dei rapporti personali, ma è insieme un'accoglienza fatta di strutture e «centri giovanili» a servizio dei giovani e dei loro interessi (Q18, 9-11).
3.1.4. Il giovane nella sua «complessità»
Altra caratteristica del modo con cui l'animazione si accosta ai giovani è assumerli come «sistema complesso» secondo le riflessioni già offerte nell'antropologia di base: l'uomo è un sistema vivente in cui le parti e le funzioni hanno senso solo se rispetto al tutto, e in cui il tutto esiste solo se viene salvaguardata l'autonomia e specificità dei suoi componenti (Q5, 24-27).
Le conseguenze metodologiche vanno in due dimensioni della complessità: la complessità interna al soggetto e quella della sua relazione con l'ambiente.
* L'animazione intende anzitutto opporsi a due modalità educative insufficienti: il settorialismo e il gerarchismo (Q5, 25).
Troppa attività educativa odierna si rivolge ad aspetti settoriali della costituzione fondamentale dell'uomo. Alcuni esempi:
- ci si rivolge all'intelligenza e si dimentica l'emotività e la corporeità;
- si bada alla crescita fisica e si dimentica l'educazione ai valori, ad una fede, ai sentimenti
- si aiuta a darsi una identità, ma la si limita ad un orizzonte psicologico, dimenticando lo stretto rapporto tra identità personale e cultura o tra identità personale e senso «religioso » della vita.
L'animazione supera queste unilateralità. In ogni momento vuol rivolgersi a tutto l'uomo. Non per questo è una sorta di genericismo educativo. Semplicemente presta attenzione allo sviluppo dell'uomo integrale, senza preclusioni, e allo stesso tempo opera perché la crescita di una dimensione (ad esempio intellettuale) si integri alle altre (ad es. affettiva, religiosa...).
In secondo luogo l'animazione rifiuta una gerarchizzazione delle dimensioni della crescita umana che porta ad affermare che certe dimensioni sono più importanti delle altre (ad esempio le attività «spirituali» più importanti di quelle «fisiche») oppure ad una sorta di divisione dei compiti tra i vari ambiti educativi.
* Fare i conti, in secondo luogo, con la complessità dei vari sistemi «esterni» in cui i giovani sono immersi (Q5, 26-27).
I giovani fanno parte di diversi sistemi tra loro interagenti: gruppo spontaneo, classe scolastica, quartiere, tradizione culturale, territorio...
L'animazione rifiuta due modalità educative insufficienti:
- la modalità di chi interviene sul singolo, dimenticando che della sua individualità è costitutivo il rapporto con l'ambiente sociale:
- la modalità di chi interviene sul territorio, facendo dell'animazione un'attività politica, in modo che il cambio nel territorio induca un cambio nella personalità dei singoli.
A queste due polarizzazioni l'animazione oppone un modo di accostarsi alla realtà che, pur mantenendo distinti gli interventi «educativi» sulla-con la persona da quelli «politici» delle strutture e istituzioni nel territorio, reinterpreta continuamente gli uni alla luce degli altri.
Ogni animazione vuol essere politica, anche se si rivolge ai singoli, e ogni attività politica vuol sere di animazione, a servizio cioè della crescita delle persone.
Fare i conti con la complessità «territoriale» comporta:
- attenzione all'inserimento dei giovani nell'ambiente
- attenzione alle scelte politiche che influenzano la vita dei giovani;
- attenzione a programmare cambi non solo a livello personale o interpersonale, ma anche strutturale e quindi istituzionale.
3.1.5. Il giovane nella sua «libertà»
Infine, per l'animazione, l'uomo è sempre un sistema aperto. Sistema aperto si oppone a sistema chiuso (Q5, 26-27).
In un sistema chiuso è possibile «programmare» in modo preciso gli interventi, sapendo quali saranno i risultati. In un sistema aperto invece i programmi e gli interventi vengono ad interagire e a essere «perturbati» da informazioni che si ricevono dall'esterno che, entro certi limiti, rendono «imprevedibili» le reazioni del sistema. Come si diceva nelle pagine precedenti, nel sistema chiuso vale il principio del determinismo, mentre nel sistema aperto vale il principio di equifinalità.
L'animazione riconosce che ha a che fare con sistemi aperti, e quindi fa suo il principio di equifinalità (cf 2.2.1.).
Cosa comporta questa scelta per il metodo dell'animazione?
La scelta del principio di equifinalità dice:
- originalità di ogni soggetto e imprevedibilità, entro certi limiti, del suo comportamento;
- affermazione che in ogni soggetto e situazione rimane un «margine» di decisione personale e quindi di libertà;
- rispetto di ogni situazione di animazione, evitando di applicare «formule prefabbricate», anche se hanno portato frutto in altri contesti;
- misurare i soggetti sui «feedback» relativi a tempi lunghi, diffidando dei risulti immediati ed efficientisti;
- vedere l'animazione come «attività a rischio», nel senso che non si può mai fare calcoli sui risultati precisi;
- fiducia, infine, nel fatto che «mezzi poveri» e interventi poveri possano innescare una presa di coscienza che porta verso scelte sorprendenti sul piano della maturazione dell'identità personale.
3.2. UN MODO DI INSTAURARE LA RELAZIONE EDUCATIVA
L'animazione come metodo non si limita ad un modo di accostarsi al mondo giovanile. Essa insieme un modo di intervenire dentro il mondo giovanile.
Indichiamo questo intervento come «intervento educativo» e, più precisamente, come «reazione educativa».
Spieghiamo per passi successivi.
3.2.1. L'animazione si qualifica come «intervento educativo»
Sono in tanti a voler intervenire «dentro» il mondo giovanile (Q1, 21-24; 27-28):
- c'è l'intervento del politico e dell'economista, che vogliono modificare il quadro strutturale a servizio dei giovani;
- c'è l'intervento dell'organizzatore culturale, che vuole promuovere «la cultura» e i suoi contenuti, e per questo coinvolge i giovani;
- c'è l'intervento promozionale del tempo libero che qualifica sempre di più il suo servizio giovani attraverso palestre, campi di gioco, aree attrezzate, iniziative sportive...
Tra questi tipi di intervento, tutti impostati in modo metodico e intenzionale, c'è un denominatore comune: sono interventi sulle strutture, sulle attività, sugli oggetti, sulle «cose da re» perché migliorino la qualità della vita dei giovani.
L'animazione non rientra tra queste attività: il suo è un intervento (non meno metodico e intenzionale) sulla e con la persona. Questa è la sua angolatura e prospettiva: aiutare le persone a ritrovare il coraggio di vivere.
Ora, agire su-con la persona richiede strategie e modalità operative ben diverse da quelle per operare sulle strutture e sugli oggetti. Altra è la logica di fondo.
3.2.2. Cosa si intende per relazione educativa
Facciamo un passo avanti.
Parlare di intervento educativo ci è servito per precisare come l'animazione si qualifica rispetto a interventi politici o culturali.
Ma a questo punto è insufficiente, perché può lasciar intendere che è un fatto unidirezionale: dagli adulti ai giovani, dall'animatore al gruppo, dalla cultura alle nuove generazioni...
Questa concezione è insufficiente.
Partendo dalla riscoperta della cultura come «organismo vivente» e dunque in lenta ma progressiva maturazione, con elementi che permangono ed altri che si trasformano o scompaiono mentre altri prendono forma, si era affermato che il meccanismo che ne regola la crescita è la «comunicazione» al suo interno fra parti, funzioni, modelli di vita, forme culturali, generazioni.
Comunicazione dice scambio e arricchimento tra realtà diverse di uno stesso sistema, alle quali si riconosce di essere, ognuna per quel che le compete, una sorta di «laboratorio culturale». Lo scambio dei materiali culturali è tra laboratori che elaborano cultura e non tra magazzini in cui è passivamente depositata la cultura e in cui lo scambio è solo trasloco nello spazio e nel tempo.
La comunicazione dentro la cultura è un fatto diffuso: avviene continuamente anche se in modo a volte povero e limitato. Questa comunicazione diventa «educativa» nel momento in cui si pone come attività intenzionale e metodica di scambio e arricchimento.
Vediamo cosa caratterizza questa attività che chiamiamo comunicazione, o, più specificamente, «relazione educativa» (Q17, 15-16).
Si ha una relazione educativa, ad esempio, tra soggetti che rappresentano la memoria culturale/religiosa e nuove generazioni alla ricerca di identità/senso per la loro vita quotidiana, quando si verificano contemporaneamente tre fatti:
* il riconoscimento dell'asimmetria della comunicazione: da una parte la «memoria» culturale con tutto quello che l'uomo ha elaborato finora; dall'altra una generazione ricca di «temi generatori», ma in fondo inesperta e alla ricerca di una identità e di un senso;
* disponibilità reciproca alla comunicazione: c'è un contesto fiduciale, di accoglienza senza preclusioni, che porta a un «patto comunicativo»: volontà di scambio di informazioni e valori per creare un'area di «condivisione» culturale;
* disponibilità al cambiamento, sia da parte della memoria culturale sia dei giovani. Il cambiamento culturale si manifesta nella capacità di aprirsi e accogliere il nuovo (ad esempio le intuizioni a proposito della soggettività, solidarietà e invocazione), nella volontà di riformularsi in termini ermeneutici per dare vita a nuove forme culturali, nell'affrontare tutti i cambi strutturali e quindi politici per consolidare il cambiamento.
C'è relazione educativa solo se tutte e tre le condizioni sono presenti e attive.
L'animazione si riconosce così nell'espressione di Paulo Freire «nessuno educa nessuno; nessuno è educato da nessuno; ci si educa tutti insieme».
3.2.3. Alcune condizioni per una relazione educativa
Per far vivere il triangolo educativo ora descritto, vanno salvaguardate alcune condizioni. Alcune riguardano gli educatori, altre i giovani. Le ricordiamo, senza pretesa esaustiva.
Condizioni negli educatori
* Una disponibilità al cambio culturale ed una competenza ermeneutica.
L'adulto/animatore ha ovviamente una sua identità personale e si riconosce in una «memoria culturale».
Consapevole di questo, egli entra nello scambio con le nuove generazioni e riconosce che il «nuovo» non è di per sé nemico del passato o della memoria culturale: il presente sollecita a riformulare il modo di vivere, i nuovi temi generatori richiedono di trarre fuori dai valori culturali e religiosi quel che, con una immagine, può essere detto «l'inespresso».
Si diceva prima che la comunicazione educativa avviene tra «laboratori culturali». Ecco, occorre essere pratici di come funziona un laboratorio (Q7, 20-23).
Fuori dalla metafora, l'animatore sa che i contenuti culturali in cui si riconosce sono la sintesi tra i «valori perenni» dell'umanità e la loro concretizzazione storica in un dato ambiente (Q10, 10-14; Q11, 7-9).
Consapevole di questo, egli apprende a «scindere» la «tradizione» dalle singole «tradizioni» e a fondere insieme, in una nuova figura culturale, i valori di sempre (arricchiti, per altro, dalla storia di questi valori in una cultura) con i «temi generatori» tipici della nuova epoca.
A questa consapevolezza e capacità diamo il nome di coscienza e competenza ermeneutica.
* La competenza ermeneutica richiede a sua volta una capacità politica.
Con capacità politica intendiamo quel che si dice «passare dalle parole ai fatti», in un modo che le nuove intuizioni, le nuove norme, i nuovi modelli di vita si realizzino, acquistino consistenza, si espandano (Q5, 26).
Le conclusioni operative non riguardano solo i singoli o i piccoli gruppi. Riguardano anche le istituzioni educative, le forze sociali, la comunità ecclesiale.
Senza un'azione adeguata sul piano del cambio istituzionale il processo educativo si blocca e reagisce (Q19, 9-11).
* Infine la capacità di «relazione» con gli altri (Q2, 21-2; Q16, 17-23).
Un buon animatore sa che gli altri lo percepiscono per quello che egli è realmente come persona. Ora, non gli è chiesto di essere un «cavaliere senza macchia e senza paura», ma più semplicemente di avere consapevolezza dei propri problemi senza proiettarli sugli altri e di saper riconoscere i problemi degli altri e cercare insieme, con pazienza, una soluzione. Procedendo per prove ed errori egli apprende a qualificare la sua relazione.
Proprio per questo fa suoi alcuni atteggiamenti:
- saper ascoltare e saper aspettare, con pazienza, rispettando tempi e persone;
- saper contenere il dolore, l'incertezza, il rischio ed il conflitto che comporta sempre la relazione educativa;
- apprendere ad elaborare l'esperienza educativa;
- non usare gli altri come retribuzione per la propria gratificazione...
Condizioni nei giovani
* «Decisione» di entrare in un «cammino di animazione».
L'animazione è un cammino educativo intenzionale e metodico. Di questo i giovani devono avere un minimo di coscienza.
Non c'è animazione se non c'è accordo sui fini, sui grandi obiettivi, sulle principali strategie scelte di metodo (Q16, 8).
All'inizio del cammino ci deve essere una sorta di «patto comunicativo». Ovviamente se ne ò avere una diversa consapevolezza, sia tra gli adulti che tra gli stessi giovani; in tanti casi o essere implicito, non dichiarato, ma non meno robusto.
* Un cammino educativo centrato sulla collaborazione critica.
Il clima dell'animazione è così quello della collaborazione critica, del protagonismo giovanile, senza però richiedere ai giovani di farsi carico da soli della «gestione» della ricerca condotta insieme, della verifica (continua) del lavoro che si sta facendo...
La stessa «conflittualità» quotidiana fa parte del patto comunicativo, in quanto nessuno si lascia facilmente ridurre all'altro e alla sua visione delle cose, ma ricerca nell'autonomia.
3.3. IL GRUPPO GIOVANILE COME SOGGETTO EDUCATIVO
L'animazione è la continua ricerca di modi, tempi, spazi che permettano di attivare una nuova comunicazione educativa tra giovani e memoria culturale.
La domanda che ora si pone è: qual è lo spazio privilegiato della comunicazione educativa? (Q16, 6)
La risposta può essere così riassunta: lo spazio privilegiato dell'animazione è il «piccolo gruppo» giovanile.
Questa affermazione ne contiene altre due. La prima: l'animazione non è una pedagogia dell'a-tu-per-tu e neppure una pedagogia di massa, ma una pedagogia che fa del gruppo il vero soggetto educativo. La seconda: non c'è animazione se nel gruppo non esiste un animatore, qualcuno cioè che svolga il «ruolo» di animatore.
Vediamo velocemente cosa intendere per gruppo, per poi sottolineare tre aspetti: il perché della scelta del gruppo come luogo privilegiato di animazione, cosa comporta considerare il gruppo soggetto educativo, la relazione fra animatore e gruppo.
Cosa intendere per gruppo? (Q16, 3-6) L'animazione rifiuta due concezioni, per assumerne una terza. Una prima concezione di gruppo che rifiuta è quella che lo considera una semplice aggregazione o somma delle persone che lo compongono. La seconda concezione che rifiuta è quella che considera il gruppo come qualcosa di totalizzante in cui si perdono e si nullificano le individualità irripetibili del suoi membri.
Il gruppo viene invece considerato come un insieme in cui i singoli interagiscono attraverso una rete di comunicazione più o meno intensa, mantenendo tuttavia la loro individualità. Sia all'interno che in rapporto all'ambiente in cui vive, il gruppo reagisce così come un tutto.
3.3.1. Il perché del piccolo gruppo
La scelta del piccolo gruppo va giustificata, per non sembrare che si voglia cedere al giovanilismo o alla faciloneria educativa.
In effetti il gruppo primario possiede un elevato potenziale educativo. A tre titoli.
* Nel piccolo gruppo, attraverso le relazioni faccia a faccia, è possibile un'esperienza dell'altro profonda e autentica, e quindi una relazione in cui risuonano tutte le dimensioni della comunicazione e non solo quelle informative e istituzionali tipiche dei grandi gruppi (Q16, 8-9).
L'attività, lo scambio non verbale, la vicinanza fisica dell'altro danno alla comunicazione una risonanza che non si ha nei rapporti tra ruoli, maschere obbliganti le persone, delle grandi organizzazioni o del sistema sociale.
Il gruppo primario è così in grado di attivare processi che negli individui sviluppano una maggior consapevolezza di sé, una maggior capacità di integrare le varie dimensioni della personalità, una maggior capacità di essere fedeli nel sociale e quindi di partecipare alla vita culturale (Q16, 6).
* Non basta; il gruppo è anche luogo privilegiato di scambio tra individuo e cultura (Q16, 7-8).
Per comprendere infatti la scelta del piccolo gruppo, occorre allargare, almeno per un momento, l'orizzonte e collocare il gruppo e il suo potenziale educativo nel contesto della cultura e dei fenomeni di comunicazione al suo interno.
Lo scambio tra individuo e cultura non è quasi mai diretto, bensì mediato dalla presenza di «gruppi-laboratorio» in cui l'individuo si riconosce. Identificandosi nel gruppo l'individuo esce dall'isolamento per «condividere» con altri l'esperienza. Il gruppo viene così a garantire la creazione progressiva di «aree di condivisione» intersoggettive, fino a nuove esperienze di unità con altri gruppi e con la cultura. La soggettività non viene né rifiutata né esaltata, ma fatta incontrare con altre soggettività e con la cultura.
* Non ci sono solo però, all'avventura del gruppo, i problemi di relazione con gli altri, con se stessi, con la natura, ma vi sono anche i problemi connessi al significato unitario della vita.
«Comunicando, vivendo gli scambi sociali, affettivi e conoscitivi, l'uomo ridisegna, ridefinisce, amplia o restringe, unifica o frantuma il proprio mondo e gli orizzonti di senso al fine di dare risposta ai più elementari e inquietanti quesiti sul perché della vita» (Q16, 9).
3.3.2. Il gruppo come soggetto educativo e la relazione fra animatore e gruppo
Vediamo che cosa significa considerare il gruppo come soggetto educativo e cosa comporta per una relazione fra animatore e gruppo.
Il gruppo come soggetto educativo
Il gruppo può essere visto come «occasione educativa» o come «soggetto educativo» (Q17, 10-12).
È «occasione» se visto per gli spazi e i tempi che può offrire per moltiplicare le relazioni a-tu-per-tu o per mettere i giovani a contatto con i valori ai quali altrimenti non si riuscirebbe ad avvicinare. Le attività rendono interessante il gruppo, per attirare i giovani e assicurare la loro identificazione con le proposte educative.
Così facendo non si utilizza seriamente la «forza educativa» che è il gruppo; di più, non gli sii riconosce dignità. Il gruppo è visto solo in termini strumentali.
Vedere il gruppo come «soggetto», invece, è considerarlo come un organismo vivente la cui vitalità è data non dalla somma delle relazioni tra le parti, ma da un qualcosa che le supera perché è in grado, come insieme, di elaborare cultura e dare vita ad un preciso modo di educare.
Nel gruppo soggetto tutti sono «educatori», perché tutti hanno qualcosa da portare e scambiare con gli altri e perché insieme incarnano una volontà educativa.
Ciò non vuol dire nullificare la presenza dell'animatore. Egli è l'interprete autorevole della volontà educativa del gruppo come insieme. In altre parole, «il gruppo stesso accetta di concentrare la funzione educativa in alcune persone, perché le considera espressione simbolica della sua vita o perché riconosce collettivamente il ruolo da essi esercitato» (Q17, 12).
L'animatore si sente a servizio del gruppo per migliorarne la capacità di soggetto e dunque la capacità di collegarsi alla memoria culturale, interpretare e riscrivere i valori e i contenuti, consolidare l'identità di gruppo come via per consolidare l'identità dei singoli (Q17, 21-23).
Per questo l'animatore è un esperto delle dinamiche del gruppo: lo aiuta a «funzionare» e diventare organismo vivente moltiplicando il suo potenziale educativo.
Per svolgere il suo lavoro l'animatore deve certo sentirsi parte viva del gruppo, «dentro» il gruppo, ma dall'altra egli deve rimanerne «fuori». L'animatore non si coinvolge nelle dinamiche interne al gruppo. Come un medico, egli osserva l'andamento dei fenomeni, fa diagnosi e indica terapie, partecipa con premura ma non si «sostituisce» al malato. In fondo, le malattie del gruppo non devono anche diventare le malattie dell'animatore.
Di conseguenza l'animatore sa vivere in «solitudine» proprio mentre partecipa al gruppo. Ha una sua autonomia e vita personale che non confonde con quella del gruppo.
Un animatore democratico ma autorevole
Una volta individuato il ruolo dell'animatore nel gruppo, va precisato lo stile con cui svolge il suo servizio.
Rifacendosi alla tipologia usuale degli stili di comando (autoritario, democratico, permissivista) è facile riconoscere che lo stile democratico è quello dell'animazione (Q17, 18-19).
Lo stile democratico contro la «pedagogia del consenso» alla base dello stile autoritario, e contro la «pedagogia libertaria» (ma, in fondo, di consenso) dello stile permissivista, tenta di proporre una alternativa concreta e realistica che sappia contemperare libertà e responsabilità, creatività e oggettività.
L'animatore democratico si caratterizza perché:
- incoraggia e sollecita il gruppo a esaminare i problemi, a vederne tutti gli aspetti, a prendere decisioni, scegliendo tra le alternative possibili individuate;
- accompagna il gruppo nella realizzazione delle sue attività, offrendo consulenza, aiutando a dividersi i compiti, incoraggiando senza mai sostituirsi al gruppo;
- facilita la capacità dei singoli, nell'arrivare a una corretta immagine di sé, nel motivare i propri comportamenti e prendere decisioni personali...
Animatore democratico non vuol dire rifiuto di far proposte, ma piuttosto far proposte partendo da una autorevolezza fondata sulla capacità di aiutare a «vivere» (Q17, 24-25). L'animatore vuol fare davvero l'educatore. «In un tempo, come è il nostro, in cui il diritto a parlare è spesso legato alla tacita accettazione di dire cose che non contano, l'educatore valida la sua pretesa comunicativa non sul rapporto istituzionale che gli garantisce prestigio perché egli è alle sue dipendenze, ma sulla competenza e coerenza, che gli assicura una proposta di valori culturalmente significativa e testimoniata dalla sua esistenza» (Q17, 24).
«La ragione ultima della sua presenza tra i giovani, quella che lo autorizza a sollecitare responsabilmente verso l'ulteriore e l'inedito, è la pretesa globale di aiutare a vivere e la realizzazione di questo compito ponendo gesti concreti dalla parte della vita. L'educatore crede alla vita e gioca tutto perché ci sia vita. Di questa vita egli è anzitutto un testimone.
Egli è testimone della vita come dato, come evento che misura ogni nostra ricerca e giudica inesorabilmente tutte le nostre pretese... L'educatore è quindi garante e propositore coraggioso del già espresso e posseduto. Egli però esprime la vita nella sua vita. Sa che nulla di vitale può essere detto nella fredda oggettività formale. Tutto è detto vivendo, rischiando, costruendo. Egli è testimone della vita nella sua testimonianza di vita» (Q17, 25).
3.3.3. Fasi di vita del piccolo gruppo
Abbiamo parlato del gruppo come organismo vivente. Riprendiamo questa immagine perché permette di intravedere il gruppo non nel momento statico, ma in quello dinamico di un tutto che con le sue parti si evolve dando luogo a nuove organizzazioni e forme di vita.
La potenzialità educativa del gruppo si scatena proprio nel suo evolversi.
Questo cammino o itinerario è segnato da alcune tappe evolutive. Ne ricordiamo le principali, tenendo conto che sono tappe da una parte «naturali », perché connotano l'evoluzione di ogni piccolo gruppo che come un organismo vivente nasce-cresce-raggiunge la maturità e muore, e dall'altra sono tappe «educative», alle quali si giunge cioè attraverso lo sforzo congiunto dei membri del gruppo e dell'animatore.
* Prima tappa: dalla disaggregazione alla solidarietà. All'inizio della vita di un gruppo c'è, di solito, un animatore o una associazione che prendono coscienza della situazione dei giovani e delle «domande» che questi sollevano.
L'animatore vi risponde inserendosi attivamente in mezzo ai giovani. La sua è una presenza disinteressata; il suo unico obiettivo è mettersi a servizio della crescita delle persone.
In questa prima fase il gruppo si propone di far conoscenza, far incontrare, rassicurare, intensificare le relazioni, valorizzare ogni interesse, condividere le esperienze quotidiane.
* Seconda tappa: dalla solidarietà della decisione di essere gruppo. Una volta che i giovani hanno esperimentato una solidarietà disinteressata, il loro essere in gruppo diventa la ricerca tacita di un cammino che liberi le energie profonde sepolte in ognuno.
Per fare questo non ci si limita a favorire la accoglienza e la gratificazione, ma si incomincia a chiedersi «chi» è ognuno dei presenti, perché si viene nel gruppo, cosa si può fare non più come singoli ma come insieme.
Affiora progressivamente una decisione: è importante «per me» fare gruppo, fare parte di «questo» gruppo, non solo perché mi trovo bene, ma perché il gruppo permette di scoprire chi sono nel momento in cui scopriamo chi siamo, permette di accettarmi nel momento in cui ci accettiamo. Per ottenere questo ognuno si dichiara disposto a «pagare un prezzo».
Il gruppo è in grado di imporre ai singoli piccole norme, fissare degli appuntamenti, affidare degli incarichi. Il gruppo si qualifica come «gruppo di appartenenza».
* Terza fase: dalla decisione di essere gruppo all'incontro con le proposte culturali e religiose. La decisione di essere gruppo e di accettarne il cammino si evolve ora nella direzione del dialogo e della elaborazione di risposte critiche alle domande della vita ai vari livelli (al livello esistenziale, al livello etico, al livello religioso esplicito) confrontandosi con la «memoria» culturale e religiosa.
Questo incontro tra le domande giovanili e le «proposte» della cultura e della fede non deve essere visto in modo astratto. È un dialogo che corre lungo la trama complessiva del vissuto di gruppo. È una continua osmosi, che avrà momenti di tipo intellettivo ma anche affettivo e operativo.
Il punto di arrivo è la capacità del gruppo di scrivere una sua biografia all'interno della quale vengono a collocarsi anche le biografie individuali.
* Quarta fase: dall'incontro con le proposte alla partecipazione. È questa la fase della maturità del gruppo. Non si vuole dire che ormai i suoi membri sono maturi, ma piuttosto che il gruppo esprime caratteristiche tipiche della maturità di un organismo vivente: capacità di produrre, capacità di autonomia, continuità negli impegni, riflessione organica sul vissuto alla ricerca di un «filo rosso», apertura ad un rapporto duraturo con l'esterno... È il momento più «tranquillo» della vita del gruppo. Non ci sono più grandi svolte, grandi crisi, grandi slanci. Il gruppo vive una sorta di routine quotidiana.
Le intuizioni globali relative al senso della vita, come pure gli orientamenti etici, piano piano si traducono in uno stile di vita di gruppo che costruisce la sua identità, capace a sua volta di nutrire la identità dei singoli. Il periodo della maturità è dunque quello della crescita di una identità dinamica.
Il gruppo diventa capace di controllare, in termini informativi, valutativi e operativi spazi sempre più vasti, assumendosi compiti sempre diversificati sia come insieme sia come individui.
* La quinta fase: dalla maturità del gruppo alla morte del gruppo. È la fase delicata del cosiddetto «sbocco» del gruppo, in cui si affronta il problema del come vivere nel dopo-gruppo. Ai membri questo periodo può apparire difficile. Lo si percepisce come una minaccia a quello che finora si è costruito. Possono aumentare di nuovo i conflitti e le tensioni. Perché il gruppo affronti questa fase occorre cogliere la naturalità e, in fondo, la positività. Il bloccarsi alla fase precedente rischia di adolescentizzare il gruppo. Meglio aiutarsi a guardare in avanti, abilitando le persone a scegliere, ad inserirsi nei vari ambiti della vita sociale, a chiedersi come utilizzare in modo nuovo l'esperienza accumulata. Dal «gruppo di appartenenza» si passa al «gruppo di riferimento».
Queste sono, a grandi linee, le fasi normali di un gruppo di animazione. Fare del gruppo un soggetto educativo è considerarlo in questa ottica evolutiva, sapendo trarre da ogni fase ciò che può arricchire le persone che ne fanno parte. Si comprende meglio il ruolo competente dell'animatore. Egli sa come si evolve un gruppo e lo aiuta ad apprendere dalla esperienza che sta vivendo.
3.4. UN METODO CHE LAVORA SULLE ESPERIENZE
Se il piccolo gruppo è il luogo dove fare animazione, le esperienze sono, per così dire, le «unità di lavoro», in modo che si può parlare di un metodo esperienziale (Q7, 26).
L'animazione fa suo il principio metodologico del «fare proposte facendo fare esperienze».
Il principio «far fare esperienze» dice la necessità di operare sempre in modo concreto e rispettoso della sperimentabilità delle proposte facendo quasi toccare con mano ciò a cui si sollecita educativamente.
Il valore educativo dell'esperienza è dato dalla sua capacità di riprendere il vissuto giovanile e farlo entrare in contatto con la esperienza più vasta degli adulti, a livello di valori umani e di proposta di fede cristiana.
Così facendo, l'animatore vuole entrare in contatto con il linguaggio esperienziale delle nuove generazioni, ma soprattutto vuole mediare le proposte educative e religiose non tanto attraverso concetti e informazioni astratte quanto attraverso esperienze, e attraverso ciò che esse evocano nel profondo della coscienza giovanile.
Va anche compreso, almeno di passaggio, il ruolo educativo delle esperienze nel quadro più generale della ricerca di identità personale durante l'adolescenza.
La costruzione dell'identità è un processo per tentativi che segue la logica dell'oscillazione del pendolo. L'adolescente non è in grado di articolare di colpo la sua identità. Per farlo ha bisogno di «oscillare», senza disintegrarsi e disperdersi nella direzione dello spazio e del tempo, della interiorità e della socialità, alla ricerca del senso etico, esistenziale e religioso della vita personale e collettiva.
Il fare esperienza è la strategia principale attraverso cui l'adolescente ricerca e costruisce la sua identità.
3.4.1. Cosa intendere per fare esperienza?
La domanda è importante perché si tratta di individuare dei parametri su cui misurare quelle che nel linguaggio comune vengono dette esperienze.
L'esperienza, per essere educativa, implica alcune componenti essenziali, riducibili a quattro: il contatto immediato, il rapporto con il mondo storico culturale attraverso il linguaggio, la riflessione, la trasformazione del soggetto.
* L'esperienza è anzitutto qualcosa di immediato, che si tocca con mano. Ciò che si è sperimentato si mostra, è evidente a chi ne fa l'esperienza.
Ci sono naturalmente diversi gradi di immediatezza e di consapevolezza del contatto che si ha con un qualcosa. Non sempre, ad esempio, il giovane è direttamente consapevole di quel che succede nell'esperienza, anche se influisce su di lui. A volte l'esperienza passa inosservata, forse persino bloccata o repressa. Solo un intervento educativo permette di riprenderla, liberarla e portarla alla coscienza.
Non si deve confondere tuttavia esperienza con materialità.
Il dato immediato di ciò che è stato sperimentato non deve essere affatto ridotto a dato puramente sensibile (un vedere, un toccare, un udire...). Il rendersi conto di vedere, toccare, udire è già una «elaborazione » astratta dell'esperienza che per se stessa è un evento che colpisce il soggetto come insieme. L'esperienza ha un carattere complessivo. Essa coinvolge in modo immediato il soggetto come totalità.
* Non esiste esperienza se non esiste un linguaggio che permetta di dirla, rappresentarla, interpretarla. Soltanto nel linguaggio le nostre esperienze si manifestano.
Il fatto che il linguaggio sia sempre il mediatore tra noi e la nostra esperienza non annulla l'immediatezza del fare esperienza, ma la qualifica dandole un orientamento, un senso.
La presenza del linguaggio permette al fare esperienza di assurgere dalla semplice sensibilità e materialità, per manifestarsi come evento che viene a fare parte di un dato contesto storico-culturale. Nel fare esperienza il singolo si radica, attraverso il gioco fra contatto immediato e linguaggio che lo manifesta, in una data cultura e ambiente.
In questa direzione si deve dire che c'è esperienza solo se il giovane, oltre che sperimentare se stesso, entra in contatto con la «memoria culturale», contatto con un segmento o frammento di memoria culturale e religiosa delle generazioni che l'hanno preceduto.
Si deve anche aggiungere che senza l'arricchimento del lessico personale e di gruppo il fare esperienza risulta un materiale grezzo e forse inutilizzabile.
* La presenza del linguaggio introduce una terza dimensione dell'esperienza: la riflessione e interpretazione del vissuto. Secondo la concezione comune del termine, la riflessione sembra diametralmente opposta alla immediatezza dell'esperienza, perché mediante la riflessione cerchiamo di raggiungere proprio ciò che non ci è dato in senso immediato. Non è in questo modo che si vuol parlare di riflessione sull'esperienza.
C'è un altro modo in cui la riflessione può essere intesa: scoprire in ciò che è già dato, e quindi nella sua immediatezza, qualcosa dell'esperienza originaria che era già dato; cioè di liberarlo anzitutto del suo stato di esser nascosto e di esser represso.
Così intesa la riflessione è un'azione di disvelamento e di illuminazione di ciò che è dato nella esperienza immediata.
Senza la riflessione non esiste «fare esperienza». Essa permette infatti non di sostituire gli anelli mancanti ai messaggi della immediatezza, ma di scoprire l'immediatezza bloccata, repressa o confusa, di distinguerla e renderla visibile dietro le nebbie delle incertezze quotidiane .
La riflessione a cui dunque abilitare è così una riflessione sul vissuto, sulle cose e sui fatti, sulle motivazioni e sulle attese, sui risultati e sulla responsabilità personale...
* Infine, ciò che si è sperimentato non diventa esperienza reale nel senso pieno del termine nel momento in cui appare e in cui si apre la riflessione/scoprimento, ma solo nel momento in cui ciò che si è sperimentato colpisce nel suo intimo chi fa esperienza e lo trasforma, in modo che da allora comincia a vivere ed esistere in questo mondo in maniera diversa. Solo un'esperienza coinvolgente e trasformante è autentica.
Chi ha fatto esperienza comincia a diventare un altro rispetto a quello che era prima, e comincia a considerare e comportarsi verso il suo mondo in modo diverso da quello precedente.
Questa trasformazione comporta due movimenti: uno negativo ed uno positivo. Dopo la trasformazione attraverso l'esperienza le cose non stanno più come stavano prima. Si percepisce che non si può più essere come prima.
Ma da questa negatività sorge una nuova positività: tutto è nuovo e diverso in modo forse inaspettato. Si dice che è un soggetto ricco di esperienza.
3.4.2. A quali esperienze si fa riferimento?
Indichiamo anzitutto tre ambiti di esperienza a cui l'animazione fa riferimento.
Le esperienze quotidiane
Il primo ambito sono le esperienze quotidiane del giovane.
È su queste, anzitutto, che l'animazione concentra il suo lavoro educativo. Il gioco, la vita di coppia, la routine quotidiana, lo studio, i problemi di famiglia sono ciò di cui tratta l'animazione.
Tutte le esperienze sono importanti e l'animatore sta attento a non banalizzarle. In loro infatti l'adolescente e il giovane vivono l'avventura della vita e ne ricercano un senso. Il «fare esperienza» è, come si diceva, la strategia concreta attraverso cui l'adolescente ricerca e costruisce la sua identità.
L'animazione lavora per far sì che nel gruppo avvengano una serie di processi che possono essere così riassunti:
- aiutare a far esplodere la domanda di vita;
- aiutare a darsi una «parola» sulle esperienze;
- aiutare a muoversi verso altre esperienze.
Le esperienze perturbatrici
Il secondo ambito sono le «esperienze perturbatrici».
L'animazione non pensa l'azione educativa come semplice aiuto al gruppo e ai suoi membri perché esprimano le loro potenzialità. Intende, invece, mettere il gruppo a contatto con fatti, persone, eventi, valori non immediatamente deducibili dalle esperienze personali e di gruppo. Come? Attraverso «avvenimenti perturbatori», capaci di attivare un processo di crescita. Questo si realizza non attraverso «parole», o messaggi, magari grandi e affascinanti, ma attraverso «esperienze-che-si fanno-messaggio» che riequilibrano le carenze e aprono nuovi orizzonti.
La nuova esperienza/messaggio introduce nella vita del gruppo un elemento perturbatore e/o conflittuale che destruttura l'equilibrio personale e di gruppo raggiunto fino a quel momento, fa spazio ad un periodo di incertezza, abilita alla ristrutturazione della vita personale e di gruppo.
Perché un'esperienza sia perturbatrice si richiedono alcune condizioni:
- una esperienza significativa, in quanto capace di agganciare alcune esigenze magari sopite del gruppo e di far intravvedere nuovi spazi, orizzonti, equilibri;
- una esperienza compiuta come gruppo, in quanto è il gruppo nel suo insieme che fa esperienza e sollecita i suoi membri ad un processo di destrutturazione e ristrutturazione dei valori, atteggiamenti, comportamenti;
- un'esperienza dentro un progetto organico di intervento che consolida il cammino verso l'obiettivo generale dell'animazione e della educazione alla fede;
- un'esperienza che non è un concetto vestito da attività, ma un qualcosa di globale che nel suo svolgersi genera nuova visione di sé, degli altri, della vita.
Le esperienze generatrici
C'è un terzo ambito di esperienza a cui l'animazione presta attenzione: le esperienze che «generano» alla maturità.
Sono le esperienze a cui ci si orienta per esprimere, una volta accolte criticamente le proposte culturali e religiose, e riformulata alla loro luce la propria identità, i poli attorno a cui costruire il loro «futuro d'uomo».
Possono essere esperienze di volontariato e servizio, assunzione di nuove responsabilità nel gruppo, impegno in un rapporto di coppia, fedeltà a un momento di preghiera personale o di gruppo...
In questa fase si dovrà:
- aiutare il gruppo e i suoi membri a sopportare la frammentarietà e la confusione della nuova identità, indicata dalle esperienze generatrici, che sorge in mezzo a tante esperienze «vecchie»;
- aiutare a consolidare i legami tra le varie esperienze generatrici per arrivare alla «coscienza esperienziale » di vivere concretamente l'amore alla vita;
- aiutare a passare dalla coscienza esperienziale alla «coscienza critica» e riflessa dell'orientamento di fondo che si sta dando alla propria vita, e giungere ad una consapevolezza globale della propria esistenza come esistenza dedicata alla causa dell'«amore per la vita».
3.5. GLI STRUMENTI PER FARE ANIMAZIONE
Di quali strumenti operativi dispone l'animazione per svolgere il suo lavoro? Con tale parola vogliamo indicare tutto ciò che serve a rendere attuale la relazione educativa (l'unico vero «strumento» dell'animazione), potenziarla e consolidarla, orientarla e stimolarla fino al suo compimento .
Ci sono tanti strumenti educativi, ma non tutti possono essere usati dall'animazione, perché ogni strumento non è affatto neutrale, ma include un'immagine d'uomo che può essere contrastante con quella che l'animazione si propone di sviluppare. Così, ad esempio, l'animazione non può far ricorso a strumenti il cui controllo sfugge al gruppo, o che fanno trovare il gruppo in una situazione di ricatto affettivo, o che esasperano l'individualismo a scapito di una identità collettiva.
Anche gli strumenti devono essere quindi conseguenti all'antropologia di base dell'animazione.
Li riconduciamo a quattro raggruppamenti:
- gli strumenti offerti dagli studi sulla comunicazione umana e sulla dinamica di gruppo;
- il linguaggio, nelle sue diverse modalità, per «dare un nome» alle cose della vita;
- la programmazione educativa, come strumento per una progressiva «approssimazione» ad una proposta educativa adeguata alla situazione ambientale e giovanile.
3.5.1. Gli strumenti della comunicazione umana e della dinamica del gruppo
L'animazione è un metodo educativo centrato sulla «relazione educativa» nel piccolo gruppo o gruppo primario.
Per potenziare in termini quantitativi e qualitativi tale relazione, utilizza gli strumenti offerti dagli studi sulla comunicazione umana e da quelli sulla dinamica dei gruppi primari.
Con due preoccupazioni che ora presentiamo.
Strumenti relativi alla conoscenza e cambio nelle funzioni vitali del gruppo
La principale preoccupazione è dare corpo ad un punto fermo del nostro progetto che considera il gruppo come un soggetto educativo in quanto «organismo vivente», dove i singoli interagiscono dando vita ad una entità nuova.
Di questo organismo ci si preoccupa di precisare le funzioni che, dalla nascita alla morte, ne regolano la vita e gli strumenti adeguati per identificare, tenere sotto controllo, attivare le stesse funzioni.
Vediamo velocemente le tre funzioni vitali del gruppo e i relativi strumenti, mentre rimandiamo al Q16 e al Q17 per un approfondimento.
* La vita del gruppo e il progressivo consolidarsi della sua identità e dei suoi membri è regolata dal codice linguistico utilizzato per comunicare (Q16, 10-12).
Parlare di codice riporta alla concezione secondo cui vivere è «interpretare», a partire da alcune precomprensioni, per dare un volto ai fatti della vita quotidiana (cf 2.2.1.).
Per costruire un gruppo occorre allora fornirlo di un codice di interpretazione della realtà. Man mano che il gruppo procede deve consolidare il suo codice, da una parte rendendosi consapevole degli slogan, frasi che ritornano, vocaboli-simbolo, gesti significativi, appuntamenti non dilazionabili...; dall'altra «inventando», dentro il continuum che è la biografia del gruppo, nuovi slogans, frasi, gesti simbolici, norme di appartenenza e comportamento.
* La vita del gruppo è regolata in secondo luogo dalla rete di comunicazione che viene a stabilirsi all'interno e nei confronti dell'esterno (Q16, 12-14). La rete di comunicazione regola il flusso delle informazioni, rispecchia il «gioco del potere» nel gruppo, determina il grado di gratificazione dei singoli.
L'animatore è chiamato, utilizzando gli opportuni strumenti forniti dalla dinamica di gruppo, a conoscere personalmente lo schema e i canali di comunicazione nel gruppo per poi farli evolvere verso uno «schema stellare» che rappresenta le organizzazioni democratiche ed autogestite come il gruppo di animazione.
* La terza funzione che regola la vita di un gruppo è la memoria, cioè l'esperienza che accumula nel tempo attraverso le varie esperienze (Q16, 14-15).
La memoria non è un semplice «archivio» in cui è depositato il sapere del gruppo, ma è ciò che regola la sua capacità di adattarsi al mutare delle situazioni, inventando se stesso nella fedeltà alla propria biologia.
La memoria può coagularsi attorno a un libro, un documento scritto dal gruppo agli inizi della sua vita, un personaggio carismatico, una storia esemplare, un ambiente caro a tutti...
L'animatore è un custode della memoria: ne conosce i contenuti e la progressiva integrazione tra gli elementi, ma soprattutto è capace di riattivarla periodicamente davanti allo stesso gruppo.
Diventano importanti, di conseguenza, tutti gli strumenti che permettono al gruppo di consolidare la sua memoria, riattivarla nei momenti cruciali, riscriverla per far fronte alle nuove situazioni.
Strumenti relativi alle leggi della comunicazione nel gruppo
Una seconda preoccupazione è relativa alle leggi della comunicazione del gruppo, viste da una precisa angolatura (Q16, 16-24):
- come si svolge la comunicazione nel gruppo;
- come influisce sui singoli membri e sul loro comportamento;
- come produrre «cambiamenti» creativi nella vita del gruppo;
- come, infine, deve regolarsi l'animatore per uno sviluppo di una comunicazione democratica, capace di condurre il gruppo verso gli obiettivi che si prefigge.
3.5.2. Gli strumenti del linguaggio umano
L'animazione si interessa del linguaggio da due punti di vista: come obiettivo e come strumento.
È in primo luogo una sorta di educazione linguistica: abilitare a comprendere e utilizzare i vari linguaggi umani, riconoscendo la specificità di ognuno e il loro complemento.
Allo stesso tempo il linguaggio è uno strumento di cui l'animazione si serve per svolgere il suo servizio.
Si è già visto che «l'unità di lavoro» dell'animazione è l'esperienza, che, però, non viene vista come puro e passivo sperimentare, ma come interazione tra vissuto personale e memoria collettiva, attraverso la mediazione del linguaggio.
Fare animazione è aiutare a dire una parola, pronunciarsi, esprimersi, collocare in strutture linguistiche, interpretare e progettare a partire da una consapevole visione della vita (Q5, 20-24; Q6, 10-15). Prima che dei contenuti linguistici, l'animazione si preoccupa di creare nelle nuove generazioni abilità linguistiche. Prima che a far leggere molti libri l'animazione è impegnata a insegnare a leggere. Prima che ad elaborare particolari contenuti, l'animazione insegna a elaborare e parlare (Q7, 20-23).
Dal punto di vista operativo tutto questo si concretizza in alcune direzioni precise:
- uso e pratica degli strumenti logico-razionali;
- l'uso di linguaggi simbolici, in particolare la narrazione;
- il ricorso a particolare «tecniche» di facilitazione linguistica.
Uso e pratica degli strumenti logico-razionali
L'animazione si preoccupa di insegnare a utilizzare «strumenti di lavoro culturale» per leggere e intervenire sulla realtà:
- sul piano della lettura della realtà l'animazione privilegia la tecnica della ricerca;
- sul piano dell'interpretazione opta per gli strumenti della presa di coscienza in gruppo;
- sul piano dell'intervento l'animazione fa riferimento alla tecnica della programmazione.
* Per tecnica della ricerca s'intende un conoscere attivo della situazione sociale e politica, culturale e religiosa, in particolare della situazione giovanile, attraverso un contatto il più diretto possibile, ma orientato e guidato da adeguati strumenti di ricerca: interviste, questionari, inchieste, partecipazione osservante, codifica dei dati raccolti, sintesi interpretative...
* La raccolta di dati e l'uso di strumenti scientifici di ricerca non sono fine a se stessi. Vanno integrati con una seconda sene di strumenti, quelli legati alla presa di coscienza in gruppo. I dati raccolti e i problemi che emergono vengono affrontati con la collaborazione di tutto il gruppo, facendo spazio alla diversità di opinione, alla ricerca di punti di vista diversi, al contributo di «esterni» come tecnici o esperti che forniscono piste di lavoro...
Punto d'arrivo è la presa di coscienza, cioè il momento in cui il gruppo, pressato dai problemi, si orienta per una sua interpretazione e giudizio di valore, tale che coinvolga tutti nella ricerca di soluzioni e nuove pratiche di vita.
Strumenti in questa direzione sono le varie forme di discussione in gruppo, tavole rotonde e panel, e tutti quelli che facilitano la presa di decisione in gruppo.
* Una terza serie di strumenti logico-razionali sono quelli legati alla programmazione dell'azione/intervento attraverso cui il gruppo ristruttura il suo modo di vivere, ripensa la sua identità di gruppo, favorisce il cambio nell'ambiente.
L'animazione non vuole moltiplicare le «azioni» del gruppo, ma piuttosto abilitare a pensare in termini scientifici la singola azione, individuando gli obiettivi, mettendo a fuoco strategie e tattiche per raggiungerli, indicando in concreto come deve svolgersi, prevedendo quali percorsi alternativi sono possibili, mettendosi d'accordo su come valutare i risultati.
L'uso di linguaggi simbolici
L'animazione non si limita ad usare strumenti linguistici di ordine logico-razionale, ma fa ricorso a tutta una serie di strumenti di ordine evocativo/simbolico.
Il ricorso a questo tipo di strumenti è necessario per abilitare i giovani a riconoscere e dare attivamente un senso al loro esistere.
Solo i linguaggi simbolico/evocativi, infatti, permettono di accedere al senso profondo e indicibile della vita umana.
* La valorizzazione di «situazioni» simbolico/evocative (Q6, 14-15). Del linguaggio simbolico sono parte anzitutto alcune situazioni ed eventi nella vita di gruppo, in cui al centro non sta più il che fare ma il «chi siamo». In questi momenti il gruppo vuol dire anzitutto la sua identità, il come percepisce la vita e il suo senso, quali sono gli interrogativi che rimangono sempre aperti dopo ogni plausibile risposta.
L'animazione riconosce queste situazioni, ne afferra la valenza simbolica, ne valorizza la portata educativa, le utilizza nel suo lavoro con i giovani.
Ricordiamo velocemente alcune di queste situazioni simboliche:
- il gioco nella sua gratuità, visto come fine a se stesso, che «anticipa» un modo nuovo di vivere, rapportarsi, darsi limiti e regole per «giocare la vita» (Q6, 20);
- gli spazi e tempi di silenzio e distacco dalla routine quotidiana, non come spazi e tempi vuoti, ma come casse di risonanza in cui si medita sulle «cose della vita» alla ricerca di un senso trascendente (Q6, 21-22);
- le feste, la domenica anzitutto, come momento in cui si dice il «credo comunitario», ci si diverte con gli altri, si celebra insieme perché solo nel rito certe intuizioni sul senso possono dirsi adeguatamente (Q6, 22-24);
- i riti e le celebrazioni di tipo religioso (in particolare cristiano), che conducono il gruppo alle soglie dell'incontro con il «di più» di senso che gratuitamente pervade la storia dell'umanità.
L'animazione intravede in queste situazioni simboliche un modo di conoscere globale, non riducibile a discorsi concettuali, in cui «ciò che non si può dire si mostra». Tali situazioni chiedono al soggetto che le vive di «uscire da sé », fare un'esperienza che eccede il visibile, per «vedere l'invisibile».
La valorizzazione dei linguaggi simbolici. Al di là e dentro le situazioni-simbolo, l'animazione utilizza le varie espressioni del linguaggio simbolico-evocativo, che fanno ricorso al racconto, alla metafora e all'immagine. Ne ricordiamo di tre tipi.
L'animazione valorizza, in primo luogo, tutti quei linguaggi poetici e artistici che accedono all'indicibilità della realtà e la vogliono, in qualche modo, far toccare con mano. Solo la poesia e l'arte e la loro comprensione dilata nel giovane certe percezioni, sensazioni, intuizioni e godimenti del reale e del suo senso profondo.
Di conseguenza, l'animazione moltiplica le occasioni in cui i giovani possono fare della poesia e dell'arte, preoccupandosi di abilitare a decifrarne i messaggi. Musei e mostre artistiche, teatri e spazi di espressione corporea del senso della vita, cinema e recital non sono puro passatempo ma strumenti educativi.
L'animazione fa riferimento ed utilizza il linguaggio di quei grandi complessi linguistici che sono i «miti» prodotti dalle culture del passato, sia di tradizione occidentale che orientale, e dalle stesse culture moderne, e raccolte in pagine significative come romanzi, libri-simbolo di una generazione, autori rappresentativi di un'epoca e di una filosofia della vita.
A titolo originale l'animazione valorizza i grandi miti religiosi dell'umanità, in particolare quelli biblici della tradizione ebraico-cristiana, che presentano gli «eventi fondanti» della fede cristiana.
Ciò che caratterizza l'animazione non è sufficientemente chiaro dicendo che fa ricorso a linguaggi simbolici, quasi si limitasse a spiegare e far studiare tali linguaggi (Q6, 24-25).
Lo specifico è invece dato dal «contesto» del piccolo gruppo e dal fatto che il piccolo gruppo è luogo privilegiato in cui la comunicazione faccia-a-faccia, dove le persone fanno esperienza diretta l'uno dell'altro e dei propri mondi interiori, è indirizzata alla condivisione esplicita del legame indicibile che tiene insieme il gruppo e del legame che avvince l'intero gruppo all'avventura dell'uomo (Q7. 22-23).
Il contesto è allora quello della «narrazione», cioè della comunicazione di gruppo ogni volta che, attraverso i linguaggi simbolico-evocativi, si viene a creare una sorta di comunicazione triangolare sotto forma di racconto in cui convergono tre racconti e storie:
- la storia narrata che presenta gli «eventi fondanti» dell'esistenza in quella particolare società, cultura, esperienza religiosa;
- la storia di fede del narratore, che si fa testimone di tali eventi (nel nostro caso, l'animatore);
- la storia dei presenti alla narrazione (nel nostro caso, i giovani e i loro bisogni).
3.5.3. Il ricorso a particolari tecniche di facilitazione
Abbiamo visto come l'animazione, tutt'altro che spontaneismo o improvvisazione educativa, richiede di fare ricorso a «strumenti professionali» di lavoro (Q6, 27-28).
Non si deve però confondere un gruppo di animazione che fa una ricerca sugli handicappati in quartiere, con un gruppo di esperti che compie lo stesso lavoro.
La finalità dell'animazione è sempre a servizio del gruppo e dei suoi membri. Da questo punto di vista l'apprendimento degli strumenti in ambito di animazione è sempre segnato da alcuni criteri e limiti.
L'animazione ha dovuto inventarsi dei suoi «strumenti di lavoro», quelle che vengono chiamate tecniche di facilitazione.
Le tecniche di facilitazione sono strumenti di lavoro presi a prestito dalle diverse discipline psicosociali interessate a conoscere l'uomo e a intervenire per una trasformazione del reale.
L'animazione li prende, li ripensa per adeguarli alla situazione di gruppo e li offre come suoi strumenti di lavoro.
Da notare, poi, che le tecniche di facilitazione possono riguardare sia il linguaggio logico-razionale che quello evocativo-simbolico.
Il ricorso a queste tecniche è decisivo per l'animatore di gruppo. Egli si rende progressivamente capace di utilizzare le tecniche di facilitazione a proposito di:
* come lavorare insieme: tecniche che aiutano ciascuno a conoscere se stesso e gli altri nel gruppo, a comprendere e partecipare a quel che sta succedendo, a valutare il proprio e altrui atteggiamento nel lavoro di gruppo;
* come far evolvere il gruppo: tecniche per rendersi consapevoli e imparare a controllare le dinamiche del gruppo, lo svolgersi della comunicazione, i giochi di potere, il ruolo effettivamente svolto dai singoli;
* come accrescere l'affettività interpersonale: tecniche di incontro con gli altri, per rinforzare la coesione e la pressione del gruppo, per riconoscere ed essere riconosciuti dagli altri;
* come osservare la realtà: tecniche da usare in gruppo per arrivare a una oggettiva e realistica visione della società, delle istituzioni, dei problemi giovanili...;
* come intervenire nella realtà: tecniche per programmare una strategia di intervento nella direzione prescelta, facendo sì che sia un cammino di gruppo;
* come impostare un'azione di gruppo: tecniche per dare vita ad azioni specifiche, attività all'interno di una strategia già determinata.
3.5.4. La programmazione educativa
Un ultimo decisivo strumento per l'animazione è la programmazione educativa (Q18). Come si è visto, la stessa proposta di animazione è organizzata secondo le grandi tappe della programmazione educativa: analisi della situazione; «scommessa» su alcuni valori e su un progetto d'uomo; ricerca di un obiettivo generale e sua specificazione in obiettivi intermedi; delineazione di alcune strategie; orientamenti di metodo per l'azione...
Ovviamente la proposta a cui si è giunti attraverso tale procedimento è ad un tempo concreta, perché misurata sull'attuale momento culturale e giovanile, e astratta, perché non fa (e come potrebbe, del resto?) riferimento ad ambienti, subculture giovanili e fasce d'età.
Proprio per questo l'animazione fa della programmazione educativa uno strumento privilegiato del suo metodo.
«Fare programmazione» è già una pratica ordinaria per tanti educatori (Q18, 19). Ciò che l'animazione richiede è l'acquisizione di una «competenza specifica» in questo ambito. «Programmare, infatti, non vuol dire andare secondo una moda pedagogica, ma migliorare la propria competenza educativa, verificarsi continuamente sugli obiettivi scelti, rendere intenzionale e quindi responsabile la propria attività, confrontarsi continuamente con la situazione senza cullarsi in una tradizione che ha sempre fatto così».
Non possiamo, in questo contesto, indicare come si fa programmazione e soffermarci sulle singole fasi dall'individuazione del progetto di uomo (e di credente) attorno a cui si vuol lavorare, alla delineazione e specificazione progressiva degli obiettivi, al chiarimento del metodo e dunque delle strategie e degli interventi, alla valutazione conclusiva che rilancia una nuova fase di programmazione. Per questo rimandiamo al Q19.
Ci limitiamo a insistere su un aspetto particolare: il passare dal «fare progetti» a elaborare «itinerari».
Globalmente si può dire che un «progetto» educativo risponde ultimamente alla domanda: quale tipo di uomo si vuole raggiungere con questa azione educativa?
Da tempo educatori ed operatori di pastorale giovanile hanno elaborato e rielaborato questo tipo di «progetto».
Un lavoro prezioso che richiede di andare oltre, per non disperdere le energie concentrate nel progetto.
Con «itinerario» si esprime «il cammino di trasformazione e di crescita che compie un soggetto a seguito di un intervento educativo. In altro modo, con itinerario si esprime la pianificazione operativa che l'educatore-animatore formula per il conseguimento di tutti quegli obiettivi che sono stati formulati nel momento del progetto... Senza un itinerario, una programmazione educativa risulta non solo incompleta, ma anche irreale» (Q19, 22-23).
Un itinerario si distingue da un progetto per il fatto che gli obiettivi non sono indicati come finali. Esprime il progetto in termini di progressività, specificato in contenuti, esperienza, tempi.