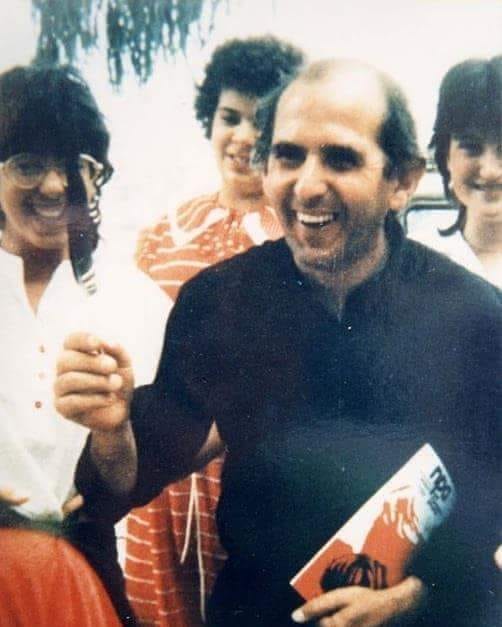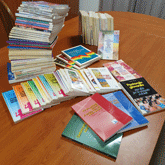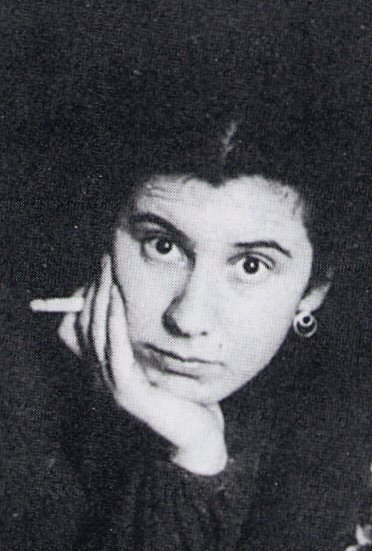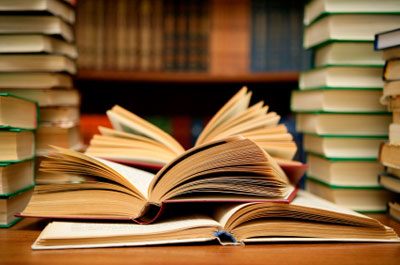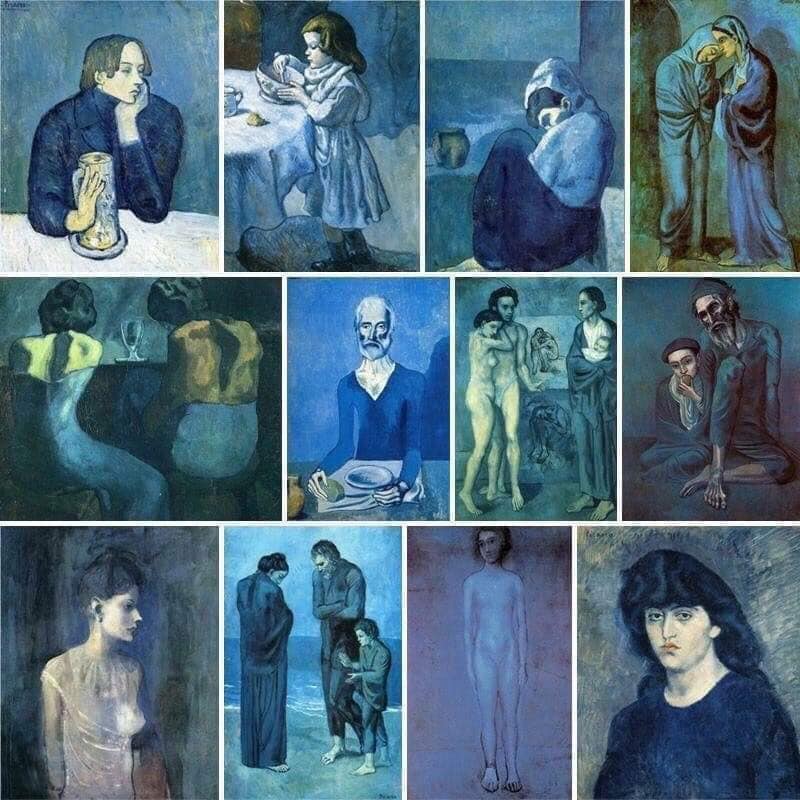Antonio Martinelli
(NPG 1983-5-25)
Ciò che accade nella profondità del nostro essere
è degno di tutto il nostro amore.
(R.M. Rilke, Lettere al giovane poeta).
1. PREMESSA: DALLA PARTE DELL'EDUCATIVO
Delimito, innanzitutto, l'ambito dell'intervento: escludo dalle riflessioni che proporrò ciò che chiamiamo i contenuti, l'oggetto dell'impegno pedagogico, e mi soffermo sul come educare, descrivendo cioè il processo che sottostà alla preoccupazione educativa e che offre il quadro indispensabile di riferimento per operare in modo efficace nei confronti degli obiettivi che ci si propone e in modo corretto da un punto di vista formale e di scienza. Mi muovo dentro le coordinate disegnate dall'articolo precedente di Riccardo Tonelli. L'incarnazione è insieme «contenuto», «criterio» e «orizzonte».
Come evento esprime il contenuto fondamentale e principale della fede; come criterio riporta al quotidiano il momento unificante della pastorale; come orizzonte interpretativo della vita afferma tutta la dignità dell'umano, che ha una sua particolare e riconosciuta consistenza.
Superare lo scollamento tra «spiritualità» e «vita quotidiana» esige di non porre i due elementi di rapporto né in divergenza e incompatibilità, quasi che il primo escluda il secondo e quest'ultimo sia incapace costitutivamente di aprirsi al primo; né in parallelismo o in semplice giustapposizione, perché significherebbe indifferenza dell'una rispetto all'altra fino alla incomunicabilità vicendevole, con conseguente sdoppiamento nella propria esistenza. Ne va di mezzo la personale, individuale e comunitaria, identità, tanto sul piano umano quanto su quello cristiano. Alla mancata identità si collegano, per naturale derivazione, il senso di frustrazione e il senso di affaticamento.
Il senso di frustrazione è generato dalla costatazione dell'inutilità della vita per la spiritualità e dell'insignificanza del quotidiano. La storia di ciascuno verrebbe compiuta così dai gesti grandi ed eroici, dai momenti sublimi, dalle circostanze eccezionali. Il quotidiano è così banalizzato e svuotato di senso.
Il senso di affaticamento si esprime come ricerca impossibile di raccordi tra sfere separate; e quando si riesce a provocare contatti, questi sono destinati a rimanere superficiali e senza interazioni significative e concludenti: un dialogo tra persone che parlano lingue diverse.
L'intervento si pone al crucivia dei problemi sollevati per tentare di capire «come educare oggi all'identità i giovani», a partire dalla vita, dal quotidiano, dall'esperienza delle cose, delle azioni, delle persone che riempiono una comune giornata, una come le molte di tanti, di quasi tutti i giovani.
Nel racconto di J. Moltmann, il giovane povero e disoccupato di Kalamazoo[1] cerca inutilmente lontano la sua felicità che è nascosta nella sua capanna, sotto il suo letto. Non le grandi e leggendarie imprese in terra straniera costituiscono la realizzazione soddisfatta e riuscita di ciascuno, ma la paziente ricerca nell'ordinario che si ritrova dietro l'uscio di casa, anzi dentro il proprio essere e il proprio vivere.
La tensione della vita cristiana è espressa bene dalle coppie «conoscere/credere», «argomentare/narrare», «essere/divenire» che racchiudono anche l'itinerario educativo per una spiritualità adatta al momento presente.
Perciò intendo privilegiare l'aspetto formale del processo educativo che fonda l'identità.
2. SPIRITUALITÀ COME IDENTITÀ
«L'essere cristiano ha un rapporto essenziale con l'integrità dell'uomo: essere santi, significa essere sani e salvi, "interi", integri.
Ciò non riduce l'essere cristiano al solo essere umano, deriva però dal fatto che l'essere-cristiani non si realizza se non nel tessuto concreto della storia umana. L'assoluto della fede cristiana in Dio si manifesta dunque necessariamente nei fatti particolari e relativi della storia, nell'umanità storica, senza che per questo "essere uomini" e "essere cristiani" si identifichino. Chi cerca l'esperienza dell'assoluto allo stato puro non lo incontrerà mai: seguirà gli idoli...
L'assoluto non si manifesta se non nelle grandi e piccole azioni umane di tutti i giorni. È lì che appare come ciò che riguarda gli uomini riguarda Dio, e ciò che riguarda Dio riguarda gli uomini nel contesto ampio e stretto delle nostre vite di uomini e delle nostre comunità».[2]
L'affermazione comporta alcuni ridimensionamenti in fatto di spiritualità: tento di esplicitarli, perché li pongo quale supporto all'intera trattazione.
- È richiesto il passaggio dalla spiritualità concepita come un dato universale e permanente, a spiritualità come riformulazione continua dentro un contesto storico e culturale in movimento.
- La spiritualità non può essere considerata unicamente come impegno individuale e disincarnato, mettendo completamente tra parentesi tutto ciò che comporta una convivenza in uno spazio e in un tempo determinati, con la concreta possibilità di verificare e misurare rapporti e convenienze.
- La spiritualità non può essere confinata in momenti privilegiati, con la conseguente esclusione di larghe zone dell'esistenza, ma ha bisogno di essere riportata nel suo più naturale contesto della vita quotidiana, perché sia un fatto di esistenza e non un'appendice, per quanto nobile.
- Una caratteristica importante diviene, in conclusione, il poter considerare la spiritualità un vero apprendistato superando la semplice categoria dell'apprendimento, dal momento che è un'esperienza e una comunicazione vitale.
In poche parole, l'affermazione fondamentale è la seguente: spiritualità e identità si richiamano, si sostengono, si definiscono vicendevolmente.
Parlare di spiritualità è parlare dell'identità personale.
Educare ad una spiritualità è aiutare l'identità di una persona ad esprimersi con coscienza e con responsabilità.
Lo studio della formazione e del consolidamento dell'identità è perciò preliminare e fondante ogni intervento che curi contenuti e obiettivi della medesima.
L'aspetto formale del processo, da riconoscere e da favorire, costituisce il primo passo, ineliminabile.
2.1. Il processo schematico dell'identità
La chiarezza nella presentazione dei vari passaggi ed elementi impone un'analisi dettagliata di aspetti che sono profondamente collegati tra loro.
Di fronte ad una persona viva toccherà operare al rallentatore e come in laboratorio. Situazioni vissute in una breve frazione di tempo avranno bisogno di molte parole, a spiegazione di quanto si sta verificando.
Affermare di trovarsi di fronte ad una persona viva comporta riferirsi, in modo più o meno conscio, ad un contesto culturale, fatto di tradizione e di storia presente.
Nessuno vive senza affondare le proprie radici in un passato; non è poi completamente passato, perché rivive sotto varie forme di comportamenti e di organizzazione pratica degli strumenti per crescere insieme ad altri.
Nessuno può vivere senza inserirsi in un contesto di relazioni e di comunicazioni: si ricevono delle offerte dagli altri, mentre si presentano loro delle istanze.
È nello scambio di un dare e di un ricevere che ciascuno trova l'equilibrio della propria esistenza.
Nessuno può vivere senza proiettarsi in qualche modo in un futuro, e lo prepara utilizzando tutte le risorse che ha a disposizione, nella prospettiva di una continuità della propria persona, del rafforzamento della propria identità.
Raccolgo in una presentazione schematica e visiva il processo dell'identità nelle singole fasi di cui si compone, commentando il senso delle articolazioni.

Lo schema riproduce l'intero processo, umano e cristiano, che descrive l'identità. Inizia quell'analisi che ho chiamato al rallentatore e in laboratorio.
2.2. L'iniziale processo dell'identità
Il termine-chiave: vita quotidiana
Non c'è vita che non sia «quotidiana».
È il tutto: fatti, cose, persone, problemi, esperienze, situazioni, rapporti. Nulla è al di fuori, e corrisponde a ciò che «riempie od occupa o realizza» una giornata.
Non è superflua una sottolineatura: il quotidiano è complesso ed ambivalente. La complessità è insieme sinonimo di ricchezza e di rischio. Ambivalente dice che è «orientabile» alla banalizzazione e alla superficialità, mentre si porta dentro, come seme o già in modo chiaro, tutta una sua «consistenza» e «significatività». Complesso e ambivalente ci riportano non solo alla categoria della presenza fisica, ma anche a quella intenzionale.
Il linguaggio comune confina «il quotidiano» nella rinuncia al progetto, nella chiusura su di sé, nell'appiattimento e nella noia, nel «piccolo mondo» che ciascuno si costruisce in proprio; perde così il senso dell'esistenza, il valore del rapporto con il grande e con il piccolo che ci circonda, con tutto ciò che emerge dall'esperienza. È ridotto a semplice «luogo di consumo», programmando di vivere realmente al di là del quotidiano, perdendo l'occasione di farne «lo spazio unico dell'identità personale», del riconoscersi e dell'esser riconosciuto .
Qui è richiesta l'opera educativa, perché dalla vita quotidiana si faccia emergere la domanda di senso: è il processo di educazione della domanda.
Le tappe fondamentali dell'itinerario da percorrere richiedono di comprendere la vita quotidiana in nuove categorie.
- La vita quotidiana non ha bisogno dell'intenzionalità dell'uomo perché si arricchisca di valore: è questa una scelta precisa di teologia della creazione e della incarnazione.
Quando si parla della «sacramentalità» delle cose, delle persone e delle situazioni si vuole affermare:
a) la possibile utilizzazione della realtà visibile per esprimere una realtà non visibile;
b) la capacità interiore, non soltanto convenzionale, e perciò intenzionalmente aggiunta, di esprimere qualcos'altro da sé;
c) infine, la presenza, anche se solo germinale, della realtà nel segno, del significato nel significante.
- La vita quotidiana non è divisibile in aspetti profani e in aspetti religiosi, se non a livello di tematizzazione.
È la necessaria conseguenza di quanto detto sopra.
«Impariamo che non dobbiamo opporre dei termini per poi affaticarci a riconciliarli: è la realtà umana quella che diventa oggetto di meditazione credente; è quindi l'integrità dell'umano che realizza storicamente il cristiano, senza che il secondo si confonda con il primo, perché lo fa diventare il luogo ove si gioca la scoperta dell'assoluto».[3]
- La vita quotidiana nella sua complessità racchiude anche una categoria determinabile con la coppia problema/mistero. La prospettiva in cui vedere e considerare l'esistenza può essere tanto quella analitica e puntuale, quanto quella globale e profetica.
Intendo dire che i singoli elementi costitutivi dell'esistenza staccati dal resto che li precede e li segue, e privi di un riferimento che riesca a raccogliere una sequenza di piccoli gesti e realtà, fanno o possono fare problema.
Questi medesimi, rivisti alla luce del coinvolgimento personale e comunitario, considerati nella loro globalità, senza perder nulla della loro consistenza, accostati non solo come materiale per la costruzione di sé, ma come servizio degli altri, come libertà trovata nel dono di sé per gli altri, rivelano l'altra faccia più vera, quella del mistero.
Educazione alla domanda: perché?
Le precisazioni sulla «vita quotidiana» giustificano la ricerca e l'esigenza di capire dove si vuole arrivare, di spiegare che cosa avviene concretamente nella storia di ciascuno, di risolvere al positivo l'ambivalenza propria del quotidiano.
Ci sono domande «insidiose» che emergono dalla vita, come l'esperienza comprova: insidiose perché superficiali, indotte, alienanti.
Le prime non nascono dal profondo, da un' identità consolidata. ma dall'immediatezza. Le indotte non sono frutto di libertà e di responsabilità, dell'io personale, ma degli interessi degli altri.
Le ultime si pongono sulla linea della fuga da sé, del ripiego, del consumo senza significato e senza prospettiva.
Educare la domanda è offrire strumenti capaci di fare della vita quotidiana una vita che si interroga e che invoca.
Bisognerebbe a questo punto, per non fermarsi ai soli aspetti formali della questione, considerare la metodologia concreta per far nascere e crescere la domanda della vita: entrare cioè nei contenuti del problema.
La scelta iniziale, il desiderio di non allargare eccessivamente il discorso, la possibilità di reperire indicazioni nell'«itinerario per educare alla fede i giovani d'oggi»[4] mi riportano alla descrizione del processo. Non è superflua una parola che dica il valore di far camminare la vita quotidiana verso le domande di significato e di senso.[5]
Cosa intendere allora per domanda?
- Riportarsi alla «serietà» della vita.
Il quotidiano è ricco di elementi, capaci di far esprimere la persona nei bisogni fondamentali fino all'invocazione verso l'assoluto. Non è ostacolo l'eventuale povertà che uno scorge in sé e attorno a sé; anzi, in alcune circostanze, sarà proprio la finitudine, ritrovata e sperimentata, ad avviare la propria coscienza e l'impegno operativo alla ricerca dell'altro.
- Imparare a «fare esperienza».
La realtà ha tempo e spazio e rischia di restare legata materialmente a contesti superati.
Ha bisogno di ritrovare continuamente «la parola» che la esprime e di conquistare «lo spazio interiore» che la faccia sviluppare.
Altrimenti il quotidiano resta insignificante, senza voce e senza continuità.
- Andare oltre, superando le apparenti opposizioni.
Descriviamo spesso la vita con concetti che Schillebeeckx chiama «gemelli ».
L'autore esemplifica riferendosi alle coppie di concetti come umanesimo-e-cristianesimo, libertà-e-grazia, evoluzione-e-creazione.[6]
Qui «andare oltre» è far scorgere il collegamento reale, saper collegare (riferendomi ad aspetti più immediatamente classificabili nel settore «spiritualità») l'assenza alla presenza di Dio, la croce alla vita, e così di seguito. È aiutare, in altre parole, a ritrovare tratti, segni, indicazioni fondamentali dell'esperienza che camminano nella direzione del Dio biblico.
2.3. Una condizione previa: la solitudine
Abbiamo istintivamente allergia alla solitudine, perché si riempie di spettri, di difficoltà, di vuoto, di paura; è l'immagine ordinaria e quotidiana della solitudine.
Prendo l'avvio dall'intuizione di Henri J.M. Nouwen per riportare il discorso alla identità, alla personalizzazione, alla spiritualità: «Per vivere una vita spirituale noi dobbiamo anzitutto trovare il coraggio di entrare nel deserto del nostro isolamento, trasformandolo con sforzi gentili e persistenti in un giardino di solitudine».[7]
Mi assumo il compito e la funzione da giardiniere per aiutare la fragile pianta della solitudine a mettere radici e a crescere vigorosa.
Perché Dio non va cercato sopra il mondo o al di là delle stelle, come un essere astrale e lontano, cioè come una parte del mondo materiale e naturale.
Bisogna invece cercare Dio nella profondità, il che significa nella direzione del profondamente infinito e inesauribile di ogni esistenza, in primo luogo dell'esistenza umana.
Qui ricorre l'aiuto della solitudine, che fa comprendere come il profondo, dove Dio va cercato, non è affatto una realtà spaziale, ma ciò che investe incondizionatamente il nostro essere, ciò che incondizionatamente dobbiamo prendere sul serio.
Colgo nella solitudine tre funzioni particolari.
La capacità di vedere la realtà nelle molteplici dimensioni
Innanzitutto quelle non oggettivabili, come ad esempio le esperienze della gioia, della felicità, dell'angoscia, della disperazione, dell'amore, del fallimento, della crisi.
La solitudine incoraggia l'uomo a cercare appassionatamente il senso della vita e a prendere sul serio i grandi problemi esistenziali nei quali si è confrontati con la dimensione dell'assoluto e dell'incondizionato.
Offre all'uomo modelli e situazioni di disclosure che favoriscono la comprensione personale.
Nei confronti dell'identità svolge una preziosa funzione di illuminazione e di decisione, in quanto, mentre fa prendere coscienza e possesso di se stessi e conseguentemente degli eventi, svela la propria vocazione.
Nel riconoscimento delle proprie capacità e degli immancabili limiti ci si confronta con gli altri, ci si scorge diversi, ci si accetta distinti ed altri.
La solitudine del cuore, come capacità di percepire e di capire il mondo da un centro interiore in cui regna la quiete, è l'unica possibilità offertaci per essere in ascolto degli altri, in un atteggiamento di recettività che assicura la vera intimità dell'amicizia, la donazione del matrimonio, la disponibilità del vivere insieme.
Utilizzavo precedentemente l'immagine del profondo.
A proposito scrive Tillich:
«L'elemento decisivo nella situazione attuale dell'uomo occidentale è la perdita della dimensione del profondo. "Dimensione del profondo" è una metafora spaziale. Qual è il suo significato quando viene applicata alla vita spirituale dell'uomo e quando si afferma che egli l'ha perduta? Significa che l'uomo ha perduto la risposta al problema del senso della vita: cioè al problema riguardante il donde egli venga, e dove va, il cosa deve fare, il come deve realizzare la sua vita nel breve spazio tra nascita e morte. Tali interrogativi non trovano una risposta. Anzi quando si è perduta la dimensione del profondo, non vengono nemmeno più formulati».
R.M. Rilke raccomandava al giovane poeta:
«Ti prego per quanto è possibile... sii paziente verso tutto ciò che è insoluto nel tuo cuore e prova ad amare le domande per se stesse...
Non cercare ora risposte che non possono esserti date perché non saresti in grado di viverle. E il punto è che dobbiamo vivere ogni cosa. Vivi le domande adesso. Può darsi allora che poco a poco, senza accorgertene, un giorno lontano tu possa vivere la risposta... accetta tutto ciò che viene con grande fiducia e se appena viene dalla tua volontà, da qualche necessità del tuo intimo io, prendila su di te e non odiare nulla».[8]
Il superamento del formalismo
La realtà ha sempre due possibili approcci, almeno.
Una immediata, diremmo oggettiva e verificabile; ed una seconda meno immediata perché più essenziale e non osservabile: è da scoprire.
Il passaggio dall'aspetto immediato a quello profondo è provocato da una parola, da un gesto, da una situazione, da una pausa, che funzionano come comprensione nuova di quanto sembrava già del tutto conosciuto, come indicatore di ciò che è al di là della esperienza immediata.
La situazione in cui si è immersi incomincia a mettersi in movimento, assume profondità, incomincia a chiarirsi, si rompe il ghiaccio, d'un colpo si scopre una dimensione nuova, altra da quella sempre considerata.
La realtà diventa doppiamente eloquente.
I.T. Ramsey per spiegare ciò che accade in alcuni momenti riferisce su una strana situazione.
Prendiamo un party freddo e formalistico, dal quale l'etichetta esclude i sentimenti personali. Tutti si nascondono dietro le parole e i gesti che sono di obbligo in queste circostanze.
Poi d'un tratto la giacca di qualcuno si spacca sulle spalle, oppure qualcuno si siede su una sedia che crolla per terra. Di colpo il formalismo è rotto (il ghiaccio è rotto) e si manifestano i sentimenti umani.[9]
Si entra così in un'altra dimensione.
L'esempio può apparire anche umoristico, ma la lezione che ne deriva è importante.
C'è bisogno, particolarmente da parte del giovane, e in riferimento al quotidiano che è avvertito come routine, che si verifichi questa rottura dell'involucro oggettivo e formale.
C'è da entrare in una logica nuova, capaci di presentarsi come una radicale rivoluzione della vita quotidiana, con la trasformazione della rete dei rapporti, con la creazione di forme nuove di solidarietà interpersonale, con la ricerca di una diversa qualità del vivere.
La funzione della solitudine è questa di rompere il guscio della routine e della formalità.
L'esperienza storica di Gesù fa del deserto il luogo dell'incontro con il Padre, e perciò della scoperta della propria identità e della propria missione, ma trasforma anche la morte e l'isolamento totale della discesa agli inferi in un momento di liberazione nella prospettiva della Risurrezione.
«Con una lenta conversione dell'isolamento in solitudine si crea quello spazio prezioso in cui... potremo accorgerci che al centro della tristezza c'è la gioia, al centro dei timori c'è la pace, al centro dell'avidità è possibile la compassione e che invero, al centro del nostro spiacevole isolamento, si può scoprire l'inizio di una quieta solitudine».[10]
Luogo e momento più confacente alla mistagogia
Il giovane immerso nel mondo attuale, in una situazione personale definita come frammentata e soggettivata, in un contesto che tende a ridurre l'orizzonte dell'esistenza alle dimensioni immediate e sensibili, trova particolare difficoltà a vivere il quotidiano come esperienza di incontro con un totalmente altro da sé.
Le esperienze hanno il respiro corto, come la sua progettualità.
La solitudine potrà aprire ad una nuova mistagogia dell'esperienza.
La solitudine svolge in questo clima una funzione di aiuto, di assistenza, di illuminazione.
In tutte le grandi dimensioni della sua esistenza l'uomo è confrontato concretamente con la problematica dell'assoluto e del mistero.
Sarà importante che non perda i contatti con le sue reali esperienze che lo aprono al di là del suo mondo, lasciandosi disperdere dalla superficialità.
Accenno ad alcune esperienze attraverso cui è possibile arrivare al mistero incomprensibile e irraggiungibile dell'Assoluto quando si è attenti ad accoglierle e ad ascoltarle nelle domande che si portano dentro.
A titolo puramente esemplificativo: l'impossibilità di disporre del futuro, nonostante tutte le forme di pianificazione, apre al mistero di un al di là non facilmente attuabile; il limite della morte sperimentata come povertà definitiva e finitudine invincibile invoca ad una certezza che non perisca; l'assolutezza e l'incompiutezza della comunione umana pur nella ricerca infaticabile si affidano ad una comprensione e ad un amore senza interessi.
La solitudine come impegno ad assumersi responsabilmente il rischio di penetrare nelle personali esperienze rappresenta l'avvio ad una nuova mistagogia.
Sarebbe abbastanza facile a questo punto tirare alcune conclusioni concrete, per richiamare l'importanza del «silenzio», della «meditazione», della «riflessione di approfondimento», della «preghiera di ogni cosa» nei confronti dell'identità personale e della spiritualità dell'incarnazione.
Sono tutti utilissimi strumenti per avviare una sintesi nuova tra azione e riflessione, tra esperienze e vocazione.
2.4. Il processo storico-culturale dell'identità
Il processo d'identità descritto nelle pagine precedenti ha considerato prevalentemente l'individuo, quasi vivesse in una campana di vetro, in un ambiente asettico.
La precisazione indica già che la persona vive in un contesto che è la sua storia, passata e presente; che vive in una relazione di dare e di ricevere, perché è immesso in un ambiente umano e in strutture che lo superano; che vive un processo di identità mentre si progetta, cioè partendo da un centro si costruisce e si ricostruisce continuamente: ciò ha bisogno di essere ora commentato e spiegato.
Il termine di confronto cui dare attenzione è dato dai termini storia e cultura, che connotano immediatamente in modo dinamico il tema dell'identità.
Storia e cultura significano e comportano il riferimento alla personale esperienza così come si è venuta sviluppando nel tempo, con le sue tappe.
La memoria personale è uno degli elementi costitutivi della identità. Il permanere di sé e della propria coscienza nel fluire del tempo è determinante perché gli altri ci riconoscano.
Storia e cultura esprimono un insieme di contenuti di vita, in parte derivati dalla tradizione che rivive nella continuità e in parte emergenti dalle situazioni nuove, dai bisogni sempre diversi, dal confronto tra passato e futuro. L'identità collettiva è costituita dall'accettazione condivisa di questi contenuti, che sono considerati la memoria comunitaria in tempi e spazi variabili.
Storia e cultura si concretizzano in atteggiamenti, comportamenti, modelli, strutture di relazione tipici e in continua tensione.
Ogni individuo immerso in una storia e in una cultura è chiamato a prendere posizione, accettando e rifiutando.
C'è interazione continua tra identità personale e identità collettiva.
Si creano così processi di identificazione, di tensione, di solidarietà che strutturano le persone e i gruppi umani.
Ne nasce un sistema coerente di relazioni e di rappresentazioni che ha un doppio soggetto: l'io e un tu; l'uno e l'altro sia personali, sia collettivi.
In un reticolo così vario di stimoli, come è possibile trovare il giusto posto dove collocarsi per definire la propria immagine? come comportarsi per raccogliere in sintesi tutta l'esperienza e articolarla, a partire da un aspetto più significativo e più efficace? che cosa significa vivere la spiritualità del quotidiano?
Ritornando allo schema visivo, riportato nelle prime pagine, il processo delineato gravita attorno ai «temi generatori», che raccolgono tutta la situazione precedente e la rilanciano nella prospettiva tipicamente cristiana della scommessa della fede.[11]
La funzione pedagogica dei temi generatori
Innanzitutto per la prospettiva di vita che aprono dinanzi a sé.
La qualificazione più importante è nel loro essere «generatori».
Rigenerano l'uomo, trasferendo problemi e difficoltà apparentemente insolubili, su un piano diverso da quello che la logica ordinaria riserva loro.
Spiego più diffusamente.
Abbiamo già incontrato le coppie di concetti gemelli».
Pensiamo per esempio: privato-pubblico, azione-preghiera, vita-morte, corpo-mente, disperazione-senso, razionalità-emotività... e si potrebbe continuare ancora a lungo.
Sono situazioni oggi ricorrenti nella vita dei giovani.
E si tratta di decidersi. La frammentazione, che li investe e li definisce, rischia di fare della vita quotidiana una vita difficile e abitudinaria.
Difficile: perché sottoposta alle molteplici pressioni esterne che limitano la possibilità di decisione personale coerente; e, in secondo luogo, perché c'è la tentazione facile di chiudersi nel privato e nell'individualistico, senza alcuna uscita di sicurezza.
Abitudinaria: perché abbandonata alla circostanza e al caso «è consumata» dalla routine e dall'insignificante; e inoltre perché, nell'impossibilità di reagire, si accettano soluzioni «adattative» di segno negativo.
Tutto ciò è manifestazione di morte, non generatore di vita.
Come fare per scegliere a favore della vita?
I temi generatori aiutano a non fare scelte unilaterali, scelte cioè che ponendosi in contrapposizione con altre, indicano alternative mortificanti e rinunciatarie del positivo che è nascosto nell'altro termine del problema.
Spingono a collocarsi su un altro piano, a utilizzare una logica diversa.
Ecco alcuni elementi della logica dei temi generatori.
- Partire non solo dai problemi e dalle domande che il vissuto continuamente pone, anche perché ci si rende facilmente conto che non ci sono risposte facili a domande difficili, e l'esistenza spesso è costretta a manifestare la sua povertà, le sue paure e i suoi limiti.
Saper partire anche dalle risposte, forse «allo stato nascente», che si ritrovano nella storia di tutti i tempi.
- Privilegiare l'aspetto significativo nei confronti di quello informativo organico. Le «risposte allo stato nascente» manifestano già alcuni nuclei di interessi, capaci di allargarsi sempre più e in tutte le direzioni.
Non si tratta di riferirsi unicamente a nuclei, organicamente collegati e gerarchizzati, ma saper anche avvertire quanto la vita propone, richiede, e genera di novità.
- Porre a fondamento alcune certezze, sapersi giocare su alcune scommesse.
L'utilità del modello educativo dialogico, in primo luogo.
Qui il fondamento è dato dalla certezza che ogni persona, ogni gruppo, ogni generazione sono portatori di valori umani decisivi per tutti, non circoscritti perciò nel ristretto ambito di alcuni privilegiati.
In secondo luogo la necessità di scommettere sull'uomo e sulle sue possibilità di uscire dalle situazioni e dalle domande limite, di dare un senso alla vita e alla storia, compiendo un salto di qualità nel modo di leggere la realtà o di vivere il quotidiano.
Al livello superiore i concetti gemelli non hanno nessuna risposta diretta, ma si sciolgono perché generano un mondo nuovo
L'uomo è cioè rigenerato e capace di inserirsi nella vita con un nuovo stile.
Alcuni appunti sul significato dei temi generatori
Ancora una parola sui temi generatori per vederne la reale portata in fatto di identità.
Sul piano antropologico, sono come dei crucivia tra varie emergenze.
Catalizzatori di domande, rappresentano delle risposte allo stato nascente per i problemi di senso della vita.
Raccolgono quindi le prospettive di fondo i punti di vista ultimi, riorganizzando l'esistenza in modo originale attorno ad alcuni aspetti, variabili da generazione a generazione, non in forma gerarchizzata ed oggettiva, ma in modi legati alla soggettività e alla capacità evocativa ed autoimplicativa.
Si pongono per questo come una scommessa fiduciosa sul frammento, sul seme sul «piccolo e povero», aprendo al futuro. Un domani che nasce dall'oggi totalmente vissuto e sperimentato nell'ordinario e quotidiano, nelle semplici realtà dell'amicizia, della ricerca della pace, della gioia dell'incontro, della paura di vivere, ecc., E a partire da questi livelli ritrovare la fiducia per ricostituire le fila di un impegno che dia senso ed orientamento ai fatti di ogni giorno.
Nasce qui l'intervento educativo; si ritrova qui un ampio spazio per l'educatore, attento ai segni dei tempi e ai temi generatori dell'epoca, per aiutare il giovane a riconoscersi nel nuovo contesto e a riformulare la propria identità e la propria spiritualità.
2.5. Una condizione necessaria: scegliere la cultura della vita
Dell'ampio spazio lasciato all'educatore nel contesto dei temi generatori, considero soltanto l'aspetto necessario che chiamo la cultura della vita.
È un atteggiamento indispensabile nell'adulto e nel giovane, particolarmente in un momento storico come è il presente. Viviamo un trapasso culturale.
Elementi e situazioni, considerati fino a poco tempo addietro intoccabili, sono stati travolti dalla storia e dalla cultura.
La ricerca di una nuova qualità della vita trova numerosi ostacoli, capaci di togliere le forze per proseguire nell'intento. Una ideologia della morte, diffusa in tutti gli ambienti, e che assume mille volti, spinge alla rassegnazione e all'apatia. La speranza è un atto di coraggio.
Diviene un comando. «E seguirlo significa vivere, sopravvivere, perseverare, mantenersi in vita finché la morte non sia inghiottita nella vittoria. Obbedire a tale comando significa: non essere mai rassegnati, né concedere mai rabbiosamente spazio alla distruzione».[12]
Immette in un impegno: a non volersi abituare alla morte prima che venga.
Oggi, ciò significa che vivere è voler consapevolmente vivere. È imparare ad amare la vita, in modo appassionato tale da non potersi abituare più alle forze della distruzione.
È questo l'impegno a vincere l'apatia.
È apatia restar fermi, voler conservare la vita e perciò non osare per paura della morte, per paura di restare delusi. E così l'apatia, nell'intento di voler metterci al riparo dai rischi, ci porta via la vita.
Questa cultura della vita ha volti diversi. Ne richiamo alcuni.
Accoglienza della legge del seme
Significa essere aperti a tutto ciò che introduce nella vita.
Ogni inizio, ogni desiderio, ogni attesa sono carichi di speranza e di futuro. E portano con loro la certezza di un dinamismo, anche se nascosto. Accoglierlo comporta aiutarlo a crescere e ad esprimersi. Non mortificare la vita.
L'angoscia e il senso indeterminato dell'attesa che s'aspettano sempre il peggio, la mestizia come atteggiamento del cuore che non sa vedere, profeticamente, il bello e il positivo in sé e negli altri, non accettano gli inizi, spengono il lucignolo fumigante, non s'interessano alla povertà del bene.
Per scoprire una presenza, soprattutto quando non è rumorosa, ma confusa con l'assenza ed espressa attraverso mediazioni e segni per nulla appariscenti, non basta una comune attenzione, ma è richiesta una nuova passione per la vita.
La sproporzione apparente tra quello che si vede e quello che sarà, tra il segno della presenza e la ricchezza dell'assenza, si allea spesso alla nostra pigrizia e rinuncia così a sostenere la crescita dei piccoli semi sparsi nella vita quotidiana.
La realizzazione nella speranza è una dura ascetica per il mondo contemporaneo. Abituati all'immediato, a misurare l'efficacia dall'efficienza, il valore delle cose dal possesso delle medesime, a pensare al futuro in termini strettamente logici e scientifici con l'esclusione, possibilmente, di tutte le incognite, ci sa di irrazionale e di contraddittorio accettare la vita dalla morte, la ricchezza dalla povertà, la gioia dal dolore, la vittoria dalla sconfitta, la conquista e la crescita di sé dal perdersi senza calcolo.
Apertura al futuro
Non c'è vita dove non c'è futuro.
Non ci potrà essere cultura della vita senza l'apertura al futuro. Questa assume nomi diversi, che evidenziano aspetti particolari a seconda della prospettiva da cui ci si pone.
Così la denominazione: «conversione», come riformulazione del proprio essere ed agire, della propria identità, adattati ai momenti di sviluppo, alle circostanze storiche e sociali.
L'accostamento verbale tra futuro e conversione è giustificato dal fatto che non c'è conversione se non come conversione al futuro.
Chi tenterebbe delle modificazioni e degli adattamenti quando sapesse dell'inutilità della prospettiva, e pensasse al dopo in termini catastrofici e nichilisti?
La fiducia nella vita, che prosegue e che attende un contributo da parte di tutti perché abbia più spazio e più accoglienza, porta alla personale e collettiva conversione, smuove da atteggiamenti e comportamenti radicati, aiuta per rinnovare le relazioni interpersonali e per impostare su basi nuove le strutture istituzionalizzate.
L'apertura al futuro, d'altra parte, è possibile solo quando si ha la forza di riconoscere onestamente il passato e di accettarlo come parte di sé, senza bisogno di autogiustificarsi.
Accettandolo, ci si dispone a cambiarlo, perché divenuto presente nella mia vita possa introdurmi nella novità del futuro. Un secondo termine che esprime questa apertura al futuro è «speranza».
Il discorso sulla speranza non è unicamente cristiano: è certamente un tema carico di «religiosità». Qui lo considero prevalentemente nella sua dimensione di speranza umana, detta anche «speranza primordiale».
È una forza segreta, non ancora tematizzata e poco definita nel suo concreto contenuto, che è come un'inquietudine del cuore, che si trova proteso verso qualcosa che è al di là, oltre, nel futuro ed opera da attrazione e calamita.
Apre l'esistenza dell'uomo ad un compimento più grande.
«L'uomo esiste nel mondo e al di sopra del mondo, nel tempo e al di sopra del tempo, nella storia e al di sopra della storia, poiché ha la coscienza della continuità del proprio io nel suo stesso divenire e perché in tale coscienza implica l'aspirazione ad essere-più-se-stesso».[13]
Non è il momento per una riflessione organica sulla speranza, ma l'occasione propizia per alcune accentuazioni.
La speranza è costitutivamente legata all'uomo come essere in tensione verso una illimitata realizzazione di sé. Influisce sul suo modo di pensare, di conoscere e di volere: è alla base di una immagine della propria vita e del proprio avvenire. Inoltre, attraverso la categoria della possibilità, l'uomo si riformula continuamente, al di dentro di una storia, comprendendo la funzione e la parte che gioca la libertà e i condizionamenti effettivi che subisce come limiti al compimento totale e definitivo di sé.
Luogo e momento più confacente alla mistagogia
Riprendo lo stesso sottotitolo utilizzato a proposito della solitudine.
Anche la cultura della vita ha una funzione di aiuto, di assistenza e di illuminazione. Rappresenta l'ambiente naturale in cui operare più facilmente un processo di identità e di spiritualità.
La cultura della vita, come accoglienza ed apertura, inserita nel quotidiano, nelle esperienze ordinarie che ogni uomo vive, è capace di dare luce alle situazioni opache e pesanti.
L'oggi che non presenta subito le sue credenziali di affidabilità e di identificazione di sé, ritrova il suo orientamento verso il senso ultimo del suo compirsi, illuminato dalla profezia.
Anche le piccole speranze, quelle a corta scadenza che popolano le giornate comuni, non sono indifferenti per la speranza più ampia e più significativa: la esprimono e la compiono, annunciandola nelle timide realizzazioni.
Infine si può anche dire che la cultura della vita è quel denominatore costante che oltre a dar senso permanente alla nostra vita caduca, unifica in una grande esperienza le molte piccole esperienze quotidiane, staccate tra loro.
E in tutto questo c'è già la vita.
Sarebbe possibile tirare alcune conseguenze concrete dalla riflessione fin qui condotta, per parlare dell'importanza della «festa», della «sofferenza» e della «croce», dell'«amicizia», del senso della «responsabilità» di fronte alla storia, della «costanza», della «disponibilità», ecc., ecc.
Sono contenuti della vita quotidiana, che un educatore attento saprà valorizzare per crescita personale e collettiva.
3. IDENTlTÀ E FEDE
Il processo d'identità così come è stato descritto nelle pagine precedenti potrebbe essere considerato ormai concluso.
La persona ha trovato il suo posto, la sua giusta collocazione tra passato e futuro; ha preso coscienza della necessaria relazione da stabilire con se stesso, con gli altri, con la storia e la cultura; è entrata in un circolo di dare e di ricevere, di riconoscimento di sé da parte sua e da parte di chi gli vive accanto; si sente impegnata a dare il suo contributo, giocandosi in una «scommessa» che, dando un senso al tutto, organizzando attorno a sé l'insieme degli altri dati a partire da uno più significativo, aiuta a superare le antinomie inevitabili della vita e dell'esperienza quotidiana, traendo da queste le possibilità di vita che contengono.
Ci chiediamo ora: in tutto questo cammino la fede ha un suo ruolo? ha qualcosa da dire e da dare? o rimane completamente estranea? nella formulazione e riformulazione dell'identità della persona è indifferente il contributo che può dare la fede? Ci si sarà resi conto come lo sviluppo della riflessione fin qui condotta, ha inteso non coinvolgere in modo esplicito l'apporto della fede, perché avendo scelto la descrizione del processo formale dell'identità, questo potesse riferirsi a qualunque giovane, non necessariamente ad un credente: ma anche perché la fondazione teologica della proposta «per una spiritualità dell'incarnazione» non richiede in prima istanza un riferimento del genere. È giunto però il momento di ripensare tutta l'identità alla luce dell'Incarnazione, così come è presentata nell'articolo precedente, per cogliere che cosa comporta, sempre in chiave educativa, cioè come educare, il rapporto identità-fede.
3.1. Ripartendo dalla scommessa
Le affermazioni riportate nel contesto dei «temi generatori» hanno bisogno di ulteriore approfondimento.
- Parlare di «scommessa» è parlare dell'uomo con categorie particolari. L'uomo, cioè, è capace di autoliberazione, di autoprogettazione e di autoidentificazione.
Questo processo comporta un impegno su un duplice fronte: quello della interiorizzazione e quello della continua ristrutturazione di sé.
L'interiorizzazione è innanzitutto capacità di portare dentro di sé l'universo simbolico della cultura, farlo proprio nel senso di stabilire relazioni, comprenderlo e comprendersi a partire da questo.
È inoltre la capacità di rendersi indipendente dal sistema e di produrre autonomamente quanto prima si era recepito in modo piuttosto passivo. È alla base perciò dell'identità adulta.
La ristrutturazione continua di per sé riporta ad una situazione di conflitto che evidenzia d'altra parte l'identità acquisita. Ristrutturarsi è possibile sia in modo globale, unificando tutta la propria esistenza attorno ad alcuni nuclei portanti che definiscono l'identità, sia in modo segmentato, creando all'interno di ogni settore dell'esistenza una sufficiente unità, una consistenza tale che salvi l'identità della persona.
«Scommettere» non è chiudere gli occhi di fronte alle reali difficoltà, ma è credere che la povertà, il limite, la stessa frammentazione possono essere inserite ed assunte in un processo di identità.
- Parlare di «scommessa» non è fare un discorso di tipo psicologico, quasi un abbandono emotivo o una decisione volontaristica di correre alcuni rischi. Non è da collocare a questo livello la «scommessa», ma a livello esistenziale. È di tipo filosofico, in altre parole, e rappresenta l'atto di coraggio che, coinvolgendo, matura.
Si scommette sulla vita, come luogo privilegiato in cui cercarsi e costruirsi, a patto di viverla continuamente in profondità, e di non accontentarsi di sguardi superficiali.
3.2. Dalla scommessa antropologica alla prospettiva della fede
L'identità di cui ho presentato il cammino è già identità cristiana, almeno implicitamente, in forza dell'evento dell'Incarnazione.
Tutto l'aspetto di umanizzazione contenuto nella descrizione del fondamento iniziale dell'identità esprime a sufficienza l'orientamento e l'apertura all'Assoluto.
La domanda di senso, che sottostà ad ogni passaggio, si porta dentro implicita, ma spesso anche esplicita, l'invocazione al trascendente, e ricerca oltre lo stretto orizzonte dell'immanente.
Il formulare la propria identità nel contesto della storia e della cultura in cui siamo immersi, a partire da un tema generatore che condensa la scommessa sulla vita, è accettare ancora una volta l'invisibile manifesto nel visibile, il tutto espresso dal frammento, l'unità vissuta nella molteplicità: in una parola, la ricchezza del quotidiano «sacramento» del cristiano.
Dire in questo caso «sacramento» è affermare, da una parte, tutta l'autonoma consistenza della vita quotidiana e, dall'altra, il suo essere «già» in rapporto ad un «non ancora».
Ci si chiede: come entra la fede in questo processo?
La riflessione sceglie, coerentemente con quanto precede, l'aspetto formale dell'interrogativo, senza addentrarsi negli aspetti contenutistici e di metodologia operativa.
La risposta si articola in proposizioni distinte.
Innanzitutto, «se le cose stanno così, questa dimensione religiosa della vita umana attende la sua formulazione espressa o la sua articolazione confessionale, come del resto attende la sua celebrazione liturgica perché infine questo mistero trovi, in seno a circostanze mutevoli, la sua traduzione umana tangibile in una prassi riconoscibile come prassi del Regno di Dio».[14]
C'è da precisare che quest'ultimo aspetto, di cui stiamo trattando, non è da considerare come ultima tappa di un processo già compiuto, quasi che si aggiunga come appendice o che arrivi alla fine con compiti ispettivi aperti anche allo stravolgimento e capovolgimento delle battute precedenti.
Se fosse una semplice appendice, una tavola fuori testo, risulterebbe assolutamente inutile, oltre che inefficace.
Se fosse una supervisione aperta ad ogni imprevisto, renderebbe insignificante ogni tappa precedente.
Si presenta invece come chiave di interpretazione di ogni momento dell'itinerario, dall'inizio alla fine, dalla vita quotidiana alla scommessa antropologica.
Chiave di interpretazione significa che mentre la fede si fa interpellare dalle diverse situazioni concrete, si fa giudizio critico delle medesime.
Si trova dentro le cose per farsi misurare da esse, ed è dentro la realtà per poterla ricollocare nel giusto contesto e nella relazione più appropriata con gli avvenimenti e con l'evento che è il Cristo incarnato.
La zona educativa è ampia, per aiutare a far percepire come il nostro Dio non è né invisibile né visibile, ma è «sacramento». Come muoversi?
3.3. Una prospettiva feconda: la dimensione simbolica dell'esistenza
Un dato scontato da riscoprire
Parlare di simboli, simbolismo, dimensione simbolica dell'esistenza è riferirsi a dati di vita quotidiana continuamente presenti nel linguaggio e nell'attività. E meno familiare invece la riflessione che indichi valori e prospettive legate al mondo del simbolismo .
Che cosa è un simbolo?
«Il simbolo non vuole essere una speculazione su Dio o la spiegazione oggettivistica della situazione dell'uomo nel mondo; esso vuole svelare il significato profondo della vita umana e fondare i rapporti che l'uomo deve intrattenere con la creazione e con il mondo divino che le conferisce senso».[15]
C'è da concludere, perciò, che il simbolo non è un elemento più adeguato rispetto al concetto quando ci si riferisce a Dio; ma è un elemento che svela la solidarietà tra le strutture dell'esistenza umana e le strutture cosmiche, trasponendo l'uomo nella sfera della relazione con Dio.
Il simbolo vero e proprio, muovendo dal concreto sensibile, raggiunge il livello spirituale in una continuità di movimento: dalla percezione di una realtà sensibile, addirittura comune, al livello più spirituale della conoscenza di Cristo.
Parliamo di simbolo quando una forma sensibile diventa portatrice di una pluralità di significati che corrispondono ad una pluralità di livelli di vita.
Sottolineo l'importanza della continuità del movimento simbolico, perché offre spunti sul piano educativo, quando bisognerà far agire quel dinamismo vitale che porta la coscienza personale a passare da un livello di vita ad un altro.
La sostanza perciò del movimento simbolico è aiutare a vedere in cose, persone, eventi non più solo categorie e concetti, ma il profondo, il mistero, il segreto sacramento in segni e simboli.
Le funzioni del simbolo nella vita
Una prima funzione più immediata da cogliere è quella rappresentativa: è già contenuta nella definizione stessa di simbolo. Soffermarsi ulteriormente serve per capire la modalità attraverso cui una realtà ne rappresenta un'altra.
L'espressione simbolica è sempre carica di tanta affettività, e questo comporta che:

- il simbolo non sia traducibile in chiave concettuale,
- il simbolo sia percepito da coloro che appartengono allo stesso ambiente culturale,
- il simbolo produca una risonanza attiva nella coscienza dell'uomo, cioè lo renda recettore di nuove relazioni con l'ambiente e creatore nell'esprimere il suo ambiente vitale.
Tutto ciò rende il simbolo molto evocativo.
Un'altra funzione dell'attività simbolica è quella trasformante o unificante in quanto fa leva sulla continuità dei vari livelli di vita.
«Se non vi fosse una certa qual continuità tramite l'unità della coscienza, non si capirebbe la possibilità dell'espressione simbolica. Orbene, tale continuità è il principio di quella unificazione della coscienza alla quale mira l'attività simbolica».[16] L'uomo può dirsi spiritualmente maturo, (usando le parole coerenti con tutto il discorso precedente) e il cristiano può dirsi adulto nella fede, quando diventano capaci di considerare il loro rapporto all'universo attraverso il rapporto con Dio, e il loro rapporto con Dio attraverso il rapporto con l'universo.
Il vantaggio di questa continuità vitale è innegabile. Innanzitutto perché l'attività simbolica ristabilisce un sano equilibrio a pro della qualità della vita, anche di quella cristiana, riducendo la predominanza del razionalismo e valorizzando il sensibile.
Inoltre perché la valorizzazione della sensibilità umana conferisce alla stessa esperienza spirituale una dimensione nuova di ricchezza inestimabile.
«Vi è lo spazio, grande o piccolo, per un'azione di aiuto a tutti, non per estraniarli dai "fatti loro", ma per farli entrare "dentro i fatti, ma fino in fondo". È presupposto però un risorgere nella Chiesa della religiosità profonda, del pensare intuitivo/simbolico, quello per cui non viene neppure in mente di parlare di "coerenza con la propria fede o con i propri principi", ma solo di conformazione a Cristo».[17]
Si noti la continuità del movimento simbolico: la coscienza spirituale usa i sensi corporei per entrare in contatto con il mondo, e dalla percezione di un rapporto particolare con il mondo passa direttamente, cioè senza l'aiuto di un ragionamento o di un paragone elaborato (ad esempio: Dio illumina la mia mente come la luce illumina il mondo), al livello spirituale.[18]
Luogo e momento più confacente alla mistagogia
Tutto il pensare ed agire simbolico, utilizzando le cose, le situazioni, le persone nella prospettiva aperta di realtà «oltre», portatrici di messaggi che superano la materialità del dato, e indicano la direzione di senso, sono strumenti adatti per una mistagogia dell'esperienza.
Veramente per l'uomo tutto può diventare simbolo in cui ritrovare ed esprimere il senso della propria vita.
Il problema reale a questo punto è di natura educativa: come educare alla dimensione simbolica?
A me interessa solo porre l'interrogativo non risolverlo in questo contesto.
Qui il richiamo è orientato a sottolineare l'importanza della dimensione simbolica per l'identità umana e cristiana.
La fede con l'Incarnazione del Cristo offre l'orizzonte interpretativo della vita dell'uomo.
La sua persona, la sua umanità, la sua storia, particolarmente la passione morte e risurrezione, divengono il grande simbolo-sacramento di Dio che condivide la vita e la storia dell'uomo.
La riformulazione quindi della propria esistenza cristiana deve partire dalla memoria e dal racconto di Gesù, signore della vita.
La vita quotidiana illuminata dalla luce del Cristo Morto e Risorto riprende il cammino della sua identità verso ulteriori approfondimenti e coinvolgimenti personali.
4. CONCLUSIONE
Al termine dell'itinerario tornano alla mente le parole del Concilio: «Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo» (GS 41).
Educare alla spiritualità del quotidiano è, in altre parole, celebrare il sacramento.
Ad analizzare, in modo dovuto, la realtà del sacramento secondo la teologia cattolica, si riscopre la doppia dimensione di fedeltà all'uomo da parte di Dio e di fedeltà a Dio da parte dell'uomo.
Il sacramento comporta una reale e reciproca presenza tra Dio e l'uomo.
Alla comunicazione che Dio fa di sé corrisponde l'impegno da parte dell'uomo ad accettare le mediazioni di cui lui si serve. All'invocazione che l'uomo presenta a Dio corrisponde la parola fedele di Dio di «essere con lui tutti i giorni della sua vita».
Educare alla spiritualità del quotidiano è celebrare la comunicazione fedele di Dio e l'invocazione responsabile dell'uomo.
E celebrare la vita donata ed accettata.
Il sacramento primo e più grande, l'originario e il fondante, è il Cristo Signore, nella sua persona e nei fatti della sua vita. Celebrare il sacramento-Cristo è riconoscere il senso ultimo e definitivo della sua presenza nel mondo. Dal giorno in cui ha posto la tenda tra noi, la vita e la storia dell'uomo-Gesù sono diventate il luogo in cui incontrare Dio; la vita e la storia dell'uomo sono il tempio nuovo in cui celebrare la lode di Dio, perché «con l'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo» (GS 22).
Celebrare il sacramento-uomo è celebrare la storia di ciascuno, del singolo.
«L'uomo così com'è "voluto" da Dio, così com'è stato da Lui eternamente "scelto", chiamato, destinato alla grazia e alla gloria: questo è proprio "ogni" uomo, l'uomo il più "concreto", il "più reale"; questo è l'uomo in tutta la pienezza del mistero di cui è divenuto partecipe in Gesù Cristo, mistero del quale diventa partecipe ciascuno dei quattro miliardi di uomini viventi sul nostro pianeta, dal momento in cui viene concepito sotto il cuore della madre» (Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis, 13).
NOTE
[1] J. Moltmann, Esperienze di Dio, Queriniana, Brescia 1981. pp. 96-97.
[2] E. Schillebeecks, Identità cristiana e integrità umana in Concilium 5/1982, p 59.
[3] C. Geffré - J.P. Jossua, L'umano, criterio dell'esistenza cristiana liminare, in Concilium 5/1982, p. 14.
[4] R. Tonelli, Un itinerario per educare alla fede i giovani di oggi, in NPG, febbraio 1981, pp. 3-63.
[5] «Per evitare pericolosi equivoci, ci sembra molto importante distinguere tra "senso" e "significato".
Senso è una conoscenza riflessa e tematica, che investe le ragioni ultime dell'esistenza umana.
Significato è invece una conoscenza parziale e intermedia, rispetto al senso ultimo, raggiungibile attraverso i diversi livelli delle conoscenze umane» (R. Tonelli, o.c., p. 29).
[6] E. Schillebeeckx, o.c., p. 56.
[7] H.J.M. Nouwen, I tre movimenti della vita spirituale. Viaggio spirituale per l'uomo contemporaneo, Queriniana, II ed. 1980, p. 28.
[8] R.M. Rilke, Lettere al giovane poeta, Argalia 1962.
[9] I.T. Ramsey, Il linguaggio religioso, Bologna 1970, pp. 20-22.
[10] H.J.M. Nouwen, o.c., p. 30 e 34.
[11] Si veda il dossier «Temi generatori» nella pastorale giovanile, in NPG, gennaio 1983, pp. 3-31.
[12] J. Moltmann, Esperienze di Dio, o.c., p. 19.
[13] J. Alfaro, Speranza cristiana e liberazione dell'uomo, Queriniana 1972, p. 21.
[14] E. Schillebeeckx, o.c., p. 63.
[15] Ch. A. Bernard, Teologia simbolica, Edizioni Paoline, 1982, p. 59.
[16] Ib., p. 196.
[17] G.C. Negri, Post-fazione, in H. Halbfas, La religione, Queriniana 1983, p. 225.
[18] Ch. A. Bernard, Teologia spirituale, Edizioni Paoline, 1982, p. 187.