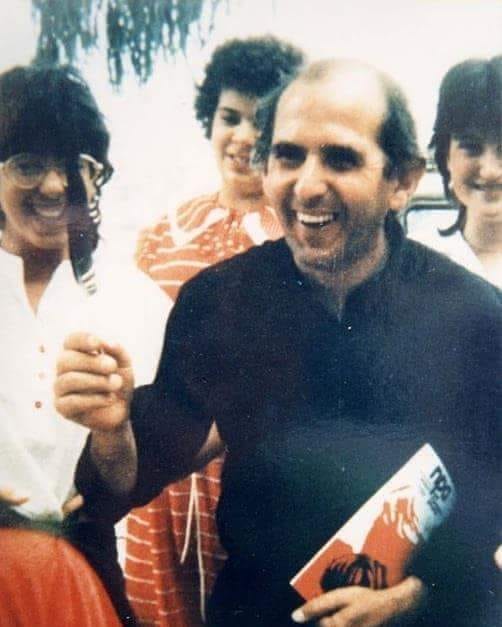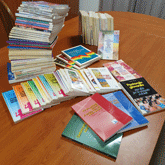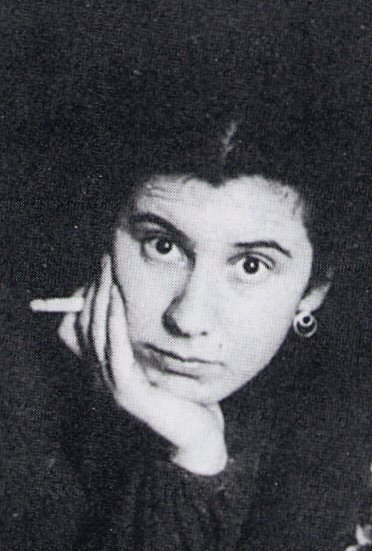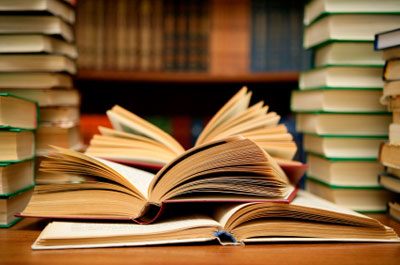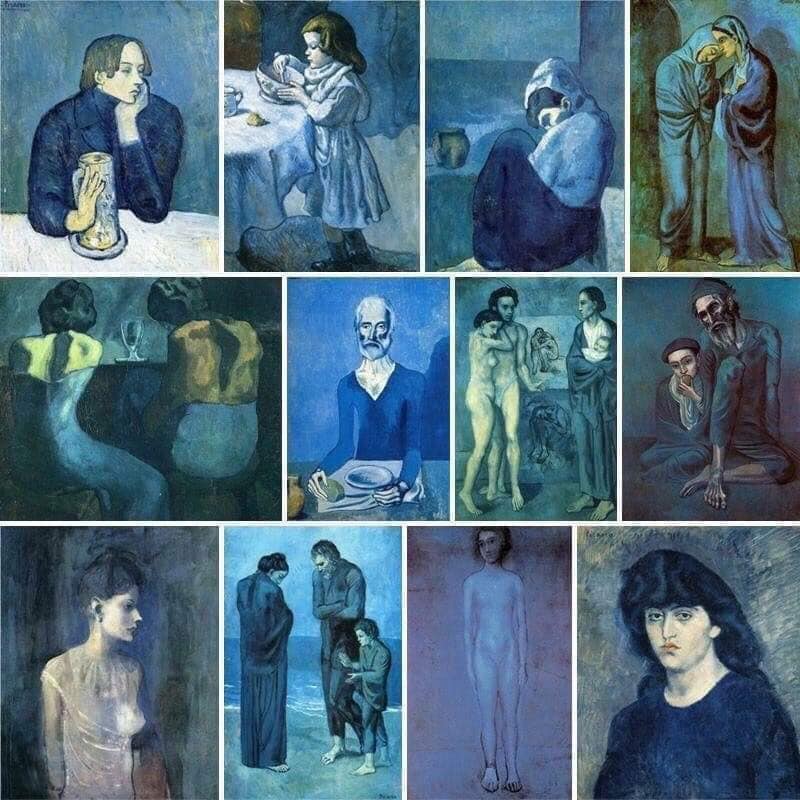Giacomo Grasso
(NPG 1983-4-17)
IN GESÙ NON CI SONO PIÙ GIORNI SACRI E GIORNI PROFANI
Nel discorso della montagna che non è legge ma vangelo, buona notizia, Matteo scrive, riferendole a Gesù, queste parole che seguono di pochi versetti le beatitudini: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto» (Mt 5,17-18).
Sono parole, come tante altre, o tutte, nel Nuovo Testamento, che colpiscono per la loro forza. Talora chi le ascolta rischia di non comprenderle nella loro ricchezza, forse perché non si è sempre disposti, una volta uditele, a «ruminare la Parola». Se, però, vengono ben masticate e pregate, come insegnavano a fare i monaci antichi che non si accontentavano della «lettura» ma passavano alla «meditazione» e alla «preghiera» della Parola, esse manifestano in pieno il loro senso profondo di notizia nuova, buona e sconvolgente.
Ho pensato di introdurre queste pagine di riflessione sulla domenica con un'annotazione del genere perché l'impegno al «precetto festivo» che viene catalogato tra i «precetti generali della Chiesa» e che caratterizza la domenica viene talvolta inteso come collegato direttamente ad un comandamento, il terzo, della Legge antica, quello che in Esodo suona: «Ricordati del giorno di sabato per santificarlo» (Es 20,8).
Se fosse davvero così ci si potrebbe chiedere in che senso Gesù abbia dato un compimento alla Legge e ai Profeti. La Legge avrebbe subito solo un piccolo cambiamento cronologico, dal sabato al primo giorno dopo il sabato, e la polemica dei Profeti nei confronti di applicazioni materiali delle norme del culto legale risulterebbe non accolta da Colui che i Profeti stessi attendevano come realizzatore di un tutto nuovo.
Invece la novità c'è, e Gesù ha davvero dato compimento alla Legge e ai Profeti. Con Lui, infatti, con la sua Pasqua, si è aperto per tutti gli uomini della terra un «sabato eterno», una festa che non ha più fine. Chi crede, ecco la buona notizia, sa che ormai non ci sono più giorni profani e giorni sacri. C'è un unico giorno santo, il «giorno del Signore» che era atteso e si è compiuto e va costantemente, dalla mattina alla sera, santificato.
Poiché Gesù Cristo è risorto, si è aperto ormai un tempo nuovo, un tempo che non ha più confini e che è già, per chi sta ancora pellegrinando sulla terra, manifestazione del Regno, anche se non ancora definitivo.
IL «CENTRO» È CRISTO
Tutto questo va detto, ancora, perché sia chiaro, al di là di ogni possibile riferimento psicologico, o sociologico, o antropologico, o culturale, o anche di scienze delle religioni, che c'è un centro per il cristiano - e per ogni uomo della terra, in qualche modo - ma questo «centro» è solo il vangelo, cioè Gesù Cristo, Colui che ha reso nuove tutte le cose (cf Ap 21,5; 2 Cor 5,17), l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine (cf Ap 22,13), Colui che rende beati quanti lavano le loro vesti nel suo sangue e così avranno parte all'albero della vita (cf Ap 22,14). In questo «centro» tutto riceve compimento: il Tempio che estende la sua maestosa bellezza a tutto l'universo, e non si tratta più di questionare se valga il monte di Samaria o l'edificio di Gerusalemme (cf Gv 4,20-22) perché ormai «i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e verità» (ivi, 23): del resto non ci sono più «luoghi sacri» perché i discepoli vedranno gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo (cf Gv 1,51); la Legge che esplode nelle singole Beatitudini (quelle di Mt, ma anche quelle di Lc, e quelle, straordinariamente vivaci, dell'Apocalisse).
A questo proposito, e per andare ad grande teologo - ben poco conosciuto - san Tommaso d'Aquino, mi limito a ricordare come nella Somma Teologica grande sintesi dell'Aquinate, la vita Cristo non sia presentata in riferimento ai dieci comandamenti della Legge antica, ma in riferimento alle virtù, teologali e cardinali, a ciascuna delle quali viene riferito un dono dello Spirito santo e, a questi, una delle nove Beatitudini di Matteo; e anche, in relazione a quanto sto scrivendo, il Sabato. Questo, l'ho già detto, non perché si è passati, e non abusivamente, da un giorno all'altro, ma perché il tempo stesso è cambiato. Ormai si è nel «tempo di Cristo» che ha anch'esso, come tutto ciò che esiste, un solo nome. Quello che è al di sopra di ogni nome (cf Fil 2,9).
La struttura sacramentale della salvezza
Ciò non significa che la domenica, e sarà detto ampiamente, non possa essere presentata come «centro». Lo può, ma solo se si è ben annotato e chiarito, a noi stessi e agli altri, che uno solo è il centro autentico e che tutto il resto, tutto anche l'eucaristia (per la quale ancora varrebbe ben studiare e ristudiare l'insegnamento di Tommaso d'Aquino checché ne dica il recente e diffuso saggio del Gerken), è importante nel segno, cioè nella sua portata quasi sacramentale, o sacramentale. Va da sé che quando nomino Gesù Cristo intendo «l'immagine del Dio l'invisibile (Col 1,15), e perciò l'immagine e somiglianza perfetta della Trinità.
Forse non ci si riflette abbastanza. Tutta l'economia della salvezza è «economia sacramentale». Lo è nei mirabilia Dei di cui si parla nell'Antico Testamento (a cominciare dalla liberazione dalla prigionia in Egitto, ai momenti dell'Alleanza, alla consapevolezza che anche la Creazione è opera meravigliosa dello stesso Dio dell'Alleanza); lo è nel presentarsi della Parola che si esprime attraverso la voce e la «cultura» dei Profeti. Lo è, e ormai siamo nel Nuovo Testamento, nella stessa Parola che parla nel Figlio (cf Eb 1,1), il Verbo che si è fatto carne ed ha alzato la sua tenda tra noi (cf Gv 1,14a), Lui che è - come già si è ricordato - l'immagine del Dio l'invisibile, il «sacramento fondamentale» di Dio. Lo è nella Chiesa «sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (Lumen gentium, 1), «universale sacramento della salvezza» (ivi, 48). Lo è nei «sette sacramenti» e, in particolare, nell'Eucaristia che è sì presenza reale e sostanziale, ma sacramentale, e dunque «nel genere del segno» del corpo e sangue del Signore Gesù effuso per la nostra salvezza. Eucaristia che nella sua realtà profonda dice «l'unità e la carità della Chiesa» (Tommaso d'Aquino).
L'uomo ha bisogno di sacramenti
Dicevo che forse non vi si riflette abbastanza. Perché tutta l'economia della salvezza è un'economia sacramentale? Tommaso d'Aquino giustifica i sacramenti annotando che solo attraverso ciò che è visibile e toccabile si giunge a ciò che è intelligibile e spirituale; e ancora rivelando come sia importante che le stesse realtà concrete che allontanano da Dio siano quelle che accompagnano a Dio; e infine osservando che l'uomo, abituato com'è alle realtà concrete, ha bisogno di «esercizi corporei, nei sacramenti», altrimenti cadrebbe facilmente nella superstizione. Tutti questi motivi possono essere assorbiti in un altro che, mi sembra, li accolga, e dia loro un significato ancora più alto. Tutta l'economia della salvezza è sacramentale perché il piano di Dio è assolutamente rispettoso dell'uomo, creato da Dio e da Dio voluto così, intelligente, volitivo, corporeo, libero di una «umana libertà». Tale umana libertà non si darebbe se le strade offerte da Dio sapessero del «tremendo» della divinità che si manifesta. Il Signore ha scelto di parlare nella brezza leggera (cf 1 Re 19,12).
Questa scelta è evidente in Gesù nel quale si intravvedono i tratti del Servo sofferente del Secondo Isaia (cf Is 42,1 e ss.), uno che è venuto per servire e non per essere servito (cf Mc 10,45), uno che sta in mezzo a noi come colui che serve (cf Lc 22,27), un Maestro e Signore che lava i piedi ai suoi (cf Gv 13,1 e ss).
Detto questo, e avendo allora ben chiaro che il «centro» è l'evangelo, cioè Gesù Cristo, cioè il Figlio di Dio, vero Dio, seconda persona della Trinità, vero uomo (il che significa ancora che il centro, per dir così si sdoppia: è Dio ed è l'uomo, con conseguenze sulle quali occorre riflettere), si può passare a parlare della domenica, nella sua portata quasi-sacramentale di «centro». Ho, però, appena detto che il centro «è Dio ed è l'uomo», e che tutto questo dà origine a conseguenze sulle quali riflettere. Riflettiamoci un po' perché si è in ciò che dà senso al resto, anche alla domenica.
Cristo, un centro che riunifica umano e divino
In Gesù Cristo, vero Dio e uomo perfetto, ci viene fatto conoscere il Padre (cf Gv 14,9). In Gesù, dunque, il Signore Iddio prende un nome familiare, Abba, papà, pronunciabile perché lo Spirito è in noi (cf Rom 8,15) e che richiama quell'amore pieno di tenerezza cui si dà il nome di «misericordia». In Gesù, allora, si supera quel confine altrimenti insuperabile che separa il divino indicibile dall'umano.
Gesù, però, è anche l'uomo perfetto, il nuovo Adamo (cf 1 Cor 15,45). Anche questo «uomo perfetto» è «centro» per il credente. Ancora una volta ci aiuta la riflessione di Tommaso d'Aquino che dopo aver parlato di Dio, della Trinità e della Creazione (degli Angeli, dell'universo e dell'uomo) ci parla dell'uomo che ritorna a Dio, e vi torna puntando alla Beatitudine somma attraverso una vita virtuosa, e attraverso il sostegno in qualche modo esterno della legge naturale e della grazia che è grazia di Cristo.
La nostra umanità chiede di essere considerata un «centro» al quale va offerta tutta l'attenzione necessaria. Saranno, in particolare, nel clima della grazia, cioè nel clima della stessa vita divina partecipata alla creatura umana, le virtù teologali (fede, speranza e carità) e quelle cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza), coi doni dello Spirito santo e con le Beatitudini consegnate a chi vive in Cristo, a fare dell'uomo un Uomo autentico. Autentico perché nuovamente, cioè in Gesù Cristo che rende nuove tutte le cose (cf Ap 21,5), «immagine e somiglianza di Dio», come nella Creazione (cf Gen 1,26-27).
La domenica tra memoriale e precetto
Detto questo ripensiamo la domenica.
Si chiama così perché in essa viene celebrato il «dominicum», cioè il memoriale della Pasqua di Gesù Cristo che ha sostituito per sempre la Pasqua degli Ebrei che della Pasqua del Signore era solo un segno, un'attesa. «Dominicum» è un aggettivo latino che deriva dal sostantivo «Dominus», il Signore. Con questa espressione (in ebraico Adonai), l'Israele antico denominava Jahvè, nome non pronunciabile col quale il Dio di Abramo, di Isacco, e di Giacobbe si è manifestato, nel roveto ardente, a Mosè (cf Es 3,14). I credenti l'hanno usato per Gesù, riconoscendolo così come Dio.
Nel giorno dopo il sabato, cioè nel giorno della risurrezione, in quel giorno che il mondo chiamavano «del sole» (questo anche nel mondo «barbarico»: le lingue anglosassoni chiamano le domenica sunday o Suntag da sun, sole), i cristiani hanno cominciato a riunirsi per l'Eucaristia. Se ne hanno antichissime documentazioni. Storia ispezionabile, quella della domenica. Storia che ad un certo momento, per il rilassarsi della vita delle comunità, ha anche richiesto interventi specifici che hanno portato al «precetto». A cristiani poco impegnati è stato imposto, in un clima culturale certo molto diverso dall'attuale, di «andare a messa alla domenica».
Un'imposizione ha senso per i seguaci dell'evangelo? Le «imposizioni», piaccia o non piaccia, hanno sempre un senso, perché noi uomini, anche se resi nuovi in Cristo, possiamo da esse ricevere un aiuto alla debolezza della nostra umanità. Hanno un senso, però, solo se non pretendono di essere «salvifiche». Altrimenti fanno piombare nello stile dell'Antica Legge, contestato (e come!) da Gesù nei conflitti coi Farisei, e dal Paolo delle due grandi lettere ai Romani e ai Galati. Se non vogliamo che la pesante frase paolina: «Oh insensati Galati» cali anche su di noi, occorre appunto che evitiamo di dare alle prescrizioni ecclesiastiche che ci aiutano a vivere bene in Cristo una forza che non hanno: quella di salvarci. Ci salva solo, infatti, Gesù. È lui l'unico Salvatore.
Anche ora la nostra santa Chiesa ci domanda di riunirci alla domenica per celebrare il «dominicum».
Ce lo chiede in un ambiente molto diverso, culturalmente, da quello di mille anni or sono, e anche da quello dei nostri bisnonni. Allora, almeno nelle nostre città e nelle nostre campagne si viveva in una civiltà che era di tipo cristiano.
Lo era, ad essere chiari, nel bene e nel male. Sì, anche nel male perché imporre agli studenti universitari, avveniva in molte Università italiane prima del 1848, di dimostrare - per poter sostenere gli esami - di essere andati a messa alla domenica, di aver compiuto il precetto pasquale, di essersi confessati almeno una volta all'anno, di aver partecipato agli «esercizi spirituali», era imposizione che oggi non accetteremmo più (eppure esistono collegi universitari o scuole «cattolici» in cui questo si chiede...), e che in sé è contraria alla dignità dell'uomo, come lo era, nei paesi cattolici il negare l'accesso all'Università agli acattolici, e nei paesi non cattolici negarlo ai cattolici...: son tutti atteggiamenti che non risalgono al Medioevo, ma si fanno sentire ancora a metà Ottocento !
Si viveva in regimi di cristianità che neppure la rivoluzione francese riuscì a demolire. Vi è riuscita la rivoluzione industriale, vi è riuscito, sostenuto dai mezzi di comunicazione sociali, da mille ideologie non cristiane, lo sviluppo economico e, in Italia, quella rapida industrializzazione, e quel rapido benessere che in cinquant'anni hanno profondamente mutato le caratteristiche del nostro Paese.
La situazione è cambiata. La domenica resta.
Resta solo come pausa, in genere ormai col sabato, dal lavoro, o resta come evento che può dire qualcosa, anche pedagogicamente, alla gente di oggi, specialmente ai giovani?
PERCHÉ LA DOMENICA SIA UN GIORNO SIGNIFICATIVO
Dal bisogno di aggregazione al fare comunità
Voglio limitarmi ad una risposta «nella fede». È una risposta, comunque, che non può dimenticare il dato antropologico. È proprio questo che mi sollecita, facendomi notare il bisogno, oggi, di aggregazione. Si tratta di un bisogno d'oggi? Si tratta di un autentico bisogno? Con ogni probabilità è un bisogno non d'oggi, ma di sempre se l'uomo è intimamente sociale, e dunque bisognoso di compagnia, di socialità (societas, società, comunità, compagnia, da socius, compagno). Sta di fatto che è almeno «anche» un bisogno d'oggi. Ed è, per lo stesso motivo addotto, un bisogno autentico. Come tale è abilmente sfruttato dal consumismo. Il viaggio organizzato, per gli adulti, curato nei particolari, ma spesso molto costoso ed eterodiretto; i Rolling Stones che danno spettacolo a Torino e a Napoli; innumerevoli meeting diversamente colorati; l'invito delle Ferrovie dello Stato ai giovani perché viaggino durante l'estate attraverso l'Europa (e poi si incontrano sulle piazze di Londra o di Amsterdam); il Carnevale di Venezia... Tutte iniziative per «aggregare». A questo livello si collocano anche tante iniziative di associazioni culturali e ricreative, o quelle di «estate ragazzi» volute da Amministrazioni comunali apparentemente democratiche (apparentemente perché nell'Europa occidentale sarebbe più consono alle democrazie muoversi in maniera meno accentrata) che puntano agli stessi risultati, anche se non «a scopo di lucro».
Per i cristiani, la domenica. Luogo e tempo di aggregazione da viversi nella dinamica di un «segno» che conduce al «centro» autentico, quello, si è detto, che dice Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Luogo e tempo insieme, o anche solo tempo, sempre però riferiti ad una comunità. Luogo e tempo se si tratta di una domenica «gestita in casa». Nella chiesa, cioè nella domus ecclesiae, nella casa della comunità riunita attorno all'eucaristia, e poi nei luoghi che talora esistono «attorno alla chiesa». Le comunità cristiane del Nord e del Centro Italia hanno al proposito una lunga tradizione di strutture. Dalle sedi delle Confraternite a quelle dell'Azione Cattolica e degli Oratori. Quelle del Sud non le avevano. Ormai però sono anche lì diffuse. Sono o possono essere «centro». Chiedono però alcune attenzioni.
Uno stile liturgico che non sappia di falso
In chiesa chiedono anzitutto momenti liturgici preparati perché la linea portante del rinnovamento conciliare in campo liturgico (e cioè una partecipazione creativa adeguata al tipo di persone presenti) chiede attenzione e stile, a cominciare dall'edificio. Se è antico, spesso nobile per la sua morfologia architettonica, o se è nato prima della riforma del Vaticano II, domanda adattamenti che non possono passare attraverso le banalità poste sul mercato dai venditori di oggetti per il culto. La paccottiglia e il cattivo gusto non aiutano a caratterizzare il «centro». Se lo si sta realizzando chiede d'essere affidato alle cure di architetti di riconosciuta professionalità, studiosamente critici. Altrimenti ci si imbatte in «centri» dove domina solo il falso. Potrei raccontare di una chiesa, costruita a mezza costa di un monte arido dove ormai arriva la grande città, in cui il cattivo gusto ha inserito una specie di fontana, e nella fontana una grande pietra levigata da un fiume (ma il fiume scorre altrove), e un altare bianco come il formaggio e tanto simile, perché sembra si muova, ad un grosso pezzo di stracchino, e una svolazzante Annunciazione (solo la Vergine) fine '600... Se si vuole un «centro» non ci si indirizzi a chi offre solo tipologie di edifici tanto simili a quelli che si incontrano lungo le strade delle regioni ricche di mobilieri.
Lo stile è richiesto anche alla musica e al canto. Anche per essi potrebbe valere il monito del card. Lercaro per l'arredo: «Un pezzo solo, opera di buon artista o, almeno, di valente artigiano». Chi ci ha preceduto nella fede lo sapeva e ha realizzato, spesso proprio per la gestione di quel centro che era, ed è, o può essere, la domenica, oggetti architettonici, e arredi di gran classe. Oggi si procede troppo spesso senza quello spirito critico che un tempo era supplito da un distillato autentico di cultura secolare. Così si vede arredare una chiesa di una cittadina veneta con i seggi usati dai Padri Conciliari in San Pietro durante il Vaticano II, o innalzare in una zona borghese di una città un pinnacolo come se ci si stesse ancora litigando con gli anticlericali, oppure ci si pavoneggia attorno alla mensa con vesti liturgiche neo-paleocristiane interpretate come espressioni del contemporaneo.
La domenica, come luogo e tempo, può avere delle chances ma non ci si illuda. Cuius commoda eius et incommoda, dicevano gli antichi giuristi. La domenica, come luogo e tempo, può essere un «centro», ma occorre costruirli, questi luoghi e questi tempi. Ed è una costruzione faticosa.
Dove e quando fare domenica
La domenica può essere anche solo un tempo. Il luogo potrà essere il più svariato. Per chi lavora con i giovani, stante quello che si è detto prima, può anche essere più facile. Più facile perché non è necessario preoccuparsi di «realizzare» un luogo proprio. Occorre, però, «scegliere» il luogo alternativo e, soprattutto, scegliere lo «stile» di quello che assumerà, nel segno, il ruolo di centro.
Quanto alla scelta del luogo va tenuto presente un fatto. Anche se si è conclusa una civiltà «cristiana», sono ancora ampiamente presenti luoghi che la ricordano, e con marcata importanza. Abbazie, conventi, santuari esprimono l'esistenza di «alti luoghi» della vita cristiana. Possono essere il luogo in cui si realizza per noi, in quella certa domenica, il «centro» che stiamo cercando. In talune regioni d'Italia la scelta è abbastanza facile, in altre meno. Deve però essere una scelta studiata. Non è detto, infatti, che per il gruppo di giovani cui ci riferiamo sia subito adatta un'abbazia, o un convento, o un santuario. Si può preferire per loro la spiaggia del mare, o di un lago, o un bosco. Può darsi che il gruppo abbia bisogno di spazio in cui far chiasso, in cui giocare a pallone, o dove fare il bagno.
Nelle sue Conferenze san Cassiano (citato in questo caso da san Tommaso d'Aquino) racconta di un tal cristiano (pedante!) che incontrò finalmente l'evangelista san Giovanni, ormai vecchio. Lo incontrò mentre coi discepoli stava giocando col pallone. Se ne meravigliò quel tal cristiano (pedante!) e comandò all'apostolo perché mai perdesse del tempo a giocare quando sarebbe stato più serio dedicarsi alla meditazione della parola di Dio. Ne ebbe una risposta piena di saggezza umana ed evangelica. Il vecchio san Giovanni chiamò un ragazzino che aveva, a tracolla, un arco. Gli disse di tendere la corda, di tenderla di più, ancora di più. Intervenne lo stesso cristiano (pedante!): «Se gli continui a comandare di tendere la corda l'arco si spezzerà». Replicò l'apostolo: «Ci spezzeremmo anche noi se occupassimo tutta la giornata nella meditazione del vangelo».
Il clima di popolo per celebrare la festa
Qui siamo ormai nello «stile» da realizzare in riferimento al «centro». È uno stile da tener presente anche nel caso in cui il «centro» debba essere realizzato non solo come «tempo» ma anche come «luogo». Deve essere un «centro» che sa di festa. In questo ci può aiutare la saggezza cristiana, e umana, di san Giovanni Bosco, disposto a fare il giocoliere, il saltimbanco, perché i suoi ragazzi, i ragazzi affatto «per bene» che raccoglieva qui e là, e infine a Valdocco, facessero «centro» con lui, nel Signore.
Sono corsi in ottantamila, a Venezia, per vivere la festa del Carnevale. La «festa» è anche oggi sentita. I cristiani devono esserne colpiti perché i cristiani, nel Signore, conoscono la «festa», quella che intrisa di beatitudini dice risurrezione.
Nei secoli i cristiani hanno saputo far festa. Non si tratta tanto della «festa dei folli», di cui si è scritto qualche anno fa, ma di quelle feste di popolo che ancora rallegrano «sa curtizza», la corte, il sagrato, di alcuni santuari campestri di Sardegna dove dopo la messa si balla il «ballo sardo»; o le piazze di chiese parrocchiali, un po' ovunque, prima e dopo la processione «con la statua del santo». Non è il clima esasperato, e ideologico, di Grazia ricevuta, e neppure quello, altrettanto ideologico, di certi artefatti dialoghi con Maria.
È un clima di «popolo» (popolare è già aggettivo ideologizzato), per usare un'espressione dei parroci toscani che chiamano così le loro «anime» (chi ha letto don Milani lo sa). È un clima che può essere realizzato anche da un gruppo di giovani, nel costruire il loro «centro», alla domenica, in parrocchia, o in oratorio, o altrove, sulle strade del mondo.
È un clima che richiede la presenza di adulti, o almeno di giovani adulti. Per due motivi. Primo: perché l'essere giovane dura poco (qualche anno), e occorre abituarsi già da giovani a lavorare con chi giovane non è più (anche se da poco); secondo: perché si rischia di avere un non giovane, il prete (da presbitero, termine non più usabile perché desueto che significa «anziano»), col gruppo. Ma: «guai ai soli». Un adulto (il prete) solo con molti giovani deve alla fine giocare anche ruoli che non sono i suoi. Come prete ha forse il carisma dell'unità (specie se è parroco), ma non ha «l'unità, l'insieme dei carismi». Se è solo rischia di dover supplire. E le supplenze spesso giocano brutti tiri. La storia, anche ecclesiale, insegna.
L'EUCARISTIA SEGNO DEL MISTERO DI DIO E DELL'UOMO
La domenica «centro» è un segno. Ritorniamo a ciò che da essa ha da esser significato. Riduciamo, per comodità, il «significato» a Cristo, vero Dio e vero uomo. La domenica «centro» deve essere espressiva di Dio e dell'uomo. Alla luce dell'evangelo. Quella luce che ci presenta Dio «Uno e Trino», cioè la Trinità, indicibile e perfetta nelle relazioni comunionali del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; comunione intima e totale d'amore che si manifesta in una misericordia (tenerezza) che è operatrice di salvezza nel Padre attraverso il Figlio che diventa uomo e redime per l'azione dello Spirito.
Realizzare la comunione con Dio nella vita quotidiana
Segno di questo mistero la domenica «centro» lo manifesta sacramentalmente nella celebrazione eucaristica che ci consegna in modo domestico, secondo uno stile quotidiano, questa operazione salvifica. In essa, infatti, opera la potenza del Padre che rende presenti nella loro realtà sostanziale il corpo e il sangue del Figlio che si è fatto uomo per l'azione dello Spirito santo invocato. Può manifestarlo - deve manifestarlo - nella vita della comunità che chiede d'essere omogenea alla comunione d'amore frutto della fedeltà di Dio alle sue promesse (cf 1 Cor 1,9).
Come ha da essere questa vita della comunità?
Non basta la creatività di uno o più abili registi di vita di gruppo. Occorre la consapevolezza che si ha a che fare con un momento di vangelo dove non hanno spazio le sapienze e le potenze del mondo. Vita, allora, all'insegna della libertà cristiana (quella che si ottiene vincendo con Gesù le tentazioni sperimentate da Gesù nel deserto, cf Mt 4,3-11); della gioia; della pace; della fraternità; del servizio operoso; dell'unità; dell'accoglienza; del perdono vicendevole.
L'esistenza cristiana è vivere ad imitazione di Cristo
La domenica «centro» è espressiva, alla luce dell'evangelo, dell'uomo. Uomo che il credente sa di trovare perfetto in Gesù, modello operante su cui si può modellare, per la grazia, ogni uomo. Per la grazia che, con la Legge nuova che è a sua volta la stessa grazia dello Spirito santo data attraverso la fede a chi crede in Cristo come insegnamento divino, è l'aiuto che Dio dà all'uomo perché questi si divinizzi, realizzando l'invito che troviamo nella Lettera agli Efesini: «Siate imitatori di Dio come figli carissimi, camminando nell'amore» (Ef 5,1-2).
L'uomo, però, riceve da Dio l'insegnamento attraverso la Legge e il sostegno attraverso la grazia, essendo in qualche modo attrezzato alla recezione. Lo è mettendo in opera le sue possibilità di agire bene attraverso un'esistenza virtuosa. Esistenza che dice, in Cristo, «fede, speranza e carità», ma anche «prudenza, giustizia, fortezza e temperanza», le virtù cardine che riguardano la globalità dell'essere uomo; la sua intelligenza, la sua volontà, la sua corporeità passionale.
Dal dono della fede alla responsabilità etica
Sia le virtù teologali che quelle cardinali Tommaso d'Aquino le relaziona ai doni dello Spirito santo. Nell'ordine: dell'intelletto e della scienza (per la fede), del timore (per la speranza), della sapienza (per la carità), del consiglio (per la prudenza), della pietà (per la giustizia), della fortezza (per la fortezza), ancora del timore (per la temperanza).
E i doni alle Beatitudini: al dono dell'intelletto la beatitudine dei puri di cuore; al dono della scienza la beatitudine di chi piange; al dono del timore la beatitudine della povertà di spirito; al dono della sapienza la beatitudine degli operatori di pace; al dono del consiglio la beatitudine dei misericordiosi; al dono della pietà la beatitudine dei miti; al dono della fortezza la beatitudine di chi ha fame e sete di giustizia.
Ma: a che pro questo elenco? Allo scopo di spingere a rivisitare un'adeguata riflessione sulla vita cristiana (possiamo chiamarla anche «morale cristiana») perché i due poli del «centro» siano entrambi investigati, e proposti, e vissuti nella gestione della domenica «segno del centro».
Anche di questo oggi c'è bisogno, specie in quella fase di costruzione della struttura morale che appartiene al tempo della adolescenza e della giovinezza. Se il fideismo compie un cattivo servizio, lo compie anche un volontarismo sempre in agguato e pericoloso perché l'uomo, nel suo agire, è immagine di Dio in quanto «principio delle proprie azioni, dotato di libero arbitrio e di padronanza di sé») (Tommaso d'Aquino) e ancora perché «è proprio alla natura razionale tendere al fine agendo in proprio e dirigendosi ad esso, mentre è della natura irrazionale arrivarvi mossa e condotta da un altro» (idem).