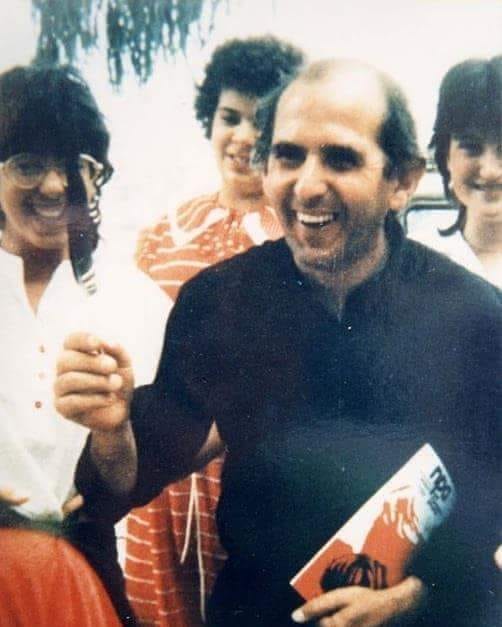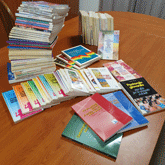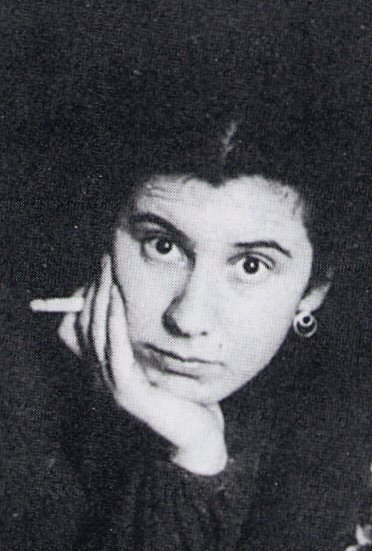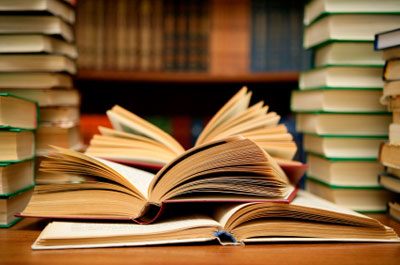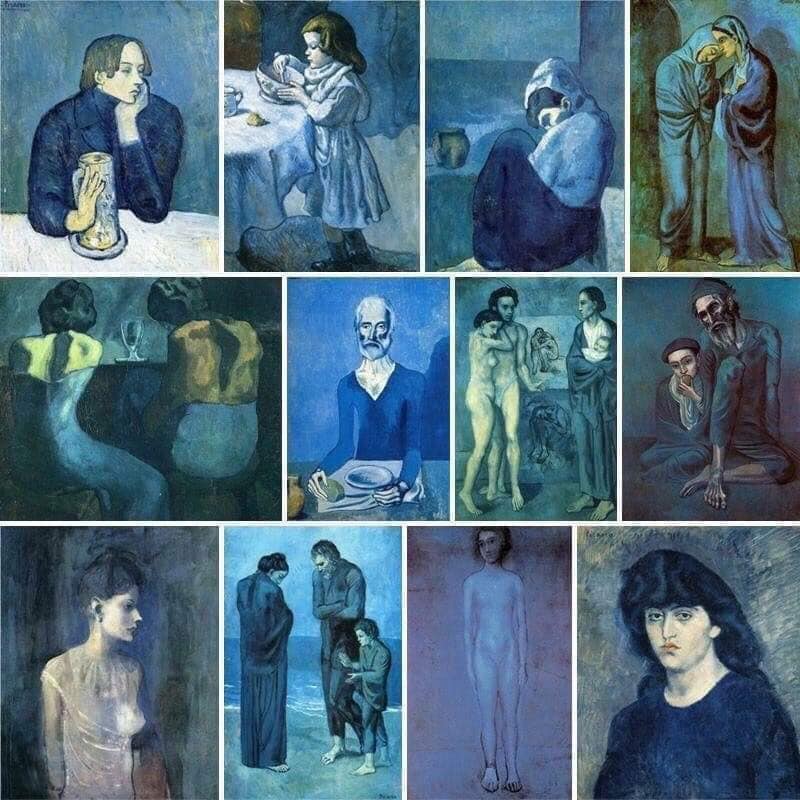RAGAZZI E ADULTI PELLEGRINI SULLA TERRA
Un viaggio attraverso le grandi domande di senso /1
Raffaele Mantegazza e Christiano Nella
(NPG 2025-01-63)
Iniziamo con questo pezzo una serie di articoli costruiti come dialoghi tra uno studente di 21 anni, Christiano Nella e un docente di 58 anni, Raffaele Mantegazza. I temi attorno ai quali graviteranno gli articoli sono alcune domande fondamentali che attraversano l’umanità non solo da oggi ma da secoli. La forma dialogica permette di confrontare idee e pensieri cercando di accerchiare i temi senza proporre verità definitive.
Tra quantità e qualità
Caro Christiano,
in questi tempi in cui tanto si dice e si scrive a proposito di intelligenza artificiale, cosa resta della domanda della Prima Critica Kantiana: “Che cosa posso sapere?”.
La risposta che potrebbe venirci in mente è “tutto”. Ma è davvero così? Abbiamo sicuramente a disposizione una mole di sapere inimmaginabile fin a solo due decenni fa, e oltretutto possiamo accedervi in qualunque momento e a velocità rapidissima: possiamo forse sapere tutto ma perché doverlo sapere? Che cosa ce ne facciamo di questo sapere così moltiplicato?
Una domanda che forse non ci si pone più e se il sapere sia il fine o lo strumento della vita umana. È la domanda sul “perché” sapere che spesso viene eclissata dalla facilità con cui la conoscenza viene raggiunta; infatti forse la domanda sul “perché” è legata allo sforzo che si compie per conoscere; se per trovare la definizione di un termine devo aprire con cura il vocabolario e cercare la parola seguendo l’ordine alfabetico, questo sforzo deve essere commisurato al risultato (chiedendomi “ne vale la pena?”); ma se invece la conoscenza è fornita gratis, senza sforzo e in tempo reale non c’è letteralmente spazio per la domanda sui fini.
Caro Raffaele,
ho l'impressione che proprio la domanda sul perché sia oggi più che mai inaggirabile. Possiamo forse biasimare un giovane che, alle prese con un’analisi formale di un testo o con lo studio di un problema complesso, si interroga sull’opportunità di investirci lunghi pomeriggi, quando, con un input ben scritto, può ottenere delle risposte più che soddisfacenti?
Non posso che rilanciare con un’altra domanda: “perché ci alziamo dal divano per una passeggiata o per fare sport?”. Mi pare che la questione non sia radicalmente diversa. Potremmo non farlo - e talora è così - ma quando invece vinciamo quell’iniziale resistenza alla forza di gravità, il risultato è appagante. Faticoso all'inizio - rossore, goffe sudate e gambe di legno per i due giorni successivi - ma poi, con un po’ di costanza, diventa un’abitudine. Il nostro corpo ce lo chiede, ne sentiamo il bisogno. Io credo che anche per la conoscenza la questione sia simile: la fatica iniziale è indubbia, e così nel percorso, ma quando si inizia ad assaporarla, poi, non è mai abbastanza. Un fine o uno strumento? Non ne sono certo, forse un fine, che indirizza gli sforzi presenti, ma anche mezzo, per un fine altro, meno netto e più difficile da sostanziare, che però il nostro corpo ci impone.
Tra verità e mainstream
Caro Christiano,
lo spettro che sembra tornare ad aggirarsi per le nostre scuole e Università è quello della neutralità del sapere. La rete ci offre una massa di dati orizzontali, senza gerarchie e senza propedeuticità, in quella che a mio parere è la parodia della democrazia. Ma se si va a osservare fino in fondo l’articolazione dei saperi, si osserva che è sempre più diffusa l’idea che esista un discorso che si eleva a superiore agli altri: si tratta del sapere tecnologico (più pervasivo di quello semplicemente tecnico-scientifico). Un sapere egemone che relega sempre di più altre forme di conoscenza (poetica, religiosa, mistica, ecc.) in secondo piano, come se si trattasse di residui dell’infanzia dell’umanità (attualizzando un Giambattista Vico letto molto frettolosamente).
L’universalità del sapere tecnologico, sempre più arrogante nella sua pretesa di esaustività, porta a compimento del passaggio da un paradigma narrativo-dialogico a un paradigma sistematico che era già implicito nello spostamento della filosofia dal mito/dialogo di Platone al sistema come strumento del pensiero in Aristotele.
Cosa resta in tutto ciò dal carattere relazionale, emotivo, fisico della conoscenza?
Caro Raffaele,
Resta tutto e più forte di prima, il punto è non scordarlo. Il mio timore è, però, che ci dimentichiamo che l’essere umano non è solo “mente”, ma è - per l’appunto - umano. Abbiamo un corpo, siamo corpo. E quando abbiamo il coraggio di non farci distrarre dal nostro caotico presente, scopriamo che anche il corpo ha i suoi saperi.
Ciò che mi preoccupa è che anche il nostro sistema scolastico si rivolge troppo spesso (quando non esclusivamente) ad un unico modello di studente. Come se lezioni frontali e manuali possano essere la ricetta per tutti, con buona pace dei nostri corpi. La staticità in cui sono immersi i corpi in una classe di scuola talvolta è tale che metterli in movimento può avere una forza inattesa. Liberarli dalla protezione-costrizione di un banco per mobilitarli, scoprirsi nudi e sentirsi membri attivi, parte di un cerchio, produce un sapere che è senza dubbio altro da un manuale, ma non per questo meno degno.
Tra fatica e felicità
Caro Raffaele,
Un percorso di apprendimento che includa fatica in se stesso mi pare fondamentale. Non fine a se stessa, non una fatica del “ai miei tempi facevi la gavetta e nessuno si lamentava", ma una fatica data dall’oggetto. Perché prendere in mano un classico, uno strumento musicale o impegnarsi inseguendo un sogno presuppongono tanta applicazione. Sapere per essere felice, faticare per sapere. «Difficili sono le cose belle» riassume - meglio di me - Aristotele. E invece il nostro presente mi pare gridarci esattamente l’opposto: videocorsi per investire in borsa, comprare criptovalute o diventare influencer. Soluzioni rapide per un massimo profitto.
Quanto al risultato poi la situazione non è migliore. “Informarsi, leggere, essere aperti sul mondo”, questi gli imperativi che sembrano guidare la nostra educazione civica. E cosa ci troviamo? Guerre, disillusione e un costante vociare di sottofondo, nel quale le parole hanno perso ogni dignità. Che fare se sapere poi mi fa soffrire?
Caro Christiano
Avendo in sostanza dedicato la mia vita al sapere e alla cultura mi sono trovato spesso a chiedermi se ne valesse davvero la pena; mi sono cioè domandato se le persone che ignorano siano più felici di quelle che cercano di conoscere, o che perlomeno sono consapevoli di ignorare. Se cioè gli schiavi della caverna di Platone non potrebbero rifiutare l’aiuto del loro compagno che si è liberato opponendogli l’obiezione “ma stiamo così bene nell’ignoranza” (un po’ come gli ebrei che nel deserto rimpiangono le pentole piene che dava loro il Faraone). Credo che la liberazione e la libertà comportino sempre un certo sforzo, che non è però la fatica dello schiavo o peggio ancora la fatica inutile di cui parla Primo Levi, ma lo sforzo dell’alpinista che non conquista la montagna ma si fa guidare da lei e per questo motivo la conosce con saggezza e con profondità.
Tra dubbio e mistero
Caro Raffaele,
Chi ce la dà la forza di sapere? Di non fermarci alla superficie, ma andare oltre il nostro - legittimo - crogiolarci in convinzioni rassicuranti. Ci vuole coraggio per non diventare insensibili al dubbio sotto pelle che di continuo mette in questione la nostra tendenza conservatrice. Stringerci intorno a principi morali superiori è bello, ci fa sentire bene l’idea che ci sia un “naturale” a cui appellarci. Uccidiamo la storia senza tanti complimenti ed eleviamo una circostanza a fatto di natura. Eppure, in fondo, chi può farsi portatore della certezza assoluta? Ma ci vuole coraggio ad ammetterlo, ricordarlo ogni giorno.
Siamo negli anni in cui abbiamo ucciso insegnanti, medici, scienziati – qualunque tipo di competenza o sapere specifico. Avevamo raggiunto così tante certezze che, forse, abbiamo deciso di dubitare di tutte. Persi in un individualismo assordante, l'io individuale, formatosi alla sacra accademia di internet, è diventato il nuovo dio universale.
Caro Christiano
Parlando di coraggio del conoscere mi richiami alla mente un bellissimo passo di Hegel che afferma: “L’essenza dell’universo, in un primo tempo celata e chiusa, non ha forza da resistere al coraggio di chi vuol conoscerla: deve schiuderglisi dinanzi agli occhi, e mostrargli e fargli godere la sua ricchezza e profondità”. Credo che il coraggio di pensare sia legato a una declinazione dolce della parola “coraggio”, non muscolosa, non violenta ma delicata e dolce; è il coraggio di chi vuole essere intelligente nel senso di intus-legere, leggere-dentro le cose chiedendo loro il permesso per raggiungere il loro cuore. È una forza che ciascuno e ciascuna di noi possiede perché l’intelligenza, essendo una posizione dell’uomo e della donna di fronte al reale, non si misura ma semplicemente si vive e si respira.