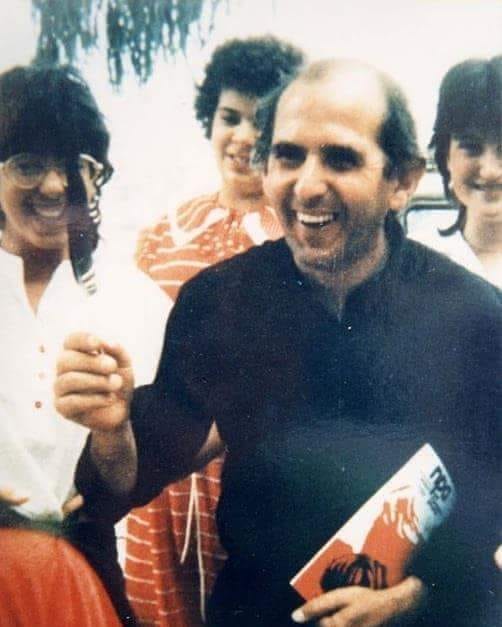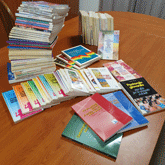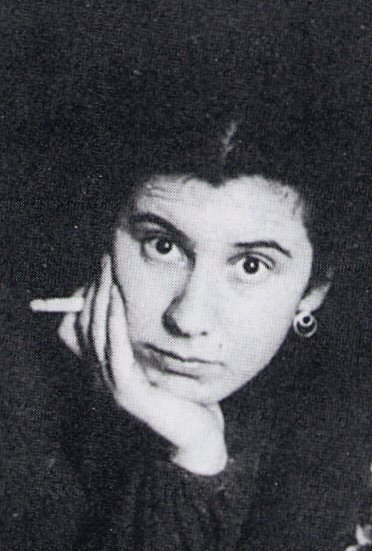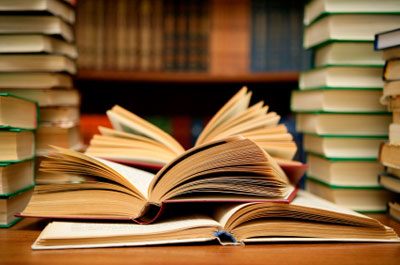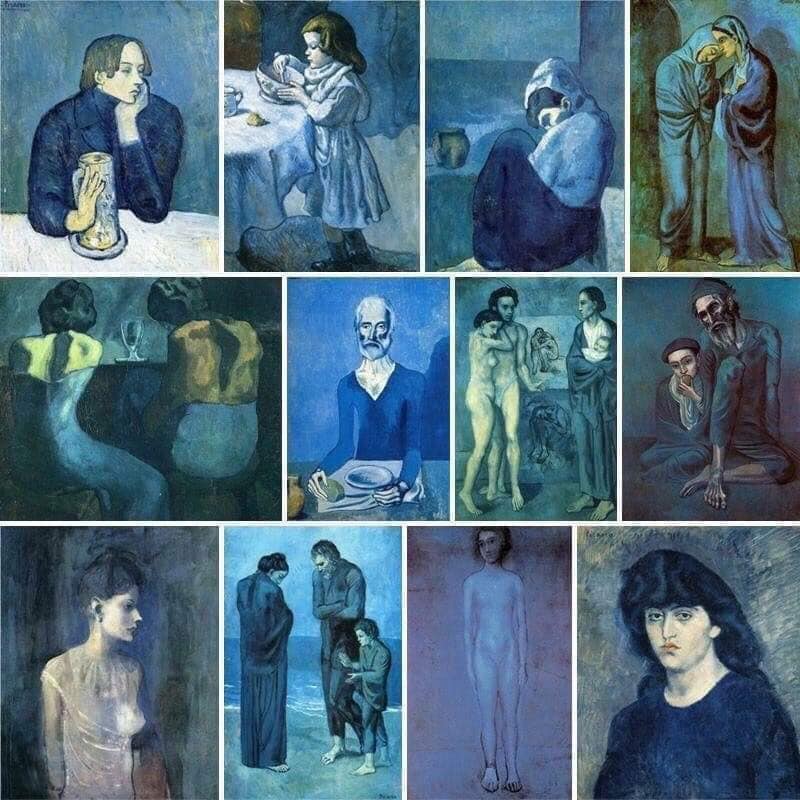Dai Vangeli all'Apocalisse:
un solo Signore, Gesù Cristo
Primo Gironi
Il Nuovo Testamento non contiene la «vita» di Gesù, ma prosegue nella presentazione della storia della salvezza che era iniziata con le vicende di Abramo, Mosè, Davide e degli altri grandi personaggi della Bibbia.
Nella lingua ebraica Gesù significa «Dio dà salvezza». In questo nome perciò si concentra tutto ciò che il Nuovo Testamento annuncia: «Dio infatti ha tanto amato il mondo, che ha dato il Figlio suo unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).
Il vangelo e i quattro vangeli
«Vangelo» è parola di origine greca che significa «buona notizia». Era un termine utilizzato già dagli antichi greci e romani per indicare la «buona notizia» della nascita di un personaggio importante o della vittoria in guerra e nelle competizioni sportive. Sono gli scritti del Nuovo Testamento che fanno di questa parola un uso particolarissimo, che è prevalso poi su tutte le altre utilizzazioni: «La buona notizia èGesù, Figlio di Dio, Messia e Salvatore dell'uomo» (cfr. Mc 1,1).
Di Gesù parlano quattro libretti che chiamiamo «vangeli», che presentano il contenuto di questa «buona notizia». I vangeli di Matteo, Marco e Luca hanno il centro del loro messaggio nella frase: «Gesù è venuto a cercare chi era perduto». Cercare è il verbo che indica la dignità dell'uomo e la cura che Dio ha per lui, nonostante il suo peccato e la sua indifferenza. Perdere significa il fallimento totale dell'uomo, il rischio della sua perdizione finale. Nella persona e nella parola di Gesù, Dio vuole mettere l'uomo al sicuro da questo rischio. Il vangelo di Giovanni invece presenta Gesù come l'unica «via» da percorrere per arrivare a Dio. Tutte le altre vie sono insufficienti, ogni altra verità è limitata, ogni altro stile di vita è incompleto. Solo Gesù è «la via e la verità e la vita» per l'uomo (Gv 14,6). Solamente lui ha aperto la via verso il Padre (cfr. Gv 1,18).
Questa diversità non significa contraddizione tra i quattro vangeli, ma giustifica la presenza di questi quattro racconti su Gesù, tutti e quattro necessari e insostituibili per comprendere pienamente la sua missione, il perché della sua venuta nel mondo e il significato della sua persona per l'uomo di ogni tempo.
Gli studiosi della Bibbia concordano nell'affermare che il primo incontro con il vangelo va fatto leggendo i racconti della passione di Gesù o, meglio ancora, partendo dalle lettere più antiche di san Paolo, scritte prima degli stessi vangeli. Noi preferiamo seguire il racconto su Gesù come ci viene presentato nei vangeli che abbiamo tra le mani e nell'ordine in cui essi ce l'hanno tramandato.
I vangeli dell'infanzia
Ci imbattiamo così con quella sezione che è chiamata «vangelo dell'infanzia di Gesù». La presenza di questi racconti in Matteo e Luca (mentre Marco e Giovanni non li riportano) conferma come le varie tappe della rivelazione di Dio nella Bibbia siano ora culminate nella tappa definitiva, nel «cor
po» di Gesù. Le «mani» e le «dita» del Dio della creazione, la «destra» e il «braccio forte» del Dio dell'esodo ora sono finalmente raccolti nell'insieme del «corpo» di Gesù che, nella sua umanità, rivela definitivamente Dio all'uomo.
I racconti dell'infanzia di Gesù non sono perciò qualcosa di estraneo al racconto più ampio della storia della salvezza. Essi sono invece una storia annunciata già dalle prime pagine della Bibbia e lungo le varie manifestazioni che il Dio biblico aveva fatto di se stesso.
I racconti dell'infanzia narrati dall'evangelista Matteo differiscono da quelli tramandati da Luca. Ciò è dovuto alla diversità dei destinatari dei due evangelisti e alla particolare angolatura teologica da cui essi presentano la figura di Gesù. I destinatari del vangelo di Matteo sono ebrei. Essi conoscono bene la Bibbia e desiderano confrontare la persona di Gesù e la sua attività con i grandi personaggi dell'Antico Testamento. Per questo Matteo si impegna a mettere a confronto gli avvenimenti che hanno caratterizzato la nascita e l'infanzia di Gesù con alcuni testi significativi dell'Antico Testamento. Egli imposta gli episodi del suo vangelo dell'infanzia alla luce di un testo biblico (in genere una profezia) che già anticipava o prefigurava quanto da lui narrato su Gesù. Sono i testi conosciuti come «profezie di compimento», cioè testi profetici che l'evangelista vede «compiersi» in Gesù. È così che la nascita verginale di Gesù è rapportata alla profezia di Is 7,14 («Ecco, la giovane donna concepisce e partorisce un figlio e gli porrà nome Emmanuele»), la strage degli innocenti a Ger 31,15 e la fuga in Egitto a Os 11,1.
L'angolatura dalla quale Matteo presenta la figura di Gesù è perciò spiccatamente biblica. Nel suo Gesù confluiscono le profezie e i testi messianici più significativi, così che il lettore ebreo viene man mano guidato a riconoscere in Gesù di Nazaret il Messia promesso e ora finalmente presente nel suo popolo.
Quest'angolatura spiega l'importanza data a Giuseppe nel vangelo di Matteo. Tutti gli episodi ruotano attorno a questo protagonista dell'infanzia di Gesù, mentre Maria è quasi messa in ombra. Matteo, infatti, vede in Giuseppe la linea della discendenza davidica dalla quale sarebbe nato il Messia, secondo tutta la tradizione biblica. Giuseppe «figlio di Davide», sposando Maria, colloca di diritto Gesù nel popolo biblico e nella linea della benedizione messianica pronunciata sulla famiglia di Davide (2Sam 7).
Il «vangelo dell'infanzia» secondo Luca contiene racconti noti a tutti per essere stati accolti nella recita del rosario con il nome di «misteri gaudiosi» (annunciazione, visita a Elisabetta, nascita di Gesù, presentazione al tempio, perdita e ritrovamento di Gesù). La narrazione di questi episodi ha un respiro universale: a differenza di Matteo, Luca ama presentare Gesù non solo come il Messia atteso dagli ebrei, ma come il salvatore di tutti.
Inoltre, mentre Matteo fa perno sulla figura di Giuseppe, Luca colloca al centro del vangelo dell'infanzia Maria, fissata nell'atteggiamento di chi «medita nel suo cuore» questi avvenimenti (cfr. Lc 2,19). Il verbo «meditare» traduce solo parzialmente il significato del greco synbdllein usato da Luca. Questo verbo ha un significato più intenso che solo i verbi «mettere insieme», «confrontare», «interpretare» possono rendere bene. «Interpretare» (o «confrontare») è quindi il verbo chiave per la comprensione dei vangeli dell'infanzia, come Maria è il personaggio chiave.
Testimone di questi avvenimenti, Maria sarà continuamente chiamata a «interpretarli» e a «confrontarli» con gli avvenimenti e i personaggi che caratterizzano il ministero di Gesù.
Negli avvenimenti dell'infanzia Maria vede perciò anticipato lo stile del ministero di Gesù, i suoi gesti e le sue parole:
l'accoglienza dei peccatori, anticipata dall'accoglienza dei pastori, ritenuti «impuri» dalla religione ufficiale; l'obbedienza alle prescrizioni mosaiche della circoncisione e della presentazione al tempio, quale anticipo dell'obbedienza radicale di Gesù al Padre, fino ad accettare la morte di croce; la perdita e il ritrovamento di Gesù nel tempio dopo tre giorni e la permanenza di Gesù per tre giorni nel sepolcro per essere poi «ritrovato» dai suoi nella gloria di Pasqua.
Questi racconti anticipano anche gli atteggiamenti che l'uomo assumerà nei confronti di Gesù e della sua parola, atteggiamenti che Luca ama racchiudere nelle espressioni «subito», «in fretta», «con gioia», «oggi», «eccomi», che scandiscono il suo vangelo.
Le parole di Gesù
Abituati a vedere nella Bibbia quasi unicamente la rivelazione che Dio fa di se stesso attraverso la parola, spesso dimentichiamo che questa stessa rivelazione avviene anche con i gesti e gli eventi. Leggiamo nella costituzione conciliare sulla divina rivelazione: «La rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole proclamano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto» (Dei Verbum, n. 2). Alla luce di quest'affermazione affrontiamo il ministero di Gesù sotto questo duplice aspetto di rivelazione attraverso la sua parola e attraverso i suoi gesti.
È soprattutto il vangelo di Matteo quello che maggiormente inserisce il lettore nella rivelazione che Gesù fa di se stesso attraverso la parola. Il suo vangelo è strutturato su cinque grandi discorsi, dai quali traspare l'identità del Gesù di Matteo: un nuovo Mosè che diffonde «con autorità» la parola di Dio. Matteo privilegia così la stessa forma letteraria con cui la Bibbia ha tramandato le parole di Mosè: il discorso. Il suo vangelo, infatti, è come un nuovo Pentateuco (= la raccolta dei primi cinque libri della Bibbia, chiamati anche «i libri di Mosè») che raccoglie la predicazione di Gesù, come dicevamo, in cinque grandi discorsi.
il discorso della montagna (Mt 5-7): è la cornice nella quale l'evangelista Matteo colloca la predicazione di Gesù. Egli privilegia il discorso, che è la forma letteraria più vicina al ministero di Mosè. La montagna ricorda ai lettori ebrei «il luogo» della rivelazione di Dio a Mosè: il Sinai (Es 19). Matteo,
che presenta Gesù come il Maestro definitivo di Israele, evoca lo stesso contesto e attribuisce a Gesù un'autorità superiore a quella di Mosè e di tutti gli altri maestri («gli scribi e i dottori della legge»). Nel discorso della montagna, infatti, Gesù è presentato come «uno che insegna con autorità e non come i loro scribi» (cfr. Mt 7,29).
Il discorso missionario (Mt 10): contiene le disposizioni che Gesù dà agli apostoli per continuare la sua missione. È importante notare come sia sempre la parola a guidare l'attività missionaria: «Non siete voi a parlare, ma lo Spirito del vostro Padre parlerà in voi» (Mt 10,20).
Il discorso in parabole (Mt 13): la parabola è un prolungamento della parola. È un modo caratteristico di parlare e di coinvolgere l'ascoltatore, che Gesù fa suo. Nessuno meglio di lui ha saputo cogliere la presenza di Dio nelle vicende e nei personaggi della vita di ogni giorno: la semina, il raccolto, la pesca, l'impasto del pane, la vita di famiglia, il rapporto servo-padrone, re-sudditi, padri-figli, pastore-gregge ecc. Nelle parabole di Gesù la vita quotidiana diventa il luogo privilegiato della presenza di Dio e della diffusione del suo regno. Dio non è più chiuso nella sola sfera del sacro, inaccessibile all'uomo, ma si rivela nella ferialità di tutti i giorni e dei gesti più comuni, grazie alle parabole di Gesù.
Anche il vangelo di Luca contiene un'ampia sezione dedicata alle parabole (ricordiamo solo quelle più note: il buon samaritano, il figliol prodigo, il ricco epulone e il povero Lazzaro). Il messaggio di bontà e di amore che si sprigiona da questi racconti incisivi di Gesù rende ragione della definizione che di Luca ha dato Dante Alighieri: Luca, scriba mansuetudinis Christi, «Luca, l'evangelista della bontà del Cristo».
Il discorso comunitario (Mt 18): la comunità che Gesù raduna attorno alla sua parola è la comunità messianica, giunta al culmine della rivelazione di Dio e della sua opera di educatore. In essa non si privilegia la legge della stretta giustizia, ma quella del perdono, della correzione fraterna, della riconciliazione e dell'accoglienza reciproca. Ognuno dei suoi membri ha la consapevolezza che «Gesù è in mezzo a loro». Il discorso escatologico (Mt 24-25): contiene ciò che la parola di Gesù dice sugli ultimi avvenimenti dell'uomo e del mondo (in greco èschaton significa appunto «ultimo»). In questo discorso emerge il giudizio che Dio pronuncerà su ogni uomo, basato sulla coerenza tra la fede nella parola di Gesù e l'accoglienza dei fratelli: «Avevo fame, avevo sete, ero malato e forestiero... e mi avete (o: non mi avete) dato assistenza».
Il discorso sulla fine del mondo, riportato nei vangeli di Matteo, Marco e Luca, si intreccia con la sorte della città di Gerusalemme, ormai vicina alla distruzione da parte degli eserciti romani (cadrà nel 70 d.C.).
Al centro del vangelo di Matteo c'è quindi la parola di Gesù. Non una parola astratta, senza efficacia, come ormai è considerata la parola nella nostra civiltà. È invece la parola delle «beatitudini», del «Padre nostro», del «perdono» e dell'annuncio del «regno dei cieli» in mezzo a noi nella persona e nella parola di Gesù. È la parola che, sola, riesce a trasformare questo nostro mondo segnato dal peccato e a renderlo come Dio lo ha voluto nel momento della creazione. Ha ragione l'evangelista Matteo a concludere il discorso più impegnativo di Gesù, quello «della montagna» (Mt 5-7), affermando: «Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia... Chi ascolta queste mie parole, ma non le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo stolto che costruì la sua casa sull'arena» (Mt 7,24-27).
Anche il vangelo di Giovanni è tutto costruito attorno alla parola di Gesù, o meglio alla Parola che è Gesù. Questo vangelo è costituito da profondi «discorsi» di Gesù (pensiamo solo al lungo «discorso sul pane di vita» riportato in Gv 6), nei quali è contenuta la sua parola di rivelazione e dai quali soprattutto traspare la sua identità di «parola di Dio». Nel presentare questa identità di Gesù, l'evangelista Giovanni usa il termine greco Logos, «Verbo» o «Parola». Secondo gli antichi pensatori greci il Logos era la ragione ultima del mondo, era ciò che dà senso e valore a tutto. L'uomo realizzava se stesso se riusciva a inserirsi in questa «ragione» che tutto ordinava e tutto spiegava. Secondo il vangelo di Giovanni invece il Logos è la parola di Dio, che tutto ha creato, a tutto dà un volto, tutto riconduce «all'immagine e alla somiglianza con Dio». La tradizione biblica identificava questa parola di Dio ora con la Legge, ora con la Sapienza. Il vangelo di Giovanni porta a compimento la rivelazione biblica presentando Gesù come «parola di Dio»: «Il Verbo (o la Parola) era Dio... si fece carne e dimorò fra noi» (Gv 1,1.14). Nell'umanità di Gesù, chiamata biblicamente «carne», prende dimora la parola di Dio e appare la definitiva rivelazione di ciò che Dio è e di ciò che l'uomo è destinato a diventare.
Il gruppo dei capitoli 13-17 del vangelo di Giovanni è conosciuto con il nome di «discorsi di addio», un genere letterario molto in voga nell'antichità. Anche Gesù lo utilizza. Quando un personaggio importante era ormai prossimo alla morte, chiamava accanto a sé i suoi cari (o i discepoli) e a essi affidava le ultime volontà. L'evangelista Giovanni, in questi lunghi capitoli, ama presentare Gesù in questo stesso atteggiamento. Mentre gli altri evangelisti insistono sul dovere di accogliere e mettere in pratica la parola annunciata da Gesù, Giovanni offre la motivazione profonda di questo dovere: la Parola è Gesù stesso. E mentre gli altri evangelisti si soffermano a descrivere i vari rifiuti opposti a Gesù sin dalla nascita (da Erode fino alla folla della crocifissione), l'evangelista Giovanni invita il credente a «rimanere» nella Parola che è Gesù e a «portare frutto». Nel quarto vangelo questi due verbi sono infatti i verbi della fede («rimanere») e del comportamento dell'uomo che si lascia orientare e illuminare dalla parola di Gesù («portare frutto»).
Le parole che Gesù ha dato agli uomini («Io ho dato loro la tua paròla», Gv 17,14) vanno poste perciò al centro della loro vita e del loro comportamento. Chi non le accoglie e assolutizza altri modelli o stili di vita (che Giovanni racchiude nel termine «mondo»), va incontro al più grande fallimento, che Gesù non esita a chiamare «essere gettati via da lui» (cfr. Gv 15,1-17). Chi le accoglie e in esse «rimane», realizza pienamente se stesso e manifesta l'efficacia delle parole che Gesù ha dato agli uomini.
I gesti di Gesù
I gesti con cui Gesù rivela se stesso sono indicati con due termini: nei vangeli di Matteo, Marco e Luca sono chiamati «miracoli»; nel vangelo di Giovanni «segni». Non si tratta però di una differenza tale da spingere il lettore a contrapporre i gesti di Gesù descritti dai sinottici (come sono chiamati i vangeli di Matteo, Marco e Luca visti in uno «sguardo di insieme», in greco syn dpsis) a quelli descritti da Giovanni, bensì di un diverso modo di guardarli. Per i sinottici questi gesti mettono in risalto l'opera di Dio, che manifesta la sua presenza nel mondo e il suo interessamento per l'uomo attraverso la persona di Gesù. Per Giovanni questi gesti sono segni che rimandano a una realtà più profonda, più alta e misteriosa. Questa diversa prospettiva spiega perché i sinottici contengano la narrazione di molti miracoli: le azioni di Gesù, infatti, devono esprimere il continuo operare di Dio in ogni ambito della vita e del mondo dell'uomo. Giovanni invece ne descrive solamente sette. Nella sua prospettiva infatti questi gesti hanno la capacità di svelare al lettore attento di ogni tempo il mistero della persona di Gesù.
Nell'Antico e nel Nuovo Testamento il miracolo è uno dei modi con cui Dio si rivela. A differenza dell'uomo del nostro tempo, che tutto vuole razionalizzare, l'uomo della Bibbia è naturalmente aperto alla dimensione religiosa e crede all'intervento di Dio nella natura e nei confronti dei bisogni fondamentali che egli avverte: la vita, la fame, la sete, la casa, la famiglia, la salute... Dio è sempre attento alle necessità dell'uomo e quando dal profondo del suo bisogno l'uomo alza la voce e tende le mani verso di lui, subito lo esaudisce.
Nei vangeli poi il miracolo è la risposta data a chi ricorre a Gesù con fiducia e abbandono. I miracoli di Gesù non hanno anzitutto lo scopo di suscitare la fede in lui, quanto piuttosto quello di manifestare la presenza di Dio nel mondo e la realizzazione del suo regno. La presenza di Dio va vista nella persona di Gesù di Nazaret: in lui che guarisce, che domina gli elementi della natura, che moltiplica il pane, che si oppone al potere del diavolo, l'uomo deve saper vedere Dio stesso, che non lo lascia in balia delle forze della natura, né in balia della malattia e della morte. Il regno di Dio non indica un luogo dove Dio comanda, ma significa la paternità di Dio, come è resa visibile nella persona, nelle parole e nei gesti di Gesù («regnare» è un verbo che nella Bibbia rimanda alla paternità di Dio sull'uomo e alla sua signoria sul creato, come ha indicato Gesù nella preghiera del Padre nostro).
Protagonista dei miracoli di Gesù è il corpo dell'uomo. La malattia, la fame, la sete, la stessa morte sono il «luogo» della compassione e dell'intervento di Gesù. Il miracolo proclama la dignità del corpo dell'uomo. Gesù privilegia questa dignità condizionando e addirittura modificando le leggi della natura: la fame, la sete, la malattia e ogni altro bisogno dell'uomo che interpella Gesù trovano la risposta nel suo gratuito intervento.
L'attività di Gesù, che si china sul corpo dell'uomo e per il quale compie i miracoli, è presentata nei vangeli alla luce dei gesti biblici che presentano i grandi «verbi» di Dio a favore dell'uomo e del suo popolo.
Nel vangelo di Luca, Gesù inizia il suo ministero accogliendo come programma i verbi di Is 61,1-2: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi ha inviato a portare ai poveri il lieto annuncio, ad annunziare ai prigionieri la liberazione e il dono della vista ai ciechi; per liberare coloro che sono oppressi e inaugurare l'anno di grazia del Signore» (cfr. Lc 4,18-19).
Nel vangelo di Matteo, Gesù applica al suo ministero gli stessi gesti compiuti da Dio verso il popolo biblico oppresso e sfiduciato, come sono descritti in Is 35,5-6: «Andate ed annunziate a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono e ai poveri viene annunziata la buona novella» (cfr. Mt 11,4-5).
Questi verbi, nel ministero di Gesù, non si limitano al solo corpo dell'uomo o a quanto di negativo lo ha intaccato (cecità, prigionia, malattia, privazione della libertà, morte), ma diventano i verbi della fede e della salvezza. Gli evangelisti cioè applicano questi verbi non più alla sola salute fisica dell'uomo, ma li estendono alla salvezza dal suo vero male, che è il p~ccato, il rifiuto di Dio e del suo amore.
In questo senso i gesti di Gesù sono già come interpretati dagli evangelisti: essi sono al tempo stesso miracoli e segni. Miracoli perché operano qualcosa di prodigioso sull'uomo e sulla natura. Segni perché rimandano a qualcosa di più profondo e di sempre attuale, che si può verificare ancora, oggi e sempre.
Quest'interpretazione degli evangelisti diventa anche la chiave di lettura dei miracoli per il lettore di oggi. Ai miracoli di Gesù non ci si deve accostare con l'occhio scettico del critico che si domanda se i fatti narrati si sono veramente svolti così. I vangeli, come abbiamo precisato, non sono la vita di Gesù, né i miracoli sono istantanee scattate al momento esatto in cui egli ha compiuto quel gesto. Vanno invece letti e compresi alla luce del loro significato. Il loro accadimento «storico» è ormai troppo lontano da noi ed è filtrato dall'interpretazione teologica dei singoli evangelisti (il che non nega la loro storicità e la loro verità).
Ai destinatari dei miracoli di Gesù si presentava in tutta la loro concretezza «storica» la guarigione fisica, la risurrezione da morte, la calma sulle acque del mare. Per loro esisteva la confortante certezza: «Sì, è veramente accaduto così, sono veramente guarito». Per noi lettori di oggi, non più testimoni di quei miracoli «storici», esiste l'altra faccia del miracolo, quella del «segno», che interpreta quanto Gesù ha fatto e continua a fare guarendoci dal peccato. La domanda c~e i gesti di Gesù ci pongono è perciò quella indicata dall'evangelista Giovanni: «Che cosa significa per me questo "segno"? A quale significato più profondo esso mi rimanda?».
I racconti della passione
I racconti della passione di Gesù costituiscono il primo nucleo della predicazione degli apostoli attorno al quale si sono venuti man mano formando i vangeli scritti. Essi infatti contengono avvenimenti di cui molti erano stati testimoni oculari e che difficilmente potevano essere contestati. Solo più tardi ci si interessò alla raccolta dei detti e dei fatti di Gesù, alla sua nascita e alla sua infanzia.
Nello stendere questi racconti gli evangelisti hanno ciascuno una particolare prospettiva che li caratterizza. Fondamentalmente essi si ispirano ai cosiddetti «Canti del Servo di Jhwh», il misterioso personaggio sofferente di cui parla il profeta Isaia (42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). La vita di Gesù e la sua morte sono interpretate alla luce di questi testi e alla luce del vocabolario oblativo («offrire la propria vita») e sacrificale («morire per salvare l'umanità») che questi «Canti» contengono. Questo profondo significato oblativo e sacrificale della vita di Gesù può essere però compreso solo nella dimensione della fede. Lo storico (o il critico), che oggi legge i racconti della passione, può solo affermare che Gesù è morto, che un uomo come tanti è morto. Non riuscirà però a fare l'affermazione che la morte di Gesù è stata una morte «per noi», «per me personalmente», come hanno compreso gli evangelisti e quanti si collocano nella loro dimensione di fede.
Una parola chiave per leggere i racconti della passione èil verbo «dovere/essere necessario» («È necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto, sia condannato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, sia messo a morte e risorga il terzo giorno», Lc 9,22). Questo verbo ha un profondo significato teologico, che aiuta a comprendere «perché» Gesù è morto e «chi» l'ha condotto alla croce. È il verbo che dà la visione teologica della passione, cioè che presenta «la parte» che Dio ha nella morte di Gesù, il quale non è stato crocifisso perché «tradito» da Giuda o perché «condannato» dal tribunale ebraico e da quello romano. Gesù è morto perché Dio da sempre ha pensato alla salvezza dell'uomo «consegnando» questo suo Figlio alla croce e «consegnandolo» nelle mani degli uomini (i suoi contemporanei e quelli di tutti i tempi). Gesù «deve» morire non perché su di lui incombe un destino crudele o perché vittima della cattiveria degli uomini, ma perché si è inserito in piena obbedienza in questo progetto di salvezza pensato e voluto da Dio.
Nei racconti della passione gli evangelisti intrecciano due logiche. Da una parte è presente la logica umana, secondo la quale la morte di Gesù è vista come un fallimento e come la fine di un'esistenza senza senso (è la logica di quanti «scherniscono» e «deridono» Gesù sotto la croce). Dall'altra è presente la logica di Dio (già annunciata nella vicenda salvifica del «Servo di Jhwh»), secondo la quale la salvezza dell'uomo è possibile solo attraverso «il fallimento» della croce. Essa, infatti, solo apparentemente è un fallimento. In realtà la passione è proprio il momento della regalità di Gesù. Dalla croce infatti Gesù ottiene la salvezza dell'uomo e sulla croce porta a compimento il progetto che Dio aveva pensato per l'uomo («Tutto è compiuto», Gv 19,30).
Il racconto della passione secondo Marco è racchiuso nei capitoli 14-15 del suo vangelo. È un racconto che mette in evidenza la profonda umanità di Gesù, che sperimenta la solitudine, l'abbandono, il tradimento e l'umiliazione fino alla croce. Ma è proprio da questa condizione tragica dell'umanità di Gesù che nel racconto del secondo evangelista si sprigiona la gloria della sua divinità. La passione e la croce sono, nel vangelo di Marco, la rivelazione della messianità e della divinità di Gesù, come sono affermate dalla fede del centurione sotto la croce («Davvero quest'uomo era Figlio di Dio», Mc 15,39). Lungo tutto il suo vangelo Marco aveva presentato Gesù preoccupato di far tacere i destinatari dei suoi miracoli, impedendo loro di divulgare i fatti prodigiosi che egli operava. Il motivo era questo: Gesù voleva essere riconosciuto come Messia e Figlio di Dio sulla croce, non nel successo momentaneo dei miracoli. Secondo Marco è l'umanità sofferente e umiliata del Gesù della passione «il luogo» della rivelazione della sua vera identità di Messia e Figlio di Dio.
Il racconto della passione è narrato da Luca nei capitoli 22-23 del suo vangelo. Per il terzo evangelista la passione rappresenta l'attacco decisivo di satana contro Gesù e ha un suo collegamento con l'episodio delle tentazioni («Alla fine, avendo esaurito ogni genere di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per un certo tempo», fino appunto al tempo della passione, Lc 4,13). La passione segna anche il culmine del cammino di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme (il «cammino» o «esodo» è la cornice redazionale entro la quale Luca colloca il suo racconto su Gesù). A Gerusalemme Gesù raggiunge «il traguardo» della croce e della Pasqua. La passione è inoltre il momento in cui emergono i tratti più significativi del Gesù descritto lungo tutto il vangelo di Luca. Innanzitutto lapreghiera (pensiamo all'episodio dettagliato della preghiera di Gesù nell'orto del Getsemani), poi la bontà, la misericordia e il perdono verso i «peccatori della passione»: verso coloro che lo arrestano (guarigione dell'orecchio del servo), verso Pietro che lo tradisce («Voltatosi, guardò Pietro»), verso i suoi crocifissori («Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno»), verso il ladrone che lo invoca («Oggi sarai con me in paradiso»). Luca sottolinea anche la docilità di Gesù alla volontà del Padre: la passione, infatti, non è voluta dagli uomini (nel suo racconto la responsabilità è limitata ai soli capi e lo stesso Pilato viene quasi discolpato), ma fa parte del disegno di salvezza pensato da Dio.
Il racconto della passione secondo Giovanni (18-19), pur seguendo lo schema narrativo degli altri evangelisti, mantiene una sua propria impostazione. Nella passione il quarto evangelista vede il compimento dell'ora di Gesù. Nel linguaggio giovanneo l'ora è il momento della crocifissione, quando Gesù porta a compimento la missione affidatagli dal Padre. La passione è anche il momento dell'esaltazione/glorificazione di Gesù («Quando io sarò innalzato/esaltato da terra, attrarrò tutti a me», Gv 12,32). Sulla croce egli appare in tutta la sua regalità, perché è li (e non nel successo dei miracoli) che «tutti si volgeranno a lui». La passione nel quarto vangelo è anche la manifestazione della verità su Gesù.
Nel linguaggio di Giovanni verità significa la rivelazione che Dio fa di se stesso in Gesù e la conoscenza della missione di Gesù («Io sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità»). La croce di Gesù è anche «il luogo» della riunificazione di tutta l'umanità dopo la dispersione del peccato (Gesù muore «per radunare insieme nell'unità i figli dispersi di Dio», Gv 11,52). Dalla croce di Gesù, infatti, hanno origine tutti i segni dell'unità: dalla croce nasce la Chiesa, dalla croce sgorgano i sacramenti («sangue e acqua»), dalla croce viene proclamata la maternità di Maria («Ecco tua madre»). Tutto ciò fa l'unità, la costruisce e la conserva.
L'annuncio della risurrezione
Accanto alla narrazione della passione, anche i racconti della risurrezione fanno parte del primo annuncio degli apostoli, chiamato con un termine greco kerygma («annuncio», «proclamazione»). Questi racconti non danno informazioni sul come sia avvenuta la risurrezione di Gesù (che avviene nel mistero del sepolcro e costituisce l'intervento più straordinario di Dio nel nostro mondo), ma la collocano nel contesto dei grandi interventi del Dio biblico. I racconti della risurrezione documentano questo avvenimento straordinario attraverso la descrizione della tomba vuota, delle apparizioni di Gesù e soprattutto con il riferimento alla Scrittura.
Il richiamo alla tomba vuota inserisce l'avvenimento della risurrezione di Gesù nel nostro mondo, rendendolo al tempo stesso il fatto più straordinario della storia e dell'esperienza dell'uomo. Ma non è ancora il fondamento della fede in Gesù risorto. Proprio gli evangelisti sottolineano l'incapacità dei discepoli e delle donne a riconoscere in ciò un segno della risurrezione. Anzi, produce l'effetto contrario («Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'abbiano posto», Gv 20,2).
Il richiamo alle apparizioni di Gesù risorto costituisce un documento importante che garantisce la verità della testimonianza degli apostoli, sulla quale è fondata anche la nostra fede. «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone» (Lc 24,34): questa era la prova inconfutabile che «il caso Gesù» non si era chiuso con la morte, ma era di nuovo aperto e continuava nella fede degli apostoli e della comunità cristiana. Ma anche le apparizioni non sono ancora «la fede» nella risurrezione. Certo, la tomba vuota e le apparizioni sono e restano realtà storiche. Esse dimostrano che la testimonianza delle donne di Gerusalemme e degli apostoli non è un inganno o un'allucinazione (come voleva far intendere la diceria riportata in Mt 28,13).
Ciò che invece dà significato a queste realtà storiche è la fede nella parola di Dio. Infatti, quanto si è verificato in Gesù - la risurrezione e il suo modo nuovo di essere con il corpo glorioso, non più soggetto alle categorie del tempo e dello spazio - è la realizzazione definitiva del progetto che Dio ha pensato per l'uomo. Tutte le altre realizzazioni - l'alleanza con i patriarchi, l'esodo dall'Egitto, il dono della terra promessa, il ritorno dall'esilio, gli stessi miracoli di Gesù - sono parziali, perché non hanno superato l'ostacolo della morte. In Gesù risorto, invece, si manifesta il nuovo destino dell'uomo: sarà anch'egli viventeper sempre (non morirà più) e avrà un corpo glorioso (avrà anch'egli lo stesso modo di essere di Gesù risorto). Dunque, solo chi sa leggere la storia della salvezza sa anche comprendere pienamente la Pasqua' di risurrezione. Infatti per comprendere la risurrezione è necessario conoscere l'agire di Dio lungo tutta la storia biblica. Gli evangelisti danno molta importanza a questa conoscenza quando sottolineano, da una parte, l'incapacità dei discepoli a cogliere in pienezza l'evento della risurrezione («Non avevano infatti ancora capito la Scrittura, che egli doveva ri-suscitare dai morti», Gv 20,9) e, dall'altra, che Gesù stesso si fa interprete della storia della salvezza, cioè di tutti gli interventi del Dio biblico, che ora culminano nella sua risurrezione («Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le Scritture», Lc 24,27).
Infatti è con la risurrezione di Gesù che tutta la Bibbia diventa «storia di salvezza». Il Dio che ha creato l'uomo e lo ha collocato nel mondo, che l'ha unito alla sua sposa, che ha scelto un popolo in Abramo, che lo ha liberato dalla schiavitù egiziana e lo ha introdotto nella terra della promessa, che lo ha nuovamente liberato dall'esilio' babilonese e lo ha orientato nel cammino verso il Messia, è lo stesso Dio «che ha risuscitato Gesù» (At 2,24). Le «mani» del Dio della creazione, la «destra» e il «braccio forte» del Dio dell'esodo si congiungono ora nell'intervento decisivo e definitivo che èla risurrezione di Gesù. Per questo il Nuovo Testamento sottolinea che la risurrezione di Gesù avviene «secondo le Scritture», cioè è il culmine della storia della salvezza, e avviene «il terzo giorno», proprio come venivano annunciati gli interventi del Dio biblico nei testi dell'Antico Testamento, dove questa espressione va interpretata più come una caratteristica dell'agire salvifico di Dio che non come un'indicazione cronologica.
Ma la risurrezione di Gesù è il fatto decisivo che illumina di luce nuova tutta la sua vita, le sue parole, i suoi miracoli, il suo cammino lungo le strade di Palestina, le sue parabole e la sua predicazione. Alla luce di Pasqua i discepoli comprendono che Gesù è veramente il Messia e il Figlio di Dio. Per questo i vangeli vengono fissati nello scritto dopo la Pasqua, perché è questo evento a illuminare profondamente la persona e la parola di Gesù.
La Pasqua illumina di luce nuova anche l'esperienza che i discepoli hanno fatto con Gesù, il loro Maestro. L'invito che egli fa ai discepoli perché ritornino in Galilea («Andate e annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno», Mt 28,10) significa ripercorrere nella fede pasquale il loro itinerario storico con Gesù, iniziato appunto in Galilea, dove il Maestro li aveva chiamati all'apostolato («Seguitemi e vi farò pescatori di uomini», Mt 4,19): un itinerario scandito dalle parole di Gesù, dai suoi miracoli, dalle sue parabole, da una vita vissuta insieme e fatta di amicizia, di preghiera, di fraternità. «Ritornare in Galilea» è, perciò, ritornare alle origini, dopo l'esperienza del tradimento del Maestro («Tutti i discepoli, abbandonatolo, si diedero alla fuga», Mt 26,56). Ritornando alle origini della loro chiamata, essi hanno la consapevolezza di ritornare a essere «i discepoli» di Gesù, di essere perdonati e di ricevere la nuova missione «di ammaestrare tutte le genti» (Mt 28,19).
Gli Atti degli Apostoli e la nascita della Chiesa
Come per i discepoli di Gesù, anche per l'uomo del nostro tempo la risurrezione rivela tutta la sua forza rinnovatrice e trasformatrice. La Pasqua, infatti, colloca il cristiano in un orizzonte completamente nuovo, che le lettere di san Paolo amano esprimere attraverso i verbi all'indicativo e all'imperativo. I verbi all'indicativo esprimono la nuova condizione di vita in cui è collocato il cristiano («Siete risorti col Cristo, cercate le cose di lassù dove è il Cristo...», cfr. Col 3,lss). Essa è opera gratuita di Dio, che l'uomo riceve nel battesimo. I verbi all'imperativo indicano il cammino quotidiano del credente, il suo impegno a mantenersi nella novità di vita della Pasqua, la sua tensione continua verso l'ideale di vita proposto dalla risurrezione di Gesù («Cercate le cose di lassù... pensate alle cose di lassù», cfr. Col 3,1-2).
Il vangelo non si è concluso con la morte di Gesù sulla croce, ma ha continuato nella predicazione viva degli apostoli e prosegue ora nella predicazione e nella testimonianza della sua Chiesa. La Pasqua segna il passaggio da Gesù alla Chiesa.
Gli Atti degli Apostoli, scritti dall'evangelista Luca intorno agli anni '70, raccontano come la prima comunità cristiana ha vissuto radicalmente il vangelo di Gesù, fino a diventare «un cuore e un' anima sola» (At 4,32) e a vivere l'ideale evangelico di avere ogni cosa in comune (cfr. At 4,35). Questa comunità, infatti, ha coscienza di essere la comunità delle «beatitudini» predicate da Gesù e la comunità che ha come programma di vita il Padre nostro. Sue guide sono Pietro, Paolo, Giacomo, Barnaba, Filippo, che gli Atti degilApostoli descrivono come instancabili annunciatori e testimoni del vangelo. In essa non vi sono distinzioni tra poveri e ricchi, ebrei e pagani, uomini e donne, schiavi e liberi. Ogni incarico in essa è un servizio, come ha insegnato Gesù. Servitori sono gli apostoli, i diaconi e quanti operano nella carità, scelti non secondo il criterio dell'efficientismo, ma secondo la logica del vangelo («Se uno tra voi vuole essere grande, sia vostro servo, e chi tra voi vuole essere primo, sia schiavo di tutti», Mc 10,43-44). Questa perciò è la comunità con la quale deve confrontarsi ogni nostra comunità di oggi e di sempre, per dare un' anima alle istituzioni e alle iniziative che le caratterizzano.
Protagonisti degli Atti degli Apostoli sono Pietro e Paolo. La figura di Pietro è presentata accanto ai cristiani che provengono dall'ebraismo. A essi Pietro rivolge la sua predicazione, sempre ricca di riferimenti e di citazioni dell'Antico Testamento, proprio per aiutarli a meglio comprendere chi è Gesù e qual è il significato della sua missione nel mondo. La figura di Paolo è invece presentata accanto ai cristiani che provengono dal paganesimo. A essi Paolo annuncia la proposta di fede di Gesù e la novità di vita a cui essa conduce.
Questa diversa missione dei due apostoli alle volte appare fonte di una certa tensione e di una certa problematicità. Infatti gli ebrei entrati nella comunità cristiana pretendevano che si continuasse nell'osservanza della legge mosaica e della circoncisione. I pagani che accoglievano il vangelo erano invece esortati da Paolo a seguire Gesù, e lui solo. Per Paolo la legge aveva la funzione di preparare al vangelo e a Gesù.
Il concilio di Gerusalemme (At 15) chiari questa situazione, dichiarando che i cristiani provenienti dal paganesimo non dovevano sottostare alle pratiche dell'ebraismo. L'attività missionaria di Pietro e Paolo riprese allora nuovo slancio, fino a raggiungere la città di Roma, che, nello schema teologico degli Atti, segna il traguardo della «corsa» della parola di Dio annunciata e diffusa.
La nota fondamentale degli Atti è, infatti, l'attività missionaria. Secondo la teologia neotestamentaria la salvezza dell'uomo (ebreo e pagano) è strettamente legata all'annuncio della parola di Dio e alla sua diffusione. Il Nuovo Testamento conosce quindi, negli Atti degli Apostoli, un movimento che va da Gesù agli apostoli e alla Chiesa e raggiunge l'uomo là dove egli si trova e là dove egli opera. Secondo la concezione dell'Antico Testamento (presente soprattutto in Is 56-66), la salvezza è invece immaginata come un «venire a Gerusalemme» e come un riconoscere il suo ruolo nel progetto salvifico di Dio. Gli Atti degli Apostoli superano ogni concezione ristretta della salvezza, limitata al solo popolo biblico e alle sole regioni bibliche («Riceverete la forza per essermi testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, la Samaria efino all'estremità della terra», At 1,8). Attraverso l'annuncio della risurrezione di Gesù e del suo vangelo a ebrei e pagani, a vicmi e lontani, a ferventi e a indifferenti, questo libro vuole dimostrare che Gesù risorto è il Signore e il Salvatore di tutta l'umanità.
L'Apostolo delle genti e le sue lettere
Paolo (in ebraico Shaul, in latino Paulus) nasce a Tarso, nell'attuale Turchia, da una famiglia profondamente radicata nell'ebraismo. Sebbene contemporaneo di Gesù, non lo ha certamente conosciuto di persona. Discepolo di Gamaliele (un grande rabbino della sua epoca), Paolo imparò a scuola l'ebraico, la lingua della Bibbia; in casa l'aramaico, la lingua parlata da Gesù; conosceva molto bene anche il greco, la lingua ufficiale dell'impero romano, nella quale scrisse le sue lettere. Dopo la conversione a Damasco (At 9), Paolo si dedicò totalmente alla diffusione del cristianesimo, fino ad arrivare a Roma, dove, con Pietro, morì martire durante la persecuzione di Nerone (64/67 d.C.).
Molte cose accomunano ancora il cristianesimo di questi nostri anni, ormai prossimi al terzo millennio, alla vita delle comunità cristiane fondate da Paolo. Innanzitutto la comune realtà delle grandi città in cui viviamo noi oggi e le grandi città dell'impero romano evangelizzate da Paolo (Corinto, Atene, Tessalonica, Efeso, Roma). Non è vero che il cristianesimo non possa avere più presa sulle grandi città. Queste, infatti, non sono solo anonimato, corruzione, droga, mafia, delinquenza, ma, come ai tempi di Paolo, «in esse Dio ha un popolo numeroso» (cfr. At 18,10). Come è stata possibile la prima evangelizzazione per opera di Paolo, così è possibile anche la seconda evangelizzazione propria del nostro tempo.
In secondo luogo Paolo offre la chiave per risolvere i problemi dell'uomo di ogni tempo, che egli affronta alla luce del mistero di Dio, che ama e salva l'umanità in Gesù Cristo. Alla luce di questo mistero, per Paolo non c'è differenza che possa discriminare l'uomo e la donna, lo schiavo e la persona libera, il sapiente e chi colto non è. Egli ha lavorato dall'interno la cultura greco-romana, avviandola a un felice e riuscito incontro con i valori del vangelo. Ha parlato del matrimonio da vivere «nel Signore»; della vita di famiglia e degli impegni sociali da vivere nell'onestà e nella iealtà dei rapporti. Ha parlato della Chiesa come sposa di Cristo. Ha presentato il popolo ebraico come la radice della comunità cristiana.
Le sue parole più dure sono per coloro che scelgono di «vivere secondo la carne», cioè per quanti rimangono indifferenti alla persona e al vangelo di Gesù.
Il suo impegno è stato quello di condurre gli uomini «a vivere secondo lo Spirito», cioè nella dimensione della salvezza e della fede nella quale la Pasqua di Gesù ha per sempre collocato l'uomo.
Le lettere di Paolo rientrano tra gli scritti del ~uovo Testamento. Si tratta dii 3 scritti occasionali, di ampiezza e contenuti diversi, stilati sotto la spinta di necessità particolari e per sviluppare la catechesi sul cristianesimo alla luce delle parole e della vita di Gesù.
Scritte tra il 51 e il 71 d.C., le lettere di Paolo sono tra i testi più antichi del cristianesimo: sette di esse scritte personalmente da lui, le altre attribuibili a suoi discepoli. Queste lettere vengono suddivise in tre gruppi: le grandi lettere di Paolo; 1/2 Tessalonicesi; 1/2 Corinti; Romani; Galati; lettere della prigionia (scritte cioè durante la permanenza di Paolo in carcere): Filippesi; Filemone; Colossesi; Efesini; lettere pastorali (così chiamate perché si riferiscono all'ordinamento e al governo pastorale delle comunità cristiane): 1/2 Timoteo; Tito.
Nella seconda lettura di ogni domenica, tratta quasi sempre da una di queste lettere, sentiamo ancora l'eco della loro vita, delle loro difficoltà e della catechesi efficace dell'apostolo Paolo.
Le lettere cattoliche e l'Apocalisse
Ormai lontani dal tempo di Gesù, i cristiani della seconda e terza generazione avvertivano il bisogno di «risentire l'eco» della sua parola (come indica il termine catechesi), di essere nuovamente formati alla luce delle sue esigenze e di ri-scoprire la freschezza del suo vangelo. Il loro tempo è caratterizzato dalle persecuzioni, dal sorgere delle prime eresie (= errata interpretazione del vangelo e della persona di Gesù) e dalla costatazione che la seconda venuta di Gesù, da tutti ritenuta imminente, è invece lontana dal verificarsi. A queste comunità cristiane è rivolta la catechesi racchiusa negli ultimi scritti del Nuovo Testamento, che utilizzano una delle forme di comunicazione più in voga nell'antichità, la lettera.
La catechesi di queste lettere affronta le situazioni vitali delle comunità a cui è rivolta. Se la comunità è perseguitata, la lettera contiene parole di esortazione e di speranza; se la comunità è percorsa da deviazioni nell'interpretazione del vangelo e della persona di Gesù, la lettera contiene richiami alla vera dottrina; se la comunità rischia di conformarsi al mondo pagano o alle mode correnti, non ricordando più gli impegni del battesimo e le esigenze del vangelo, la lettera richiama a una vita più coerente e a una fede più intensa.
In queste righe abbiamo sintetizzato il contenuto delle lettere del Nuovo Testamento (la cui attribuzione è fittizia), che sono: la lettera agli Ebrei, le due lettere di Pietro, la lettera di Giacomo, le tre lettere di Giovanni e la lettera di Giuda. In questa sintesi può essere collocato anche il contenuto dell'ultimo scritto del Nuovo Testamento, l'Apocalisse, che èpresentato come una «~lettera» scritta alle «sette Chiese che sono in Asia» (Ap 1,4). In queste lettere la rivelazione che Dio fa di se stesso viene descritta attraverso le stesse immagini dei primi libri biblici. È il Dio che «l'uomo ha veduto con i propri occhi», «ha toccato con le proprie mani» e di cui «ha udito la voce e le parole» nella persona di Gesù di Nazaret, il Verbo della vita. Tutta la Bibbia, scandita dai verbi «vedere», «camminare», «udire», «parlare», raggiunge il suo traguardo nell'incontro con il Messia Gesù «venuto a salvare chi era perduto». Queste prime comunità cristiane ritmano la loro vita e la loro fede alla luce di questa visione biblica ed evangelica.
Il libro dell'Apocalisse si chiude con il suggestivo richiamo a una nuova creazione («un nuovo cielo e una nuova terra») e a una «nuova Gerusalemme». C'è quindi uno stretto legame tra il primo libro della Bibbia (quello che descrive la creazione dell'uomo e del mondo) e l'ultimo suo libro (l'Apocalisse che parla della salvezza totale dell'uomo e del mondo). La prima creazione, offuscata dalla disobbedienza di Adamo, è resa di nuovo luminosa dall'obbedienza di Gesù.
Il richiamo alla «nuova Gerusalemme», ricostruita e abitata da Dio, è simbolo dell'uomo riconciliato con Dio e divenuto di nuovo «sua immagine e somiglianza». Ma è anche simbolo della comunità di fede, della nostra Chiesa, amata e guidata da Gesù (che l'Apocalisse ama chiamare «Agnello»). Essa diventa così modello delle comunità cristiane di ogni tempo.