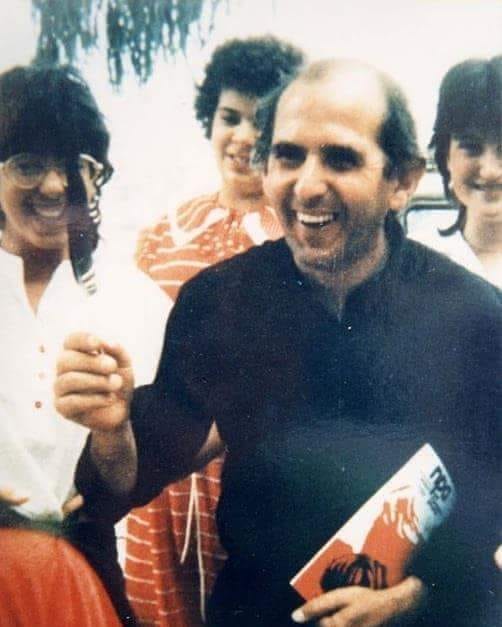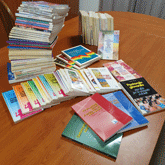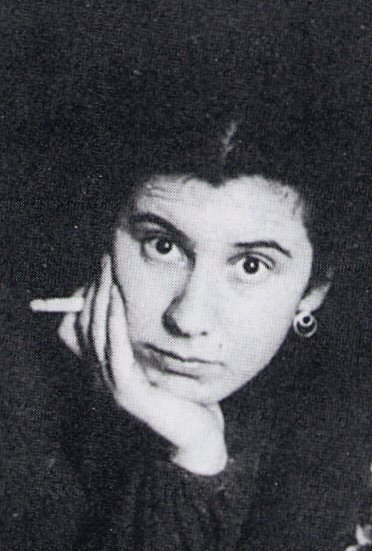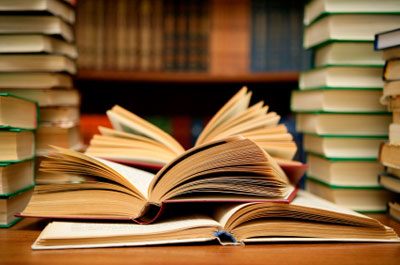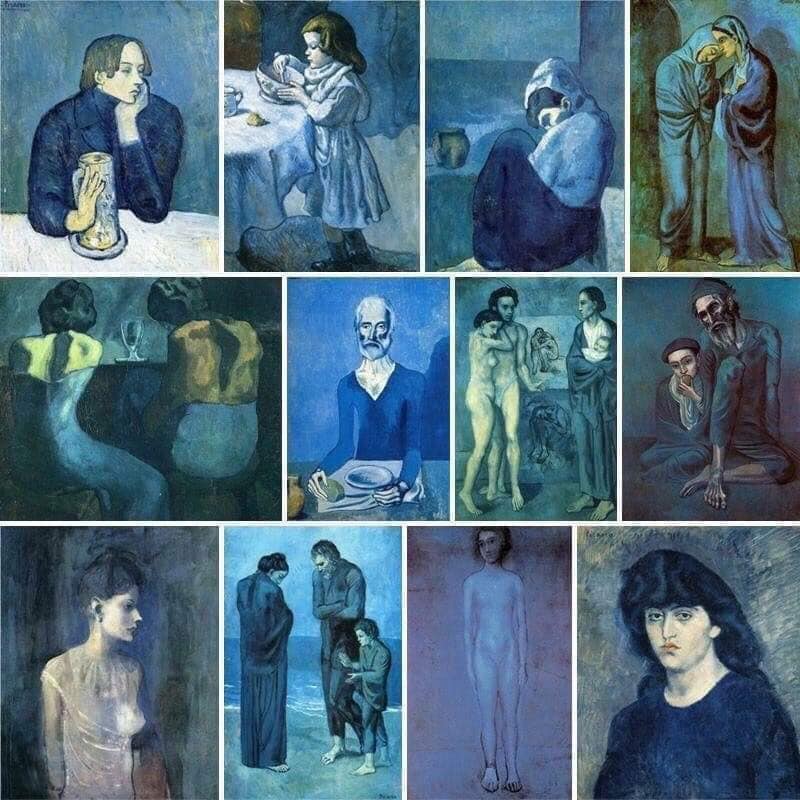Il creato manifesta
la gloria di JHWH
Gianantonio Borgonovo
«I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani; il giorno al giorno enuncia il detto, la notte alla notte dà la notizia. Non è loquela, non sono parole, non si ha percezione del loro suono; in tutta la terra uscì il loro richiamo, ai confini del mondo le loro parole» (Sal 19,2-5).
L'attacco solenne e grave del salmo 19 - riletto magari con gli occhi musicali illuminati dalla vivacità barocca dell'Estro poetico armonico di Benedetto Marcello - ci introduce nel tema della «natura» secondo i libri della Scrittura ebraica e di quell'insieme che noi cristiani definiamo Antico Testamento. Di «natura» e di «mondo» la Bibbia ebraica parla solo in modo indiretto. Ai testi biblici, da Genesi fino alla Sapienza, non interessa la prospettiva analitica dello scienziato che considera «oggetto di studio» quanto le sue ipotesi scientifiche devono verificare. Ciò che a essi sta a cuore è la prospettiva sintetica del poeta e del credente, i quali di fronte al mondo e alla natura colgono l'al di là delle cose con una percezione simbolica che esprime e si lascia trasportare dalla contemplazione di un linguaggio non fatto di parole e di vocaboli linguistici, ma trama di un discorso non meno vero e penetrante. Come affermava lo studioso Romano Guardini parlando dell'aspetto mistico della poesia di Rainer Maria Rilke: «Lo spazio dell'anima non è il campo psicologico della coscienza e del sentimento, bensì quello dell'intimità e della metamorfosi poetica. E lo spazio delle stelle non è quello osservato e calcolato dall'astronomo, bensì la sfera del mito, della trasfigurazione degli eroi che hanno trovato un posto in cielo come costellazione».
Il mondo creazione di Dio
Cielo e terra, estremi della totalità dell'universo per il salmista, sono i fuochi di un'ellisse asimmetrica: il cielo proclama il linguaggio della gloria di Dio su tutta la terra. E l'asimmetria che parte dalla concezione cosmologica tipica di tutta l'antichità, al cui centro sta la piattaforma terrestre con l'uomo: una prospettiva antropocentrica, che è paragonabile nella vita di ogni individuo alla percezione infantile del mondo, quella non ancora obiettivata dalla capacità critica. Nell'asimmetria del polarismo vi è anche la coscienza del limite della «potenza» umana, al di sopra della quale sta Dio: «I cieli sono cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo» (Sal 115,16).
Anche la prima pagina di Genesi disegna una mappa di due regni dai confini precisi, i cui «governatori» stanno in relazione al Creatore in modo diverso. Il cielo, e con esso la scansione del tempo, sta sotto il dominio (mashal) degli astri, declassati dal rango di divinità, quali erano venerati a Babilonia o in Egitto, alla pur grande funzione di essere «segni per feste, per giorni e per anni» (Gn 1,14). E il salmo 19 allude a questo dominio, parlando di una comunicazione ordinata e stabile di «giorno a giorno» e «notte a notte». Al di sotto, sulla «terra» vige la signoria dell'uomo: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela (kabash) e abbiate dominio (rada) sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sul bestiame e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra» (Gn 1,28).
Un altro salmista, un contemplatore pieno di stupore per la «gloria» del nome divino nel creato e acuto estimatore dell'impasto di grandezza e miseria presente nell'uomo, riprenderà l'immagine di Gn 1 per suscitare la domanda cruciale. Essa è posta proprio all'incrocio - letteràrio, teologico, esistenziale - della sua composizione, tesa tra la vittoria del Creatore sulle potenze caotiche e l'incoronazione dell'uomo quale governatore (mashal) della terra: «Che cos'è l'uomo ché ti ricordi di lui? Che cos'è il figlio d'uomo ché diluiti prendi cura?» (Sal 8,5).
Jhwh, con la sua vittoria sulle potenze caotiche, ha creato il cielo e la terra, la luna e le stelle, e il loro ordine stupefacente; e l'uomo, cui è stato dato il dominio sulla terra, che cosa saprà fare?
L'universo per gli autori biblici non è dunque una res extensa da studiarsi oggettivamente sulla scorta dileggi scientifiche. Anche l'osservazione più «laica» della realtà, quale ci è stata trasmessa dalla tradizione sapienziale antica (cfr. Proverbi), non è un'analisi che prescinda dal riconoscimento del Dio creatore. Un orizzonte di pensiero, che non tenesse conto di ciò, non poteva darsi. Le osservazioni esperienziali analitiche della tradizione sapienziale vengono lette, da coloro che le raccolsero e le ordinarono, come la legge che Dio ha imposto alla sua creazione.
In termini più vicini al loro linguaggio, esse sono «sapienza» (hokma), la quale da progetto immanente nel mondo (Pr 8) diviene progressivamente rivelazione di Dio all'uomo (Gb
28), incarnata nella Torah (Sir 24) e, alla fine, mediazione attiva nell'opera creatrice e nella storia salvifica (cfr. Sap 7-9), riassumendo in se stessa i tratti tipici dello Spirito vivificante e della Parola creatrice.
Non vi è un cosmo autosufficiente, ma creazione in totale dipendenza da Dio e dalla relazione etica stabilita dall'uomo con Dio. «Israele non vedeva il mondo come un organismo ordinato e autosufficiente, in quanto da un lato nel suo divenire vedeva molto più direttamente l'opera di Jhwh, e dall'altro vi avvertiva anche il contributo dell'uomo, che pure, con le sue azioni buone e cattive, determinava incessantemente le reazioni dell'ambiente circostante» (G. von Rad). Ciò significa che ogni fenomeno «naturale» viene percepito nella sua valenza mitico-simbolica come linguaggio che narra le meraviglie e la potenza di Dio.
D'altra parte, proprio il senso dell'assoluta trascendenza e alterità di Dio rispetto al mondo creato permetterà un' autentica demitizzazione e secolarizzazione della creazione e aprirà la strada a un approccio critico e scientifico. Solo un mondo non divinizzato, ma «narrazione» della gloria divina, può diventare «cosmo», possibile oggetto di considerazione scientifica.
Osservando la storia dello jahvismo, si nota che la professione di fede d'Israele in Jhwh non è avvenuta per via deduttiva, ma storica ed esperienziale. Israele al Sinai incontra il Dio liberatore dell'esodo, quel «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» che adempie pienamente la promessa di vicinanza rivolta ai padri: «Io ci sarò» (cfr. Es 3). In questa attuazione di vicinanza e di liberazione è implicita la sua forza creatrice, capace di dominare il corpo vivente della creazione.
Sono stati necessari altri catalizzatori perché si giungesse a parlare di Jhwh creatore, come, ad esempio, il confronto con la cultura cananaica, mesopotamica o egiziana. Va ricordato a questo proposito che le sintesi della fede jahvista, quelle che - seguendo Martin Noth - vengono chiamate il «piccolo credo storico» (Dt 26 e Gs 24), iniziano la loro confessione con Abramo e non dicono nulla della creazione. La creazione era comunemente riconosciuta anche nelle culture circonvicine e per questo non divenne un «articolo di fede». L'eventuale problema non era se Dio avesse creato il mondo, ma quale Dio l'aveva creato.
Che Jhwh fosse il creatore era affermazione già implicita nel fatto che egli era in grado di dominare gli eventi della storia. Basti ricordare due pagine, tra loro abbastanza diverse, eppure da leggersi in parallelo per illuminare la nostra considerazione.
La prima è la grande epopea narrata nel libro dell'Esodo
(Es 7-14), con il «decalogo» delle piaghe poste in esecuzione da Mosè e Aronne contro il faraone e con la solenne «liturgia» del passaggio del Mar Rosso, così almeno è presentato l'attraversamento del mare dai testi che provengono dalla tradizione sacerdotale. Tutti gli elementi della creazione, fenomeni climatici, botanici e zoologici, e soprattutto il mare - evocazione mitica del caos primordiale - sinfonicamente esprimono il giudizio del Dio liberatore a favore dell'oppresso contro l'ingiustizia, incarnata in quel momento dall'Egitto.
Rimeditando il racconto dell'esodo in uno stupendo midrash (cfr. Sap 10-19), l'autore del libro della Sapienza, vissuto qualche decennio prima di Cristo probabilmente ad Alessandria, coglie nel segno quando ricapitola l'evento fondatore esodico con questa dossologia: «Tutta la creazione nel suo genere si rimodellava di nuovo come prima, servendo ai tuoi ordini, perché i tuoi figli fossero custoditi illesi. [...] Gli elementi si armonizzavano tra di loro, come le note in un'arpa mutano il nome del suono, conservando sempre la tonalità. [...]In tutto, Signore, hai reso grande il tuo popolo e lo hai glorificato e non l'hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo» (Sap 19,6.18.22).
La seconda pagina è invece un giudizio di condanna di Jhwh contro il suo popolo, pronunciato dal profeta Amos, il «raccoglitore di sicomori» venuto da Teqoà per predicare a Betel e Samaria nella prima metà dell'VIlI secolo a.C., con parole gravide di minaccia, ultimo appello perché Israele potesse sperimentare - forse! ('ulaj, Am 5,15)- la misericordia del suo Dio. Mi sto riferendo alla straziante litania di Am 4,6-12. Per cinque volte risuona il pesante giudizio: «Ma non tornaste fino a me. Oracolo del Signore».
Un duro verdetto, ripetuto da Amos dopo ciascuna menzione di una serie di sciagure che avrebbero dovuto scuotere Israele dal torpore annebbiato dall'ingiustizia sociale: fame, siccità, carbonchio e cavallette, peste, terremoto. Anche qui Jhwh usa gli elementi della creazione per esprimere il suo giudizio. E il redattore ha posto in un'adeguata cornice questo passo, collocandovi subito di seguito uno degli «inni al Creatore» che, come opportune pause liriche, spezzano il ritmo irruente del libretto di Amos: «Ecco colui che plasma i monti e crea il vento, che palesa all'uomo qual è il suo pensiero, colui che trasforma l'aurora in oscurità e cammina sulle sommità della terra: Signore, Dio delle schiere è il suo Nome» (Am 4,13).
Israele ha dunque «incontrato» nella sua storia il Dio liberatore. La potenza creatrice era implicita nella confessione di un Dio che agiva con efficacia nella storia del suo popolo. Come una creazione continuamente in atto, tutto era visto in stretta dipendenza dalla causalità divina, ultima e unica. Non si era interessati alle causalità intermedie, alle quali invece prestano la loro precisa attenzione le diverse scienze, per determinare le diverse «leggi» - astronomiche, fisiche, economiche, sociali o psicologiche - che possano interpretare gli eventi del nostro mondo.
Un cambiamento di prospettiva è rintracciabile nella ricca tavolozza simbolica dell'abile profeta anonimo dell'esilio babilonese, che ha lasciato i suoi scritti nei capitoli 40-55 del libro di Isaia e che convenzionalmente chiamiamo Secondo Isaia.
Nelle sue pagine, quanto abbiamo detto sin qui sembra capovolgersi. L'affermazione che Jhwh è il creatore unico dell'universo non è più la conseguenza della sua azione storica o la sua implicazione, ma il fondamento per poter annunziare un nuovo intervento nella storia, ancora più grandioso del primo esodo.
Tra tutti i testi possibili, ricordo Is 51,9-11, in quanto vi è un intreccio evidente fra il momento originario della creazione, espresso con immagini mitiche, l'evento del primo esodo e l'annuncio della nuova liberazione: «Risvègliati, risvègliati, rivèstiti di forza, o braccio del Signore, risvègliati come nei giorni antichi, al tempo delle generazioni passate! Non sei forse tu quello che hai spezzato Raab, e hai trafitto il dragone? Non sei forse tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada, perché i redenti l'attraversassero? Quelli che il Signore ha liberato, ritorneranno, arriveranno a Sion acclamando...».
Anche nel Secondo Isaia, tuttavia, la connessione tra il gesto creatore di Dio e il nuovo intervento storico invocato e annunziato, non relega la creazione al solo' momento originario del passato. L'universo viene sentito ancora di più come il luogo dell'iniziativa salvifica di Dio, il «totalmente Altro», ma anche il sempre presente, il «Santo d'Israele», come amava chiamarlo Isaia: ogni momento salvifico è «creazione» e la creazione è già storia salvifica.
Il progetto ideale di Dio nella creazione
A partire dalla storia come teatro dell'azione salvifica divina, gli autori biblici, in dialogo con le culture circonvicine, sono giunti a parlare anche del momento originario della creazione. Il loro interesse non è mai direttamente scientifico, ma rimane sempre teologico e antropologico. Ciò spiega la molteplicità dei linguaggi utilizzati e la sensibile diversità delle narrazioni: l'inno di lode di Gn 1, il racconto «eziologico» di Gn 2, l'orchestrazione mitica del Sal 8 o Is 51, gli ampi voli poetici del Sal 104 o Gb 38-41... La creazione rimane sempre «mistero», rivelazione dell'alterità del Dio nascosto nella simbolicità dèlla storia. E del «mistero» si può parlare solo polifonicamente e senza la pretesa di esaurirne l'essenza, ma progettando ogni volta un orizzonte di nuovi significati.
In effetti, se si leggono con occhio critico le prime pagine di Genesi, si è portati a riconoscere che esse non sono la ricerca delle «cause» in prospettiva scientifica, ma piuttosto l'«offerta di senso» capace di leggere la creazione in un quadro determinato dal dialogo tra il Dio che si rivela nella storia e un popolo che vive in relazione a lui. Per questo motivo la «protologia» di Genesi è accostabile ai grandi progetti escatologici delle pagine profetiche e la sua simbolica viene riutilizzata e rimitologizzata dalle speculazioni apocalittiche.
Così, il settenario di Gn 1, 1-2,4a è un invito a leggere la bontà e bellezza (tòb) del creato, come l'ha pensato e fatto il Creatore. L'ordine di tutte le cose è espresso in questa pagina della tradizione sacerdotale come separazione e distinzione di tutti gli elementi, in tensione verso un fine: separazione di luce e tenebre, di acque sopra e sotto il firmamento, di mare e terra asciutta; distinzione di tutta la vegetazione e gli animali «secondo la loro specie»; centrale, nel quarto giorno, è l'ordine del tempo scandito dalle luci nel firmamento. E infine l'uomo, «maschio e femmina», fatto «a immagine di Dio», cioè interlocutore libero di un progetto di dialogo che da li in avanti può iniziare: «Dio li benedisse e disse loro» (Gn 1,28).
L'uomo è il vertice di tutta l'opera di Dio, ma un vertice incompiuto, perché anch'egli appartiene al sesto giorno, anch'egli è in cammino verso il settimo giorno di Dio, il giorno della pienezza della gloria di Dio e della sua presenza, il compimento di ogni «fatica» di Dio. Tutta la creazione, guidata dall'uomo quale «re» e luogotenente di Dio, è in marcia verso questo giorno finale che appartiene solo a Dio: in esso si rivela una fecondità medita, nei cui confronti la benedizione già data agli esseri viventi e all'uomo è solo una piccola caparra: «Dio benedisse il giorno settimo e lo consacrò» (Gn 2,3).
Abraham J. Heshel, in un saggio giustamente famoso sul significato del sabato nella tradizione ebraica, sottolineava la valenza escatologica del «settimo giorno» di Dio nel sabato dell'uomo: «La legge del sabato cerca di convogliare corpo e spirito nella dimensione del sacro; essa cerca di insegnarci che l'uomo e in relazione non soltanto con la natura, ma anche con il Creatore della natura. Che cos'è il sabato? È lo spirito sotto forma di tempo. Con il nostro corpo noi apparteniamo allo spazio, ma il nostro spirito, la nostra anima, si leva verso l'eternità e aspira al sacro. Il sabato è ascesa a un vertice... Il sabato è un microcosmo dello spirito, come se riunisse in sé tutti gli elementi del macrocosmo dello spirito».
Il racconto di Gn 2,4b-25 manifesta invece un interesse complementare, orientato a comprendere le grandi domande dell'uomo di sempre a partire dalla storia d'Israele. Normalmente attribuito allo Jahvista, nome convenzionale di un autore o di una scuola teologica che - nel X o IX secolo a.C., sotto Salomone o poco dopo - avrebbe cercato di giustificare il grande impero salomonico, collocandolo nelle coordinate delle tradizioni patriarcali e nella confessione di fede esodica, Gn 2 è una narrazione ricchissima di elementi mitici, che affondano le loro radici nell'humus comune alla cultura del Vicino Oriente antico. Essi diventano un linguaggio plasmato per descrivere il quadro ideale del dialogo tra Jhwh e il suo popolo, tra Dio e l'umanità. Lo Jahvista parte dal suo orizzonte storico; parte dunque dalla comprensione della storia della salvezza probabilmente già configurata nella categoria di «alleanza».
Come in filigrana, scopriamo dietro il racconto di Gn 2 la vicenda del popolo di Israele, quale trama paradigmatica per parlare dell'uomo - 'adam nel progetto ideale di Dio. L'uomo viene plasmato dalla terra e fatto riposare nel giardino, per coltivarlo e custodirlo. Nel giardino, viene dato all'uomo un comandamento e una legge, come ulteriore occasione per mettersi in relazione con Dio. Così, Israele viene fatto uscire dall'Egitto, plasmato nel deserto (alcuni testi, come Is 44,2 usano lo stesso verbo) e fatto riposare nella terra della promessa (linguaggio tipicamente deuteronomista). Al Sinai il popolo ha ricevuto il comandamento e le leggi, con l'opportunità di rispondere all'«alleanza» divina.
Il parallelo può continuare anche nell'eziologia del reale di Gn 3. L'uomo, istigato dall'assurdo del «male», narrativamente espresso dalla figura del serpente, legge il comandamento come «limite» imposto alla sua libertà e pensa di emanciparsi rinunciando a esso. Vi è una parola di Dio che interpella l'uomo dopo la trasgressione: egli sente la voce di Jhwh nel giardino e ha paura. Ne nasce un processo, la cui sentenza è stilata con maledizioni e benedizioni: la vita che continua rendendo la donna «madre dei viventi». Così la storia dell'alleanza ha visto la reiterata ribellione d'Israele, con l'abbandono del comandamento, alla ricerca di altri dèi. La parola profetica ha continuamente interpellato l'Israele storico, con l'invito ad ascoltare la voce di Dio. Per mezzo dei profeti, Dio ha istruito processi contro il suo popolo, invitando Israele a riandare all'origine del patto: maledizioni e benedizioni concludono ogni stipulazione di alleanza (cfr. soprattutto Dt 28,lss.lSss).
Il «principio» delle prime pagine di Genesi è in verità una risalita al cuore dell'essere, è il quadro ideale della creazione vista nella prospettiva di Dio, non ancora ferita dalla ribellione della libertà umana.
Nella considerazione ideale dei rapporti costitutivi dell'umanità, troviamo anche la descrizione della «pace» e del benessere che l'uomo era destinato a vivere con la natura. Il conflitto che invece l'umanità sostiene in ogni momento della storia con il suo ambiente e con gli animali viene assunto dagli autori biblici come indizio di un disordine presente sì in questa creazione, ma assente dalla bellezza voluta dal Creatore. L'uomo storico è in grado di sognare questo ideale, perché è stato fatto per esso, ma si trova drammaticamente vinto dalla dura realtà che lo rende schiavo. E la sproporzione, la «mancanza» - in senso forte - introdotta dal peccato. Accanto alle considerazioni che riguardano il rapporto uomo-Dio (Gn 3 e 6,1-4), uomo-donna (Gn 3), fratello-fratello (Gn 4,1-16), padre-figli (Gn 9,19-26) e le relazioni con il progresso (Gn 4,l7ss) e tra le «città», cioè tra gli stati (Gn 11,1-9), emerge anche l'ideale di un ecosistema, colto dalla nostra intelligenza, ma purtroppo non realizzato.
La «terra» e gli «animali» sono gli attori che esprimono narrativamente il progetto ecologico ideale. Nei primi capitoli di Genesi vi sono accenni interessantissimi al riguardo, che non dobbiamo lasciar cadere.
In Gn 1, l'uomo è creato con il compito di «soggiogare» la terra e di «dominare» sugli animali. Non lasciamoci ingannare dalla traduzione che, come sempre, può introdurre valori semantici estranei ai vocaboli della lingua di parten
za. I due verbi ebraici che ci interessano sono abbastanza precisi. «Soggiogare» (kabash) è il verbo che caratterizza soprattutto il rapporto tra padrone e schiavo (cfr. ad esempio: Ne 5,5) oppure il rapporto di sottomissione di un popolo al vincitore (cfr. Gs 18,1). Non pensiamo però al rapporto padronale con la nostra sensibilità odierna. E già la legge più antica circa gli schiavi, contenuta nel cosiddetto «Codice dell'alleanza», ingiungeva, infatti: «Quando acquisterai uno schiavo ebreo, ti servirà per sei anni e al settimo sarà messo in libertà, senza riscatto» (Es 21 ,2ss). Non è cosa da poco. Il regime di schiavitù, vale a dire il rapporto di lavoro nella società antica, almeno nel caso di schiavi ebrei, prevedeva già nella più antica legge la libertà «sabbatica».
La stessa attenzione, che vieta uno sfruttamento indiscriminato, riguarda anche la terra: «Per sei anni seminerai la tua terra e raccoglierai il suo prodotto, ma al settimo non la coltiverai e la lascerai riposare» (Es 23, 10ss). Tutto questo non è forse espressione di una grande idealità ecologica, in cui bisognava riconoscere il riposo «sabbatico» anche alla terra, sentita come organismo vivo?
Analogamente, nel secondo capitolo della Genesi, il rapporto di pace tra l'uomo e la terra risulta dalla notazione positiva che l'uomo viene collocato nel giardino per «coltivarlo» e «custodirlo».
Il dominio dell'uomo sugli animali è espresso in Gn 1,26.28 dal verbo rada, il verbo caratteristico del governo regale (cfr. ad esempio: Sal 72; 110; Is 14...). Si tenga anche qui presente che nel Vicino Oriente antico il re non era soltanto un'autorità di governo, ma la personalità che corporativamente rappresentava tutto il popolo: il benessere del re e del popolo correvano su sintonie biunivoche.
In modo più narrativo, Gn 2 enuncia lo stesso rapporto regale, quando l'uomo dà il nome a tutti gli animali, in segno della sua autorità, benché non trovi in essi «un aiuto a lui corrispondente». Le pagine bibliche non perdono mai il sano equilibrio e le corrette proporzioni dell'ecosistema.
Il rapporto regale che unisce l'uomo agli animali ha alcune valenze che mette conto di esplicitare. Sorprende e fa pensare il rapporto che sussiste tra la «decima» parola pronunciata dal Creatore in Gn 1, in cui si manifesta la cura provvidente per il sostentamento vegetariano dell'uomo, e il comando ripetuto in Gn 9 - sempre un testo della tradizione sacerdotale - con la nuova possibilità di mangiare anche la carne degli animali, seppure priva di sangue. Se Gn 9 rappresenta il regime storico in cui la nostra umanità si trova a vivere, Gn 1 ne è invece il progetto ideale.
In Gn 1 l'uomo domina quale «re» e luogotenente di Dio sul regno animale; in Gn 9 s’insinua il timore e il terrore a rompere l'equilibrio. La relazione pacifica è diventata conflittualità. Con simbolica analoga, anche lo Jahvista parla di questa rottura: mentre in Gn 2 l'uomo dà il nome a tutti gli animali, in Gn 3,15 viene denunciata l'«inimicizia» implacabile tra la stirpe della donna e quella del serpente.
Il conflitto con il regno animale assume un immediata con-notazione simbolica. L'uomo è diventato homini lupus e l'uccisione di animali allude alla ferocia fratricida: «Certamente del sangue vostro, ossia della vita vostra, io domanderò conto:
ne domanderò conto a ogni animale; della vita dell'uomo io domanderò conto alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello!» (Gn 9,5). Il cuore dell'uomo diventa una tana in cui si accovaccia il terribile demone del fratricidio (cfr. Gn 4,7) e Abele ne è la prima vittima.
Ma «in principio» non era così. E anche la prospettiva escatologica dei profeti e dell'apocalittica promette come «fine» della storia lo stesso ideale originario. Is 11, descrivendo l'elezione gratuita e la solenne incoronazione del rampollo di lesse, parla di una nuova creazione riplasmata attorno a questo nuovo re con simboli che riportano all'ideale genesiaco:
due settenari che uniscono a coppie animali domestici e feroci, e alla fine di ciascuno di essi l'«Uomo nuovo», nella figura di bambino, che giunge persino a vivere in pace con il «serpente»: «Il lupo abiterà insieme all'agnello e la pantera giacerà insieme con il capretto; il vitello e il leone pascoleranno insieme, un piccolo bambino li guiderà. La vacca e l'orso pascoleranno, i loro piccoli giaceranno insieme, il leone come il bue si nutrirà di paglia. Il lattante si divertirà sulla buca dell'aspide e il bambino porrà la mano nel covo della vipera» (Is 11,6-8). L'ecosistema escatologico è ritorno alla «pace» voluta dal Creatore per l'uomo c'reato «a immagine di Dio».
Anche in Daniele, in un capitolo (Dn 7) che giustamente il Nuovo Testamento ha particolarmente amato, volendo de-scrivere il giudizio divino sulla storia, si ricorre alla simbolica genesiaca del rapporto dell'uomo con gli animali. L'oceano, tradizionalmente considerato l'elemento ostile della lotta mitica primordiale, ha continuato a partorire «bestie osti-li»: è il quadro storico reale, in cui sembra che le potenze del male abbiano la meglio. Di contro, dopo la sentenza divina, ecco apparire le nubi - elemento celeste - che accompagnano (o trasportano, secondo la versione greca) l'Uomo.
Di fronte dunque alla sequenza di fiere che si succedono nella storia senza migliorare l'umanità, anzi peggiorando in ferocia, si erge, in contrasto, l'Uomo che fa parte di un'al-tra categoria, perché è stato voluto a immagine di Dio, «custode» della terra e «re» su tutti gli animali. La creazione, guardata con gli occhi di Dio, non va dunque verso una progressiva «bestializzazione», ma verso la sua piena «umanizzazione». E il capostipite della nuova umanità è il «Figlio dell'uomo», che gli autori neotestamentari non hanno esitato a identificare con il Signore Gesù. Il fine della storia è un ritorno alle sue origini e all'ideale bontà e bellezza del progetto del Creatore.
Racconti biblici e scienza: il senso ultimo della creazione
In un testo conciliare lungamente discusso, che segna il definitivo tramonto della concezione troppo angusta di «inerranza biblica», si afferma che «i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle Sacre Lettere» (Dei Verbum, 11). Interpretare è dunque scorgere quale «verità» voglia comunicare un testo biblico, che rimane pur sempre storicamente situato dalla finalità per cui è stato scritto e dal linguaggio utilizzato, perché non si dà parola di Dio se non attraverso una parola d'uomini. D'altro canto, l'ermeneutica contemporanea ci ha insegnato a più riprese che ciò che è detto è altrettanto importante di come viene detto, per cui la pretesa di verità di un testo traspare dal mezzo stesso di espressione utilizzato e dalla sua struttura intrinseca.
Questa consapevolezza ermeneutica pone fine all'annosa e tormentata discussione sui rapporti tra scienza e racconto biblico delle origini. Il lungo e comprensibile travaglio ebbe già un primo momento di incandescenza ai tempi del «caso Galileo», ma fu soprattutto il darwinismo a porre il problema nella sua radicalità. Visti i gravi problemi teologici implicati - la creazione del mondo e dell'uomo, la dimensione spirituale dell'uomo e la sua libertà, il peccato originale e la solidarietà del genere umano in Adamo - prima di poter approdare a una determinazione corretta e serena dei rapporti senza smarrire per strada nessun elemento, si è dovuta at-' tendere la maturazione dell'ermeneutica biblica e, da parte della scienza, la presa di coscienza dei propri limiti.
Un apporto decisivo venne dalla possibilità di leggere direttamente le letterature del Vicino Oriente antico: i grandi miti ed epopee dell'area sumero-accadica, i cicli mitici di Ugant, la vasta produzione letteraria egiziana hanno permesso di ricreare lo sfondo culturale sul quale si staglia in continuità e differenza il racconto biblico. Ricollocati nel loro habitat culturale, appare più evidente che i primi capitoli della Genesi non vogliono essere una preistoria scientifica del nostro mondo e dell'umanità e nemmeno un trattato di fisica o di cosmologia.
Il metodo scientifico si fonda su propri postulati. L'esattezza delle sue asserzioni sta nella validità verificabile e falsificabile dei suoi assunti e nella coerenza delle sue dimostrazioni. Le pagine bibliche sono invece ricerca del senso ultimo della creazione e di questa creazione, dell'uomo e di questo uomo, in rapporto alla «verità» di un Dio che si è manifestato nella storia d'Israele come Colui-che-è-presente, tessute con il linguaggio del mito e della poesia. Se il compito delle diverse discipline scientifiche interessate alla preistoria èdi ricostruire quanto è accaduto in quei lunghi millenni muti che precedono la comparsa dell'avventura umana, la finalità delle pagine bibliche è di rispondere alla domanda radicale e veritativamente ultima circa il senso di tutto questo. Se le diverse ipotesi fisiche devono tentare complicatissime equazioni per spiegare come l'universo si è formato, le pagine bibliche vogliono rivelare perché questo universo si è formato e verso quale fine è orientato.
Con un'adeguata interpretazione, i racconti delle origini cessano di essere per il lettore credente contemporaneo quella zavorra di cui si farebbe volentieri a meno o quel glorioso ritratto di antenato che si preferisce collocare nell'angolo meno in vista della casa. Essi riprendono il loro insostituibile ruolo di «far pensare» alle grandi domande antropologiche e teologiche, alla luce della rivelazione del Dio dell'esodo (e quindi del Dio di Gesù), mediante quell'insostituibile capacità del pensiero poetico di descrivere o narrare con simboli in azione quanto il pensiero filosofico tenta di concettualizzare dialetticamente.
Certo, anche il poeta non può fare a meno di infrastrutture filosofiche o scientifiche: ma ciò che egli vuole comunicare è al di là di esse. Così dobbiamo interpretare le più o meno implicite asserzioni scientifiche delle pagine bibliche, che rimangono «vere» anche se utilizzano una cosmologia precopernicana, una fisica rudimentale, un linguaggio ingenuamente (ma è proprio così?) antropomorfico o escludono l'analisi di tutte le causalità intermedie, «riassumendole» nella prima - e unica - causalità divina.
Da quanto detto, possiamo dedurre che ogni tentativo di concordismo tra i dati biblici e una qualsiasi ipotesi scientifica è dal punto di vista metodologico scorretto già in partenza, a prescindere dai possibili casuali agganci, perché la «verità» biblica ha un'unità di misura non omogenea all'esattezza scientifica. Con questo bisogna scartare anche ogni tentativo di concordismo «negativo», ovvero di fondamentalismo: equivarrebbe a sostenere che il testo biblico vuole comunicare nella sua «verità» una qualche ipotesi scientifica a sfavore di un'altra. Sta alla scienza esibire le ragioni delle sue ipotesi, in coerenza con la propria metodologia. La Bibbia su questo non vuole avere alcuna ragione.
Alla luce di questo principio generale vanno letti i problemi che riguardano l'evoluzionismo e il poligenismo. Sono due ipotesi scientifiche, e quindi andranno dimostrate, accolte o rifiutate con ragioni scientifiche. Non dobbiamo tuttavia stupirci se, nel 1909, la Pontificia Commissione Biblica rispondeva negativamente a chi voleva mettere in dubbio il senso letterale dei primi capitoli della Genesi per quanto riguarda quei fatti «che toccano i fondamenti della religione cristiana, tra cui: la creazione di tutte le cose fatta da Dio all'inizio del tempo, la speciale creazione dell'uomo, la formazione della prima donna dal primo uomo, la felicità originaria dei progenitori...». Come non dobbiamo stupirci se ancora nell'enciclica di Pio XII Humani generis (1950) viene ritenuta insostenibile per i cattolici l'ipotesi poligenista, in quanto non appare «in alcun modo come queste affermazioni si possano accordare con quanto le fonti della rivelazione e gli atti del magistero della Chiesa c'insegnano circa il peccato originale».
Questi pronunciamenti mettono in luce qual era il vero problema che restava da superare, una volta compreso che la «verità» biblica non voleva interferire con le ipotesi scientifiche, e quale fu la vera ragione di tutta la faticosa discussione. Si trattava di ripensare i dati della fede cristiana in una simbolica medita, nel quadro della nuova prospettiva scientifica. È appunto il compito ermeneutico e critico, specifico dei teologi: e così il dato di fede della creazione viene riletto in prospettiva evoluzionistica e la solidarietà del genere umano in prospettiva cristocentrica.
Un'impresa possibile e non priva di rischi, che ha visto tra i pionieri Teilhard de Chardin. Un dialogo fecondo e illuminante, nella serena consapevolezza che «la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede» (Gaudium et spes, n. 36). Perché questo sia possibile, anche lo scienziato deve rinunciare a una scienza «totalizzante», che voglia in qualche modo rispondere anche alla domanda sul senso delle cose: questa risposta non sarà mai disponibile come risultato «esatto» di una ricerca.
Vi è ancora spazio, nella mentalità scientifica contemporanea, per la meraviglia e lo stupore che diventano «lode al Creatore»? E ancora possibile pregare con l'estatico rapimento del salmo 8 o del salmo 104, parallelo sorprendente dell'inno al Sole composto sotto il faraone «eretico» Akhenaton (Amenhotep IV, 1352-1338 a.C.), e riconoscere nella natura le «grandi opere del Signore»? Certamente, e più ancora di un tempo. I credenti, e tra questi coloro che hanno incontrato Dio nel Figlio Gesù, «immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione» (Col 1,15), scorgono nell'universo un discorso ininterrotto del Creatore: «Mandi il tuo spirito ed essi sono creati, e rinnovi così la faccia della terra» (Sal 104,30). Qui sta tutto il mistero del Dio creatore. «Chi non è certo che egli è il Creatore, che rinnova oggi la terra nel ritmo di ogni vivente, non ha compreso nulla di lui» (C. Westermann).