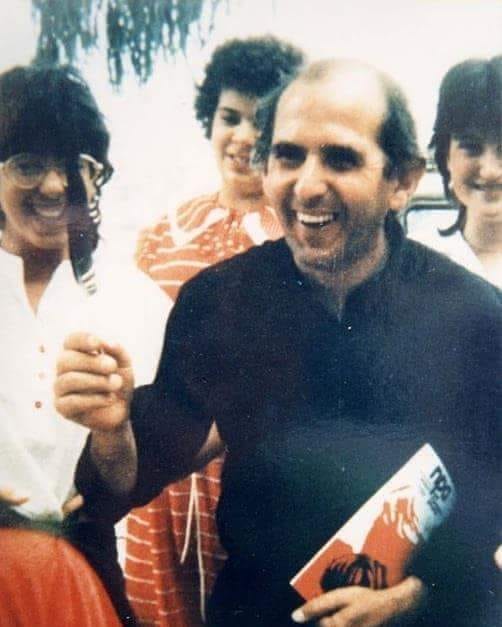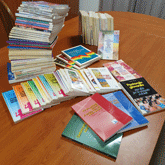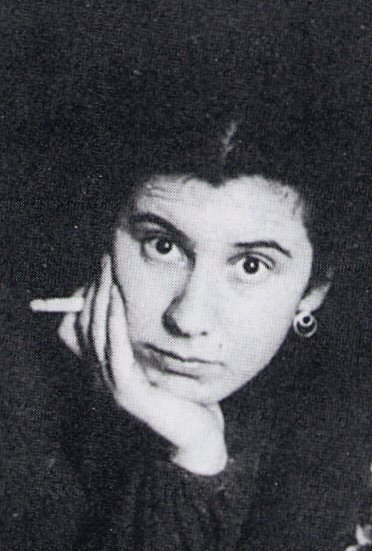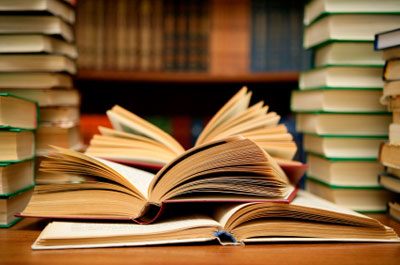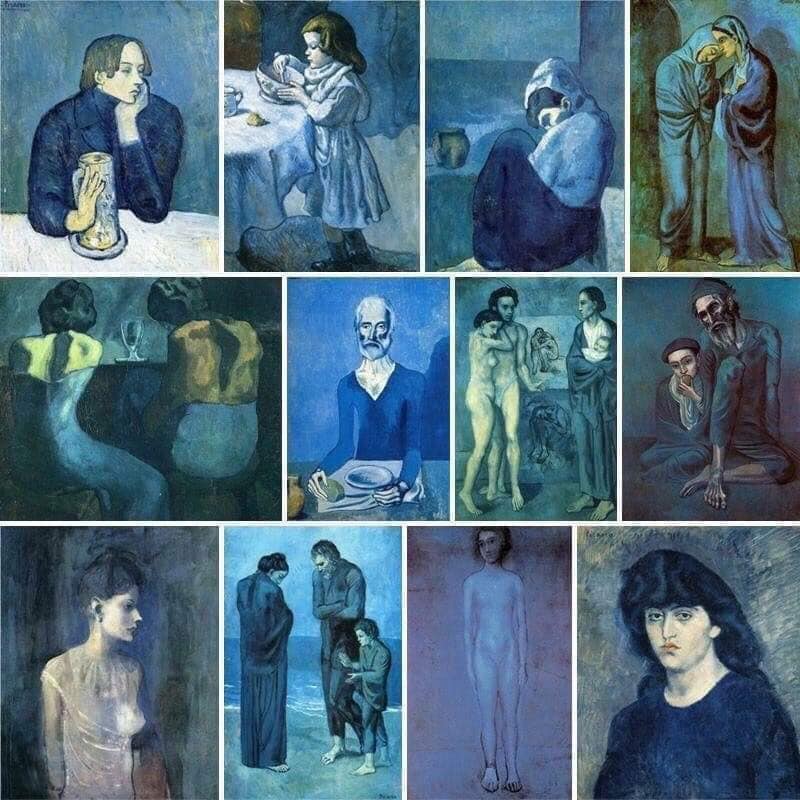Riconciliarsi
con la bellezza
José Tolentino Mendonça
«Cos'è che può restituire l'entusiasmo e la fiducia, cos'è che può incoraggiare l'animo umano a riscoprire la sua strada, a volgere lo sguardo oltre l'orizzonte immediato, a sognare una vita degna della sua vocazione, se non la bellezza?». Questa domanda così seria, così esistenzialmente decisiva, è stata posta da Benedetto XVI nella Cappella Sistina, nel novembre 2009, in uno storico incontro con gli artisti. Ovviamente, per sua natura, non è una questione che riguardi soltanto le persone legate alle arti: è una sfida lanciata a tutti. La questione della bellezza è, in effetti, assolutamente centrale nell'esperienza cristiana, nell'esperienza cristiana comune, ripeto, ed è urgente che sentiamo la necessità di riconciliarci con la bellezza.
Forse oggi ci meraviglia sapere che una delle discussioni intessute dai Padri della Chiesa era decidere se Cristo era o non era bello. Non si tratta di una questione minore o futile come, forse, possiamo credere a prima vista. In effetti, è la stessa liturgia che continua ad alimentare questo dibattito. Il Salmo 45, per esempio, l'applica a Gesù:
«Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
perciò Dio ti ha benedetto per sempre!».
Si tratta di un salmo nuziale, dove prima di tutto si descrive la bellezza del re, i suoi valorosi attributi e la sua nobile missione e, successivamente, si passa a esaltare la promessa sposa:
«Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio!».
La tradizione cristiana ha interpretato questo salmo come una prefigurazione della relazione sponsale di Cristo con la Chiesa. Commentava in un articolo su La bellezza e la verità di Cristo l'allora cardinale Joseph Ratzinger: «La Chiesa riconosce Cristo come il più bello fra gli uomini, e la grazia che si diffonde sulle sue labbra rimanda alla bellezza intrinseca delle sue parole, alla gloria della sua predicazione. Non è la mera bellezza esteriore dell'aspetto del Redentore che è glorificata; anzi, in lui traspare la stessa bellezza della Verità, la bellezza di Dio stesso, che a sé ci attrae e, al contempo, ci cattura attraverso la ferita dell'amore, la santa passione che ci permette di procedere assieme – con e nella Chiesa, la sua sposa – per incontrare l'Amore che ci chiama».
La bellezza, e la bellezza di Cristo in particolare, cattura il nostro cuore, ci ferisce intimamente, ci schiude la rivelazione, fa in modo che smettiamo di appartenere a noi stessi, ci obbliga a relativizzare ciò che eravamo, a dimenticare molte volte la nostra patria e la casa paterna, ci attrae a sé. È questo che la Chiesa prega nel Salmo 45.
Ma, mentre la liturgia utilizza ampiamente il salmo, considera allo stesso tempo indispensabile la luce che reca al mistero di Cristo il dramma del «servo sofferente», descritto in Isaia:
«Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato
il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo
alcuna stima.
Eppure egli si è caricato
delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato» (Is 53,1-4).
Come possiamo, dunque, coniugare spiritualmente i due testi? In uno Cristo è «il più bello fra i figli degli uomini», nell'altro, appare completamente sfigurato, privo di qualsiasi bellezza che attragga il nostro sguardo. Pilato, forse per attirare su di lui un resto di compassione, lo presenta semplicemente come «l'uomo»: «Ecco l'uomo!» (Gv 19,5). Commenta, ancora, il cardinale Ratzinger: «È qui implicita la questione più radicale: sapere se la bellezza è vera o se, al contrario, è la bruttezza che ci conduce alla verità più profonda della realtà. Chiunque creda in Dio, quel Dio che si è manifestato precisamente nell'apparenza sfigurata di Cristo crocifisso come amore fino alla fine (Gv 13,1), sa che bellezza è verità e verità è bellezza; ma, in Cristo sofferente, apprende anche che la bellezza della verità accoglie allo stesso tempo l'offesa, il dolore e persino l'oscuro mistero della morte, e che questa può essere assunta solo quando si accetta la sofferenza, non quando si cerca di ignorarla». In effetti, non esiste bellezza che non sia unita al mistero della croce, che non ci collochi come Maria e Giovanni sotto la croce.
Perché la riconciliazione con la bellezza di Cristo è così decisiva nella maturità di un percorso spirituale? Senza la bellezza, l'esperienza cristiana rimane incompleta. Conosciamo bene i rischi di un cristianesimo puramente sociologico, articolato semplicemente fra convinzioni e pratiche. Come nella storia di quei geologi che nelle loro ricerche scoprirono, sulla vetta di alcuni monti altissimi, un lago, dove riposavano pietre immerse chissà da quante centinaia di anni. Però, quando le spezzarono per studiarne le caratteristiche morfologiche, capirono, con meraviglia, che all'interno erano asciutte. Allo stesso modo, senza la bellezza attraente di Cristo, il cristianesimo rimane «asciutto», funzionale, burocratico, ritualista, un bagno esteriore di convenzioni rispetto al quale il nostro cuore si mantiene impermeabile.
Il nostro cuore, tuttavia, è chiamato a essere ferito dalla bellezza pasquale di Cristo e dall'amore infinito che egli rivela. La nostra vocazione è questa ferita d'amore, questo ampliarsi, questo inzupparsi fino alle ossa nell'amore di Dio, questo vivere un'appartenenza reale che accende nella vita intera il desiderio di Dio, questo sperimentare un sussulto di Dio che si prolunga negli anni: «Io dormivo, ma il mio cuore vegliava» (Ct 5,2), questa passione che non termina se non nell'assoluto di Dio e di Dio soltanto, questa epifania d'amore che quotidianamente ci compromette, trasfigura e trascende, questa inspiegabile luce di Dio che ci abbatte e solleva nel nostro cammino di Damasco.
Platone spiegava così l'impatto della bellezza in noi e la sua spiegazione ci è di grande aiuto, perché essere ferito dalla bellezza è, prima di tutto, un'esperienza antropologica: «Mentre si vede la bellezza, come in un tremore febbrile, si produce dentro di noi un'agitazione, un sudore, un calore insolito. Così è quando gli occhi ricevono il flusso della bellezza. Questo flusso scalda e irriga l'essenza...». Non è la stessa cosa che succede ai discepoli di Emmaus quando domandano: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24,32). Il cristiano si definisce come qualcuno che vive «ferito» dalla bellezza singolare di Gesù. E questa «ferita» genera in noi desiderio, volontà, attrazione, disponibilità per quanto può ancora avvenire.
La misteriosa lotta di Giacobbe con Dio (Gen 32,25-32) trascrive, paradigmaticamente, come l'irruzione del divino sia di una bellezza più forte che ci vince, bellezza irresistibile, che non smette mai di essere indicibile. «Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: "Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora". Giacobbe rispose: "Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!". Gli domandò: "Come ti chiami?". Rispose: "Giacobbe". Riprese: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!". Giacobbe allora gli chiese: "Svelami il tuo nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?". E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: "Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva". Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all'anca».
«Spuntava il sole». L'incontro con la bellezza è talmente decisivo che esistono un prima e un dopo, è una nuova stagione che comincia per la nostra vita. Ed è interessante il dettaglio di Giacobbe che se ne esce dalla lotta con l'angelo zoppicando. È ferito, perché il bello di Dio ferisce, non ha niente di superficiale. Il bello di Dio convoca l'uomo al suo destino finale, gli rivela la reale grandezza della verità. Il famoso teologo bizantino Nicola Cabasilas ha scritto nell'opera La vita in Cristo (XIV secolo): «È stato lo sposo che ci ha ferito con questa ansia. È stato lui che ha inviato un raggio della sua bellezza direttamente ai nostri occhi. Se l'estensione della ferita dimostra che la freccia ha raggiunto il suo bersaglio, l'ansia dimostra chi è stato a infliggere la ferita».
In effetti, gli altri due elementi trascendenti, «verità» e «bontà», non riescono ad attrarre l'uomo, se questi non si sente toccato da «qualcosa che affascina», come scriveva Plotino. E la bellezza che attrae, fa spostare il cuore, cattura e trasfigura. Dobbiamo, per questo, oltrepassare il silenzio a cui una certa stagione razionalista, persino all'interno della teologia e della spiritualità cristiana, la votava. Riconciliamoci con la bellezza, lasciamoci trasformare interiormente da questa. Dice ancora il cardinal Ratzinger: «Essere colpiti e dominati dalla bellezza di Cristo costituisce una conoscenza più reale, più profonda, che la mera deduzione razionale. È chiaro che non dobbiamo sottovalutare l'importanza della riflessione teologica, del pensiero teologico esatto e preciso; questo continua ed è assolutamente necessario. Ma da qui a disdegnare o rifiutare l'impatto che la risposta del cuore produce nell'incontro con la bellezza, considerata come un'autentica forma di conoscenza, significherebbe impoverirci, esaurire la nostra fede e la nostra teologia. Dobbiamo riscoprire questo modo di conoscere, e si tratta di una necessità urgente al giorno d'oggi».
Nel suo sviluppo storico, l'esperienza cristiana è diventata humus di alcune sorprendenti espressioni della bellezza: l'architettura religiosa, da Michelangelo a Gaudí; le impressioni incandescenti trascritte dai mistici (pensiamo a Ildegarda di Bingen o a san Giovanni della Croce); i registri iconografici che riproducono l'incommensurabile (le moltitudini giornaliere sono la prova che la Cappella Sistina dà i brividi a qualsiasi mortale); le opere musicali che risuonano come inventari dell'anima o come il suo genio; gli immensi dizionari del naturale e del soprannaturale; i simboli, il laboratorio di linguaggi che si sviluppano infinitamente. Ma tutte queste espressioni possono diventare semplicemente equivoche, perché la bellezza non è un patrimonio che la Chiesa ha posseduto, possiede o amministra. La bellezza si lega alla rivelazione della stessa Chiesa, alla sua identità soprannaturale. È questo il «grande mistero» a cui si riferisce la Lettera agli Efesini: «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei... per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga» (5,25-26). La Chiesa in Cristo, nel mistero della sua natura e della sua missione, è l'aurora della visione, è questo impeto, storico e infinito, verso il punto di vista di Dio. In modo velato, ma tremendamente efficace, costituisce espressione e dramma della sapienza divina.
Così scrive Dionigi Aeropagita, offrendo l'esempio di san Paolo: «Sublime Paolo caduto sotto il pungolo dell'eros divino e reso partecipe del suo potere estatico, grida con voce ispirata: "Vivo, ma non sono io ormai che vivo. È Cristo che vive in me". Egli parla, dunque, come un vero amante, come qualcuno che, come lui stesso dice, è fuori di sé e vive estaticamente in Dio (2Cor 5,15), in tal modo che non vive ormai la sua vita, ma quella dell'amato, come qualcuno ricolmo d'amore appassionato».
L'affermazione centrale, e tanto citata, di Gesù nel Vangelo di Giovanni (10,11), che ci siamo abituati a vedere, in ogni luogo, tradotta come «io sono il buon pastore», possiede in effetti un'altra possibilità di significato. Si può tradurre con: «Io sono il bel pastore». Nella visita apostolica in Portogallo, durante il discorso al Centro Culturale di Belém, Benedetto XVI ci ha lanciato la sfida: «Fate cose belle, ma soprattutto fate delle vostre vite luoghi di bellezza». Lasciamoci toccare, incantare, innamorare, ferire dalla bellezza che Dio rivela in Gesù.
(Il tesoro nascosto. Per un'arte della ricerca interiore, Paoline 2011, pp.71-80)