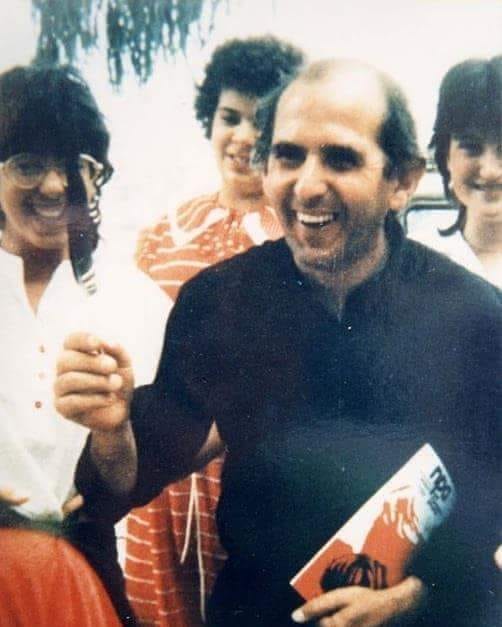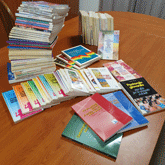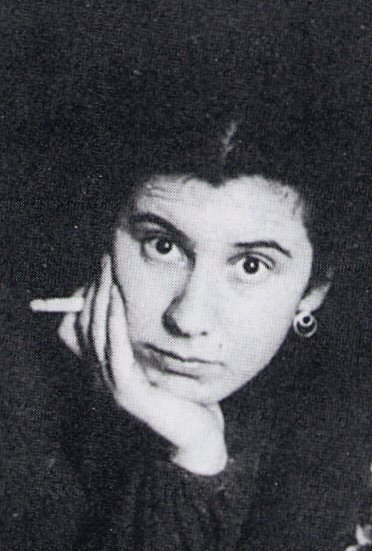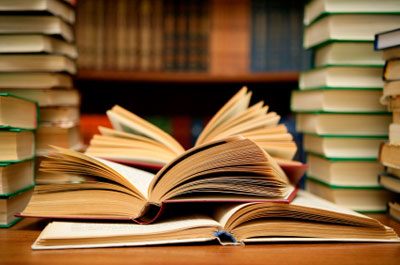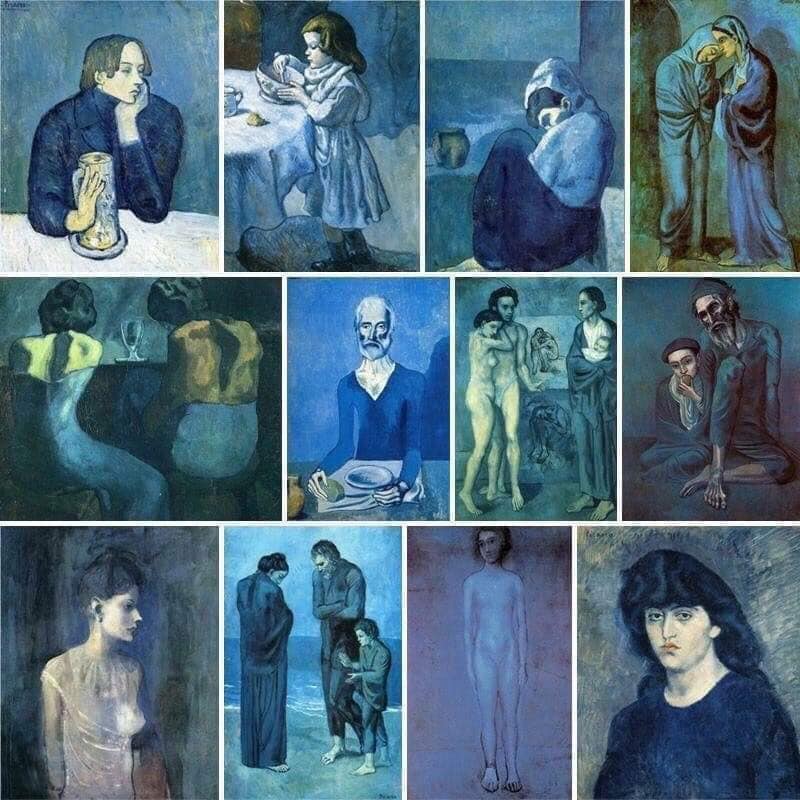Quando un film è
l'incontro che non ti aspetti
Nadia Ciambrignoni *

Certe volte nella vita, i percorsi più stimolanti e generatori di novità nascono da un incontro: con una persona, con un’esperienza, una poesia, un film, una serata a teatro… E se l’incontro attiva una nuova riflessione, salvandosi dall’assalto della frenesia di ogni giorno, diventa crescita personale.
A noi è successo con un film visto quest’anno, di quelli che in genere i più non vanno a cercare, perché siamo tutti abbastanza confinati nella corsia (non così larga) del main-stream, del prodotto preconfezionato, che spesso ci racconta ciò che ci piace sentirci dire e ci illude di farci pensare, ma in realtà ripropone quello che già pensiamo.
Ha innescato qualcosa di diverso il film malese COME FRATELLI - ABANG E ADIK, opera prima del regista e sceneggiatore Jin Ong, che racconta la storia di due giovani orfani nei bassifondi di Kuala Lumpur, quelli del quartiere di Pudu Pasar. È stato lanciato al Far East Film Festival di Udine nell’edizione 2023 e lì scoperto dalla delegazione di giovani C.G.S.; uscito nelle sale italiane a primavera 2024.
I due protagonisti sono nati in Malaysia ma, privi di documenti, devono nascondersi alle autorità e sbarcare il lunario. Abang (Kang Ren Wu) è un ragazzo sordo-muto che cerca di ritrovare un’identità lavorando duramente per guadagnare soldi in modo pulito. Adik (Jack Tan), vive di estremi: si caccia nei giri più loschi vendendo documenti falsi, prostituendosi e incappando in risse con i gangster locali, per poi farsi sempre salvare dal “fratello maggiore”. Il titolo in malese significa infatti “fratelli”: Abang significa “fratello maggiore” e Adik “fratello minore”.
Un tragico avvenimento sconvolge la vita già precaria dei due, che si ritroveranno ad essere fuggitivi, precipitando fino ad un punto di non ritorno, dal quale emergeranno le tematiche spiazzanti della Colpa, del Sacrificio e dell’Espiazione.
Il disvelamento dei personaggi avviene gradualmente, così come quello del corollario umano che li circonda, con un “sottinteso” di sofferenze e umiliazioni che tutti gli abitanti del popoloso e labirintico caseggiato attraversano quotidianamente. Scopriremo un po’ alla volta che il legame di fratellanza tra i due protagonisti è scritto solo nella loro differente orfanezza (una scelta per Adik, che non accetta l’abbandono del padre) e nella conseguente necessità di prendersi cura l’uno dell’altro, in un significativo rovesciamento di ruolo che conferma Abang, sordomuto e completamente solo, come tutore paterno di Adik, apparentemente più scafato e sicuro di sé.
Spesso lo spettatore si accorge che la prospettiva del racconto è proprio quella del ragazzo sordomuto, grazie all’espediente dell’ottundimento dei rumori o all’assenza totale di essi, specialmente nei momenti più carichi emotivamente. Il commento musicale, quando è presente, sovrappone con insistenza piste diegetiche con piste extra-diegetiche in contrasto tra loro, creando un senso di turbamento che lascia ulteriori “indizi” di riflessione per la lettura di ciò che si sta osservando. Anche la costruzione iconica è molto accurata: Abang e Adik sin dall’inizio appaiono incastrati tra sbarre e ringhiere, a volte insieme, altre volte separati da esse; sono paragonati visivamente ad animali da macello, come polli, e schiacciati da altissimi palazzi diroccati, oppressi e senza vie di fuga. Non a caso lo spazio in cui si muovono i due ragazzi, fotografato con colori nel contempo caldi e acidi, è costituito da quelli che il cinema chiama “non luoghi”, spazi di transito.
Le parole della lingua dei segni, scandite con veemenza da Abang nei momenti più tragici, sono un ponte di comprensione universale in una realtà dove vengono parlate contemporaneamente quattro diverse lingue (mandarino, cantonese, malese e inglese). È il muto linguaggio che esprime frustrazione per una vita ingiusta, subita da chi è costretto ai margini, vittima di un riscatto negato.
Nella parte ricca della megalopoli, invece, chi nasce agiato è libero di potersi scegliere il proprio futuro. Questo divario è rappresentato dalla contrapposizione tra i personaggi femminili di Jia En (Serene Lim), ragazza di classe agiata che lavora per una ONG, ma che è destinata ad una inaspettata tragica fine, e di Xiao-su (April Chan), cui Abang dona una sciarpa (segno di un legame nascente), che non ha alcun controllo sulla sua situazione di vita o sulle sue decisioni sentimentali, diventando una vittima di circostanze al di fuori della sua influenza.
Ne esce un quadro di solitudini che si accompagnano, ma soprattutto di assenze sociali: la vera sordità è quella delle istituzioni, che sembrano totalmente inermi davanti ad una endemica burocrazia corrotta, che non vuole riconoscere l’identità dei protagonisti. Ed è proprio dell’identità che il testo parla: Abang e Adik la celebrano, quasi ritualmente, nel gesto di rompersi vicendevolmente sulla fronte il guscio dell’uovo sodo, il loro pasto comune più frequente. Un’immagine fortemente significativa, fermata anche nel frame del manifesto del film. Il cammino istituzionale verso il sospirato documento di identità, invece, si completerà solo parzialmente e a costo di un estremo sacrificio. Emblematica anche la scelta di rappresentare l'unico personaggio adulto di influenza positiva e su cui i giovani possono contare con una donna transgender, Miss Money (Tan Kim-wang), anche lei emarginata, che li prende sotto la sua ala protettrice.
Le piste di riflessione e lavoro da proporre attraverso questo film partono dalla scelta di occuparsi delle fasce di giovani, “specialmente i più poveri”. E di povertà qui si ha uno spaccato, apparentemente “lontano”, ma il quartiere Pudu Pasar di Kuala Lumpur è specchio di una globale progressiva deriva dei diritti sociali e civili: riconoscere cittadinanze, e quindi “voci”; assicurare tutele abbattendo orfanezze e abbandoni; accompagnare nella Legalità la riconquista di un “posto” dignitoso, togliendo spazi alla criminalità e allo sfruttamento dei più giovani… Di questo racconta Abang e Adik e ci sembra l’opera giusta (specialmente in molte delle nostre realtà divenute multiculturali) per avviare laboratori che partendo dalla lettura attenta di simboli, figure filmiche, scelte visive e sonore di regia, facciano immergere gli spettatori in un prodotto asiatico, aiutandoli a verificare che la “lontananza” rispetto ai linguaggi e alle tematiche cui siamo abituati è solo apparente. E la distanza comunicativa si accorcerà, specie quando sono in gioco tematiche urgentemente globali.
* Docente, formatore e dirigente CGS Dorico di Ancona; co-direttore dell’Ufficio diocesano per la cultura della Arcidiocesi di Ancona–Osimo.
Pronta a portare le Giurie C.G.S. Percorsi Creativi al Giffoni Film Festival, che quest’anno ha come tema “L’illusione della distanza”.