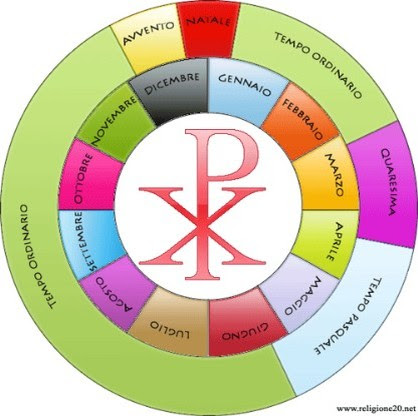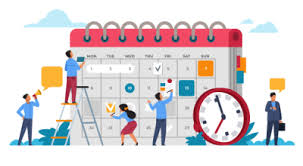Luis A. Gallo, LA CHIESA DI GESÙ. Uomini e donne per la vita del mondo, Elledici 1995
Dopo aver preso in considerazione quella grande parte dei membri della Chiesa che sono i cristiani e le cristiane laici, affrontiamo ora un altro gruppo, quello dei cristiani-pastori.
1. UN SERVIZIO INDISPENSABILE NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE
1.1. Nelle prime comunità
Gli scritti neotestamentari, pur così sensibili all’uguaglianza fraterna che dietro gli orientamenti di Gesù vivevano le comunità dei suoi discepoli, non tralasciano di rilevare quest’altro dato: alcuni fratelli svolgono in mezzo ad esse dei servizi speciali che li mettono a capo delle medesime. Sono servizi che contribuiscono a tenere vivi nella comunità tanto l’ardore per la missione di salvezza affidatale da Gesù quanto la comunione fraterna della comunità stessa.
Tra questi fratelli occupano un posto di singolare rilievo “gli Apostoli”. I testi ricordano una serie di funzioni che essi esercitano in favore delle comunità.
Il libro degli Atti, in particolare, riferisce che essi annunciano la Parola di Dio tanto ai membri della comunità quanto a quelli che non appartengono ad essa (At 2,14-36; 3,12-26, ecc.), che battezzano i convertiti alla fede in Gesù risorto (At 2,37-41; 10,44-48), che presiedono e organizzano la comunione fraterna (At 2,42; 6,1-6, ecc.) e, come è logico supporre anche se non è detto esplicitamente, che presiedono alla frazione del pane e alle preghiere (At 2,41-42).
I Vangeli, da parte loro, lasciano intravedere la coscienza che questi Apostoli possedevano di aver ricevuto tali compiti dallo stesso Signore Gesù. Esprime bene questa coscienza il testo finale del Vangelo di Matteo nel riferire queste parole a lui attribuite:
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato” (Mt 28,19-20).
Anche Paolo nelle sue lettere si presenta più di una volta come “apostolo” (Rm 1,1; 2 Cor 12,2, ecc.). Un apostolo che esercita la stessa serie di servizi degli altri verso le comunità da lui fondate tra i pagani.
Ma non sono solo gli Apostoli a esercitare simili servizi. Diversi testi neotestamentari fanno capire chiaramente che ci sono anche altri uomini e donne, chiamati da essi, che collaborano in questo compito. Tale collaborazione implica diversi impegni che si possono catalogare in tre gruppi.
Anzitutto, i servizi della Parola, a cui viene attribuita molta importanza e che vengono esercitati innanzitutto dai profeti (1 Cor 12,28; Rm 12,6) e profetesse (At 21,9; 1 Cor 11,5), ma poi anche dagli insegnanti (1 Cor 12,28; Rm 12,7), dagli anziani e dai vescovi (1 Tm 5,17; Tt 1,9), e infine da quelli che praticano l’esortazione o paraclesi (2 Ts 2,3; 1 Tm 4,13); poi, i servizi di assistenza o aiuto fraterno, che sono esercitati soprattutto dai diaconi (Pii 1,1; 1 Tm 3,8-11); infine, i servizi di governo o autorità, che vengono svolti soprattutto da presbiteri e vescovi (At 11,30; 14,23, ecc.).
Esistono inoltre alcuni inviati personali degli Apostoli, per mezzo dei quali questi esercitano la loro supervisione sulla vita e funzionamento delle comunità nella loro assenza. Fra essi Tito e Timoteo e, ancora prima di loro, Barnaba (At 11,22 e Lettere a Tt e Tm).
È da rilevare che nei testi nessuno di questi membri della comunità viene chiamato “sacerdote”. La ragione di ciò si deve riporre, secondo gli studiosi, nella preoccupazione di stabilire una netta distinzione tra il sacerdozio pagano e veterotestamentario, e il ministero del Nuovo Testamento. Coloro che sono a capo delle comunità non sono in realtà dei mediatori, poiché l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù Cristo (1 Tm 2,5); essi sono soltanto dei ministri o servi della comunità. I termini utilizzati per designarli (“pastori”, “servitori”, “sorveglianti”, ecc.) testimoniano in quale misura i primi discepoli avevano assimilato l’insegnamento di Gesù su ciò che significa essere “più grande” nella sua comunità, secondo quel detto: “I re delle nazioni dominano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come chi serve” (Lc 22,25-26).
1.2. Il Vaticano II
La costituzione Lumen Gentium, dopo aver saldamente confermata l’uguaglianza fraterna di tutti i membri della Chiesa nel suo capitolo II, dedica esplicitamente il suo capitolo III al tema che stiamo affrontando (nn. 18-29). In realtà, già prima aveva accennato di passaggio ad esso in diversi punti (nn. 11.12.13), ma in detto capitolo ha voluto affrontarlo espressamente alla luce della nuova impostazione generale assunta. Purtroppo il titolo del capitolo (Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'episcopato) può fuorviarne la comprensione riportando a una concezione piramidale della Chiesa, ma al di là dei termini c’è una sostanza, ed è quella che ci interessa.
Tale sostanza si trova soprattutto in due testi-chiave.
Il primo asserisce: “Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il Corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità umana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza” (LG 18a).
E nell’altro si dice: “I vescovi [...] assunsero il servizio della comunità con i loro collaboratori, presbiteri e diaconi, presiedendo in luogo di Dio al gregge, di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa” (LG 20c).
Da questi e altri numerosi testi conciliari possiamo raccogliere sinteticamente quanto segue: esiste nella comunità ecclesiale un servizio particolare, chiamato anche “ministero della comunità” o, con parole un po’ tradizionali, “sacra potestà”; esso consiste nel governare la comunità, nel pascerla, nel presiederla in nome di Dio; tale servizio si esercita nella triplice linea della proclamazione della Parola, dell’attività cultuale e dell’organizzazione della comunità stessa; va svolto appunto in chiave di servizio, cioè come una collaborazione affinché la comunità viva e cresca tendendo sempre verso il proprio fine.
1.3. Il servizio “della responsabilità ultima”
Quindi, tanto il Nuovo Testamento quanto il Vaticano II, che a sua volta riecheggia una storia di secoli, fanno riferimento all’esistenza nella comunità cristiana di un gruppo dei suoi membri che esercitano ciò che possiamo chiamare il servizio della responsabilità ultima, e che ne costituiscono, in diversa misura, come il centro di vita e di comunione. In forza di questa responsabilità, essi dispiegano un ampio servizio tanto verso i membri della comunità ecclesiale quanto verso gli altri che non ne fanno parte.
Anzitutto servono i loro fratelli di fede aiutandoli a vivere autenticamente ciò che essi sono in quanto membri della Chiesa, e a realizzare la missione nella quale sono impegnati. Il loro servizio specifico consiste nel presiedere alla comunità loro affidata, e alla quale appartengono, in modo tale che essa possa realizzare la sua vocazione di serva della Vita fra gli uomini. Tale servizio si svolge nelle tre dimensioni proprie della comunità ecclesiale: Parola (fede, profezia), sacerdozio (liturgia, sacramenti), organizzazione e funzionamento.
In primo luogo, essi hanno la responsabilità ultima dell’annuncio della Parola evangelica. Presiedono, cioè, alla comunità nella sua linea profetica. Questa presidenza comporta la funzione del cosiddetto “magistero”, esercitata soprattutto dai vescovi, che consiste non tanto nell’insegnare le verità dottrinali agli altri (cosa talvolta necessaria), quanto nello stimolare, sollecitare e orientare l’intera comunità nella comprensione vitale e nella proclamazione della proposta di Gesù.
Sono pure i responsabili ultimi della vita cultuale della comunità. Presiedono cioè alla sua linea liturgica o sacerdotale. Ciò comporta, secondo la prassi che si è andata sviluppando e anche evoluzionando lungo i secoli, certe funzioni proprie: quella di consacrare il pane e il vino nell’Eucaristia, di assolvere i peccati in nome di Dio e della Chiesa, ecc.
Su di essi riposa, infine, la responsabilità ultima dell’organizzazione, coordinamento e funzionamento della comunità. Presiedono cioè nella linea regale o pastorale. Ciò comporta il governo e l’esercizio dell’autorità in mezzo ai fratelli, con la facoltà di dire l’ultima parola decisiva, quando ciò sia necessario.
Ma la responsabilità dei cristiani-pastori non si esaurisce nel servizio che prestano ai membri della comunità ecclesiale; essa si estende, nella misura del possibile, a tutti gli altri uomini. Tale servizio viene da loro esercitato anzitutto in maniera indiretta, sollecitando l’intera comunità a centrare i suoi sforzi su ciò che è veramente essenziale, cioè nel suo contributo alla salvezza dell’umanità. Se dimenticassero di farlo o lo trascurassero, contribuirebbero a convertire la comunità in un ghetto chiuso in se stesso, forse in ricerca del suo proprio bene, ma tradendo la sua fondamentale ragione di essere.
Ma inoltre e soprattutto s’impegnano per primi nell’annuncio del Vangelo a coloro che ancora non l’hanno accolto, in modo tale che questi possano prendere contatto con il progetto di salvezza proposto da Gesù Cristo, possano ricevere la luce per la propria azione e, se lo desiderano, anche s’incorporino alla comunità ecclesiale per seguire apertamente Cristo.
2. PASTORI IN UNA CHIESA LOCALE
Quanto abbiamo finora esposto è ancora generico; occorre specificarlo. Perché, in concreto, questo servizio pastorale viene esercitato sia a livello di Chiesa universale sia a un livello più ristretto. Prenderemo in considerazione successivamente i due livelli, invertendo tuttavia l’ordine per i motivi che appariranno nell’esposizione stessa.
2.1. Il ritorno della Chiesa locale
Durante il Vaticano II cominciò a modificarsi una mentalità radicata da molti secoli in Occidente. Essa vedeva la diocesi come una semplice suddivisione amministrativa della Chiesa universale assegnata a un vescovo perché la governasse. Il Concilio aprì la strada a un’altra visione delle cose in questo tema, una visione in realtà più originaria e che rimase in vigore attraverso i secoli presso i cristiani orientali. Essa riconosce la consistenza ecclesiale di ognuna delle Chiese radunate intorno a un vescovo.
Ecco come si esprime al riguardo in uno dei suoi testi: “Questa Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime comunità locali di fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro Pastori, sono anche chiamate Chiese nel Nuovo Testamento” (LG 26a). Come si vede, non si fa che riprendere ciò che è la più genuina tradizione iniziale. La Chiesa è nata in realtà così: con il moltiplicarsi di piccole comunità credenti in Gesù, fortemente impegnate nel portare avanti la sua proposta e strettamente collegate con le altre comunità già esistenti o appena nascenti. Lo si vede soprattutto nelle lettere di Paolo, indirizzate alle varie “Chiese” che lui stesso andava fondando. Un dato lo conferma tassativamente: la prima volta in assoluto che il termine “Chiesa” viene utilizzato in uno scritto neotestamentario (la prima lettera ai Tessalonicesi) lo è precisamente in questo significato di Chiesa locale (1 Ts 1,1).
Il Vaticano II afferma ancora che “in ogni comunità che partecipa all’altare, sotto la presidenza del vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del Corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza”. In queste comunità, sebbene spesso piccole e disperse e povere, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica” (LG 26a).
Difficilmente si poteva esprimere in modo più netto la valenza ecclesiale di ogni singola comunità credente, per piccola e povera che sia. Essa rende presente “la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica”.
Ciò vale, naturalmente e anzitutto, della Chiesa diocesana. Volendo dare una specie di definizione della medesima, il Concilio dice: “La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui per mezzo del Vangelo e della SS. Eucaristia unita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente ed agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica” (CD 11a).
La Chiesa diocesana (viene anche chiamata “Chiesa particolare”) è, quindi, l’ambito umano dove il cristiano può fare l’esperienza di ciò che è una comunità cristiana organica di una certa ampiezza che oltrepassa i limiti della comunità parrocchiale o di altre comunità ancora più piccole, e allo stesso tempo non ha una portata universale.
Ciò però non significa che queste altre comunità più piccole non siano anche da considerare “Chiese”. Lo sono anch’esse, a loro modo, dal momento che anche in esse si vive la comunione nel progetto di Gesù e nel tentativo della sua realizzazione.
2.2. I servizi pastorali in una Chiesa locale
Tanto nella Chiesa diocesana quanto nelle altre comunità minori vengono esercitati diversi servizi pastorali, circa i quali, appoggiandosi ai dati del Nuovo Testamento, ha parlato in modo rinnovato il Vaticano II. Risulta impossibile esporre qui, data la sua ampiezza, tutto ciò che questo Concilio ha apportato su ognuno ditali servizi pastorali. Ci limiteremo quindi ad accennare ad alcuni degli aspetti più importanti.
Il servizio del vescovo
Il Concilio gli ha dedicato i nn. 24-27 della costituzione Lumen Gentium e, inoltre, un intero documento dal titolo Christus Dominus.
In quest’ultimo troviamo il seguente enunciato globale, nel quale si delinea l’identità del vescovo intrecciando espressioni tipicamente evangeliche con altre di sapore alquanto giuridico: 1 singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l’autorità del Sommo Pontefice, come pastori propri, ordinari e immediati, pascono nel nome del Signore le loro pecorelle, ed esercitano a loro vantaggio l’ufficio di insegnare, di santificare, di reggere” (CD 11b).
Tutti e due i citati documenti hanno esplicitato le dimensioni nelle quali il vescovo esercita il servizio verso la Chiesa che presiede: sottolineano, in primo luogo, l’importanza del servizio della Parola (LG 26; CD 12), al quale, si dice, deve corrispondere negli altri membri della comunità un atteggiamento di aperta e fiduciosa accoglienza (LG 25a); affermano, inoltre, che il vescovo ha la grazia del supremo sacerdozio, grazia che esercita soprattutto nella presidenza (personale o mediante i presbiteri) di ogni celebrazione eucaristica, e nella regolazione degli altri sacramenti nella sua Chiesa (LG 26a; CD 15); dicono, infine, che il vescovo esercita il governo della Chiesa a lui affidata in diversi modi, anche esercitando l’autorità e la potestà sacra in nome proprio, e cioè non come semplice vicario del papa, ma sempre in atteggiamento di servizio e non di dominio (LG 27; CD 16).
Al di là delle espressioni adoperate, che in certi momenti denotano un’impostazione ancora prevalentemente giuridica, questi testi vogliono dire che in ogni Chiesa locale o particolare il vescovo svolge il ruolo di centro di comunione. Tutta la vita di fede e tutta l’azione ecclesiale fa capo a lui, che la presiede con la collaborazione dei presbiteri e dei diaconi, i suoi diretti aiutanti.
Naturalmente, essere centro non significa monopolizzare tutto. Se il ruolo episcopale viene vissuto veramente all’insegna del Vangelo, con atteggiamento realmente pastorale, questo rischio resta facilmente superato.
Il servizio dei presbiteri
Anche al servizio presbiterale, quello esercitato da coloro che comunemente vengono chiamati “preti”, il Concilio ha dedicato un’attenzione speciale nella costituzione Lumen Gentium (n. 28) e, dopo, un intero documento che porta come titolo Presbyterorum Ordinis.
La prima cosa che fece il Concilio, dopo aver chiarito il rapporto di questi presbiteri con Cristo in quanto partecipanti a titolo speciale del suo sacerdozio, fu quella di mettere decisamente questo servizio in rapporto con quello dei vescovi, precisando che va esercitato in stretto collegamento con esso e sotto la sua direzione. In questo modo ha capovolto una certa immagine creatasi alcuni secoli fa, secondo la quale il vescovo era semplicemente un presbitero a cui “inoltre” veniva affidato il governo di una parte della Chiesa, chiamata diocesi. L’episcopato era così considerato come una specie di aggiunta accidentale nella linea del “potere”, e non come la forma più piena del ministero pastorale.
La costituzione Lumen Gentium è chiara al riguardo (n. 28a), e il decreto Presbyterorum Ordinis a sua volta afferma: “Cristo, per mezzo degli Apostoli, rese partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi, la cui funzione ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri, affinché questi, costituiti nell’Ordine del presbiterato, fossero cooperatori dell’Ordine episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo” (n. 2b).
I presbiteri svolgono il loro servizio nella triplice linea nella quale si esercita quello dei vescovi, ma sempre in dipendenza da questi (LG 28; PO 46). Tra essi, tuttavia, c’è una grande varietà di situazioni: alcuni - i parroci - esercitano la presidenza di comunità minori all’interno della Chiesa diocesana, e svolgono verso di essi tutti i servizi a cui li capacita la loro condizione; altri invece collaborano o direttamente con il vescovo, o con i parroci o in altri modi ancora alla vita e alla missione della comunità diocesana. Quelli poi che appartengono a qualche famiglia religiosa, lo fanno a partire dalle accentuazioni che questo fatto crea nel loro servizio.
Un altro apporto importante del Concilio, non soltanto teorico ma anche e soprattutto pratico, fu quello di ripristinare l’antica istituzione ecclesiale del “presbiterio”: i presbiteri costituiscono nella Chiesa particolare un corpo collegiale, nel quale essi sono uniti tra di loro e con il vescovo, capo della comunità, in intima fraternità (LG 28c,d; PO 8a). Ciò li aiuta a condividere con gli altri le proprie responsabilità, e dà loro energia e luce per compiere la propria missione.
Il servizio dei diaconi
Questo tema venne affrontato dal Concilio soltanto nel n. 29 della Lumen Gentium. Tuttavia, con quelle poche righe ivi esposte contribuì in larga misura alla rinascita di questo servizio ecclesiale. Afferma stringatamente in esse che il ministero dei diaconi, svolto in comunione con il vescovo e con il presbiterio, si esercita nella liturgia, nell’annuncio della Parola e specialmente nella carità.
Una decisione conciliare, che si sta dimostrando molto feconda in diverse Chiese locali del postconcilio, fu quella di ristabilire il diaconato come servizio proprio e permanente tra i ministeri pastorali, e di ammettere allo stesso tempo ad esso uomini maturi e anche sposati. Era atteso questo contributo, perché il ministero diaconale, molto importante nei primi secoli del cristianesimo, era quasi scomparso da secoli nella Chiesa di Occidente, per il fatto di essere stato ridotto a un semplice gradino di passaggio al presbiterato.
Concludendo questa stringata esposizione sui ministeri pastorali nella Chiesa locale, vogliamo fare ancora due osservazioni.
2.3. Due rilievi finali
La prima riguarda l’uso della terminologia biblica (“pastori”, “pascolare”, “gregge”, “pecorelle”...) utilizzata in questo contesto. Essa offre indubbiamente da una parte il vantaggio di superare l’impostazione prevalentemente giuridica di questi ministeri, che predominò nella Chiesa per secoli. Tale impostazione portava a rafforzare la separazione tra vescovi e presbiteri da un lato, e “semplici fedeli” dall’altro, creando quell’asimmetria tipica che contraddice il pensiero di Gesù. Il vescovo, soprattutto, finiva spesso per venir considerato come un “signore”, al quale dovevano sottomissione e ubbidienza tutti gli altri, specialmente i laici.
Se invece tanto il vescovo quanto gli altri ministri vivono il loro servizio da pastori, alla stregua del primo Buon Pastore (Gv 10,10), le cose cambiano profondamente.
D’altra parte, tuttavia, la terminologia “pastorale” comporta il rischio di considerare i cristiani-laici come “pecorelle” nel senso deteriore della parola: persone gregarie, incapaci di pensare con la propria testa e di stare sui propri piedi, bisognose di essere costantemente condotti da altri, i pastori precisamente. Questo rischio va attentamente vigilato perché non è meno antievangelico del precedente.
La seconda osservazione riguarda la necessità di tenere vivo lo scopo ultimo dei ministeri pastorali. Essi esistono nella Chiesa per aiutare la comunità a raggiungere il fine per il quale è stata convocata da Gesù stesso: la Vita in pienezza degli uomini, e soprattutto dei più “moribondi”. Un ministero episcopale, presbiterale o diaconale che lo dimenticasse, tradirebbe la sua ragion d’essere. L’ispirazione costante del loro servizio non è altra che quella del Buon Pastore: “Io sono venuto perché abbiano la Vita, e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
3. PASTORI NELLA CHIESA UNIVERSALE
Considerati i servizi pastorali nella Chiesa locale., restano da vedere i servizi a livello universale, poiché la Chiesa non si esaurisce né nelle piccole comunità, né nella parrocchia, e neppure nella comunità diocesana, ma è diffusa su tutta la terra, e anche a questo livello richiede una strutturazione per poter vivere e funzionare.
Il ministero o servizio della Chiesa universale in quanto tale viene esercitato, di fatto, in forme diverse ma complementari, dal collegio episcopale e dal papa di Roma.
3.1. La corresponsabilità comune dei vescovi
Nel primo capitolo abbiamo raccolto un dato decisivo dal punto di vista ecclesiale: i Vangeli ci fanno sapere che Gesù convocò numerosi discepoli. Essi raccontano anche, e con una certa solennità, l’elezione di “dodici” tra di essi. Un’elezione preceduta da una notte di preghiera da parte sua, segno dell’importanza che le attribuiva (Lc 6,12).
Ci sono ancora altri dati nei Vangeli vincolati con questo tema: ciò che Gesù fece con questi dodici e ciò che la prima comunità pensava di loro.
Sul primo punto, ci dicono che essi costituivano un cerchio più ristretto accanto a Gesù, al quale egli rivelò “il mistero del regno” (Mc 3,34) e che andò plasmando a poco a poco affinché vivessero secondo le esigenze del suo grande progetto. Sul secondo, lasciano intravedere che le prime comunità avevano una visione molto alta di essi: si aspettavano che fossero i giudici della fine dei tempi (Mt 28; Lc 22,30) e li consideravano come i patriarchi del nuovo popolo di Dio (Mt 19,28; At 26,7).
In questo contesto acquista tutta la sua importanza il numero “dodici”, che costituiva come il titolo o nome del gruppo (Mc 3,14-16; 1 Cor 15,5), e che essi si preoccuparono di conservare anche dopo la morte di Giuda Iscariota, il discepolo che consegnò Gesù ai suoi avversari (At 1,15-22).
Tutto ciò fa vedere che, secondo i Vangeli, ma anche secondo altri scritti neotestamentari che non stiamo a riportare, questo gruppo costituiva un’unità fortemente vincolata con la persona di Gesù e dotata anche di una forte coesione tra i suoi membri. Secondo Mt 28,16-20, Gesù risorto affidò ad esso la triplice missione di fare suoi discepoli gli uomini, di battezzarli e di insegnare loro a realizzare tutto ciò che egli aveva loro proposto. È quello che li vediamo fare, come gruppo compatto, nella Chiesa nascente di Gerusalemme, secondo i dati già ricordati del libro degli Atti. Appare evidente che in essa “i dodici”, con a capo Pietro, sono quelli che presiedono e guidano la comunità. Dopo il cosiddetto “Concilio di Gerusalemme” (At 15), nel quale venne risolto il problema dell’ammissione dei pagani alla comunità, non si hanno invece più notizie del gruppo come tale, ma soltanto dell’attività di alcuni dei suoi membri.
Il Vaticano II, che dovette affrontare tra tanti altri temi anche questo, perché la coscienza su di esso era andata maturando da qualche decennio, assunse i succitati dati del Nuovo Testamento sugli Apostoli e li esplicitò nel seguente testo: “Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che Egli voleva, e ne costituì dodici perché stessero con Lui, e per mandarli a predicare il regno di Dio; e questi Apostoli li costituì a modo di collegio o ceto stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro” (LG 19a).
Ma poi, fondandosi su diversi argomenti tratti dall’esperienza plurisecolare vissuta della Chiesa, aggiunse che i vescovi attuali (come anche quelli che li hanno preceduti in passato) sono i successori di quei dodici Apostoli (LG 20c) e che essi, similmente a Pietro e agli altri Apostoli, costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico (LG 22a). E specificò che tale collegio è costituito da tutti i vescovi della Chiesa universale che sono in comunione gerarchica tra di loro e con il vescovo di Roma, successore di Pietro, che lo presiede.
Sono questi, in stringata sintesi, i principali dati forniti dal Concilio sul tema. Non gli fu facile arrivare a stabilirli, perché s’interponeva, in alcuni dei suoi partecipanti, la paura di offuscare con essi la figura del papa come capo della Chiesa, di intaccare la sua autorità. Tuttavia, la forza del principio fondamentale della comunione portò a superare tali reticenze.
Più che evidenziare ulteriori affermazioni conciliari, di taglio prevalentemente giuridico, riguardanti questo tema, crediamo opportuno evidenziare il suo senso profondo. Il collegio dei vescovi costituisce, come abbiamo appena accennato, la realizzazione, al più ampio raggio della Chiesa, del principio di comunione.
Forse ciò apparirebbe più chiaramente se si traducessero i termini adoperati dal Concilio e indicanti potere (“potestà”, ecc.), con termini indicanti responsabilità. Si sarebbe così più in sintonia con quanto costituisce l’ispirazione più profonda del Concilio stesso.
Se si vedono le cose in questo modo, parlare di “collegio” significa parlare di corresponsabilità. Essere corresponsabili significa condividere il peso della responsabilità tra diverse persone.
Nel nostro caso, il collegio episcopale mette in rilievo il fatto che nella Chiesa anche la responsabilità suprema va condivisa. Anche se il vescovo di Roma, come vedremo fra poco, porta sulle sue spalle il grande peso di tale responsabilità, egli non è il solo a reggerlo. Entrano in comunione con lui tutti coloro che esercitano la stessa responsabilità nelle loro rispettive Chiese particolari.
È evidente che deva essere così, dal momento che la Chiesa universale risulta dalla comunione di tutte le Chiese particolari (LG 23a). La responsabilità condivisa è molto più sopportabile, e inoltre ha la possibilità di venire esercitata in modo molto più ricco ed efficace.
Un fatto positivo, derivato dall’enunciato conciliare del collegio episcopale, è stato la creazione delle “conferenze episcopali” a diversi livelli: nazionali, regionali, continentali. Anche questi organismi sono una realtà giuridica, ma vanno molto oltre. Offrono, infatti, la possibilità di vivere più concretamente il principio fondamentale di comunione e, inoltre, l’occasione di unificare le forze dei cristiani delle diverse Chiese in una determinata zona, per poter così rispondere con maggior realismo ai problemi che l’azione di salvezza propone.
3.2. Il servizio del papa alla Chiesa
È innegabile che la Chiesa cattolica si distingue da tutte le altre Chiese e confessioni cristiane per il fatto di riconoscere quello che viene chiamato “il primato del papa”. Risulta quindi importante esaminare il senso di questa componente, cercando di capirla alla luce di quanto abbiamo visto finora.
Che il vescovo di Roma venga riconosciuto dai cristiani-cattolici come “successore di Pietro” e come “vicario di Cristo” (santa Caterina da Siena lo chiamava “il dolce Cristo in terra”), ha suscitato nella storia e suscita ancora attualmente diversi interrogativi: Cosa significò Simon Pietro per la primitiva comunità credente? Vi esercitò qualche servizio specifico, diverso dagli altri? Occupò in essa un posto peculiare? Se esercitò un tale servizio, era necessario che esso si prolungasse attraverso i secoli? Se si prolungò, è il vescovo di Roma a continuarlo oggi? In che cosa consiste il servizio del papa verso la Chiesa universale? Come dovrebbe svolgerlo oggi?
Gli interrogativi non sono pochi. Cercheremo di rispondere brevemente ad essi.
Pietro nella Chiesa primitiva
Gli scritti neotestamentari offrono una serie di dati riguardanti questo discepolo di Gesù, al quale riconoscono un’importanza speciale all’interno del gruppo dei “dodici”.
Innanzitutto mettono sempre Simone, figlio di un certo Giovanni, il quale a un dato momento della sua vicenda ricevette da Gesù il nome di Pietro (Mt 16,18), alla testa delle liste dei componenti di tale gruppo (Mt 10,2 e par.). Egli è anche colui che, pieno di ardore, prende di solito la parola in nome di tutti (cf Mt 16,16, ecc.). Doveva avere un temperamento molto vivace e impulsivo, a giudicare da questi suoi interventi. Tanto che qualcuno ha avanzato l’ipotesi, difficilmente verificabile, che antecedentemente fosse appartenuto al gruppo degli zeloti, i quali si proponevano di cacciare via i Romani dalla Palestina con la violenza.
I Vangeli sinottici raccontano anche, con ammirabile schiettezza, il suo tradimento: egli abbandonò Gesù nel momento del processo che lo portò alla morte (Mt 26,69-75 e par.).
Diversi testi ci fanno sapere, inoltre, che dopo la Pasqua egli, riavutosi dalla sua “caduta” (Gv 21,15-17), presiede, in un primo momento insieme agli altri dodici e poi con Giacomo e Giovanni, la comunità di Gerusalemme e altre comunità ad esse unite (At 1,12.15; 2,14.37; 3,12; GaI 2,11), soffrendo anche persecuzioni per l’annuncio del Vangelo (At 4,1-2; 5,18; 12,3).
È anche lui a introdurre, dopo un’illuminazione ricevuta da Dio, i primi pagani nella comunità ecclesiale, battezzandoli senza farli passare attraverso la circoncisione giudaica (At 10).
Dopo il cosiddetto Concilio degli Apostoli (At 15) egli abbandona Gerusalemme e viene ivi sostituito da Giacomo, conosciuto come “il fratello del Signore”. Negli ultimi scritti del Nuovo Testamento, Pietro appare come “apostolo di Gesù Cristo”, come “pastore”, come “copresbitero” (1 e 2 Pt).
Secondo la tradizione, molto attendibile dati gli argomenti apportati, Pietro si stabilì a un certo punto della sua vita a Roma, dove, già anziano, subì il martirio per la fede nel Vangelo.
C’è però un testo del Nuovo Testamento che merita - e ha meritato lungo i secoli - un’attenzione speciale da questo punto di vista. È quello di Mt 16,18-19 che riporta queste parole di Gesù a Pietro: “E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”.
In certe epoche di controversie tra le diverse Chiese cristiane, si arrivò perfino ad affermare che questo testo era stato una “interpolazione romana”, ossia una creazione posteriore della Chiesa cattolica per provare il primato del papa. Oggi tale posizione non è più sostenuta con serietà da nessuno.
Ciò che si continua ancora a discutere è l’origine redazionale del testo e il momento storico in cui avrebbe avuto luogo il fatto cui allude la narrazione. Le prese di posizione al riguardo sono molto varie. Non è il caso di elencarle.
Checché ne sia ditali discussioni, non sempre svolte con la dovuta serietà e oggettività, esse non sembrano intaccare sostanzialmente il contenuto di messaggio che ha il testo. Cosa intende trasmettere in ordine alla vita della Chiesa e, oltre ad essa, in ordine alla salvezza? Ecco la domanda centrale.
Per rispondere, bisogna analizzare le tre metafore riferite a Simon Pietro che si intrecciano nel testo: la pietra, le chiavi, la funzione di legare e sciogliere. Dall’analisi che ne fanno i biblisti si arriva a questa conclusione: le tre metafore vogliono indicare che Pietro occupa nella Chiesa di Gerusalemme, e per estensione anche nelle altre, un posto di autorità e disciplina. Egli è il fondamento di tutta la comunità credente, ed esercita un ruolo importante nella fede, che si ripercuote anche sulla disciplina.
Questo è, certamente in forma molto succinta, quanto raccogliamo dall’esegesi del testo. Ma, oltre a ciò, è molto importante sapere come l’ha inteso la comunità ecclesiale lungo la sua storia. La comprensione che ne ha avuto è stata spesso pesantemente segnata dalle vicissitudini storiche del momento. È stato in relazione con i due più grossi scismi della Chiesa universale: quello del secolo XI, che sigillò la separazione tra la Chiesa orientale e quella occidentale con la reciproca scomunica, e quello del secolo XVI, che diede origine alle Chiese e confessioni protestanti. Tanto gli “ortodossi” orientali quanto i “protestanti” si sono rifiutati di comprendere il testo di Mt 16,16-18 quale fondamento del primato di giurisdizione del papa di Roma, benché alcuni di essi gli abbiano riconosciuto un “primato di onore” per il fatto di succedere a Pietro.
La Chiesa cattolica, invece, intese detto testo in senso “primaziale”. La sua dichiarazione più importante al riguardo, preceduta da numerose altre, è certamente quella della costituzione Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I (anno 1870).
Detta Costituzione, fondandosi sulla dottrina della Scrittura, proclamò solennemente che se qualcuno dice che l’apostolo Pietro non è stato costituito da Cristo Signore come il primo di tutti gli Apostoli e capo visibile di tutta la Chiesa, o che ricevette direttamente o immediatamente da lui un primato d’onore ma non una vera e propria giurisdizione, deve essere considerato fuori della fede cristiana (DS 3055).
La definizione, come si può facilmente constatare, è condizionata, nel suo modo di esprimersi, dalle circostanze storiche in cui fu pronunciata. È polemica, poiché prende di mira tutti quelli che in qualche modo o in qualche misura sono “scismatici”, cioè separati dalla Chiesa che riconosce l’autorità suprema del papa; e subisce inoltre l’influsso delle concezioni ecclesiologiche del secolo scorso per quanto riguarda l’autorità e il suo esercizio.
Andando tuttavia oltre al modo di esprimersi, si può cogliere ciò che essa intende sostanzialmente trasmettere: Gesù volle venire incontro al bisogno della comunità ecclesiale di avere un punto fermo, affinché “tutti i credenti potessero rimanere uniti con il vincolo di una sola fede e carità nella casa di Dio vivo” (DS 3051), e per questo scelse Pietro come capo della sua Chiesa.
Un bisogno, naturalmente, non circoscritto ai primi momenti della comunità credente, ma permanente, di tutti i secoli (DS 3056).
Pietro nei secoli
Ma, di fatto, chi ha continuato lungo i secoli questo servizio di Pietro all’unità di tutta la Chiesa?
Un’indagine storica permette di concludere con chiarezza che già nel secolo IV la coscienza dei vescovi di Roma di succedere a Pietro in questa funzione è un dato indiscusso. I dati dei secoli precedenti non godono, invece, di tanta chiarezza. Ciò non significa però che non ci sia stato il fatto, benché con caratteristiche diverse, date le diverse circostanze.
Il Concilio Vaticano I si pronunciò anche solennemente su questo punto, ribadendo appunto che il papa è il successore di Pietro (DS 3058).
Il servizio del papa alla Chiesa universale
Cosa fa, allora, il successore di Pietro nella Chiesa?
Il Vaticano I, esprimendosi sempre con la mentalità e le categorie del suo tempo, esplicitò il senso di detto servizio dicendo che il papa è il “vicario di Cristo e capo di tutta la Chiesa, e padre e maestro di tutti i cristiani”, e che perciò stesso, possiede “la piena potestà di pascere, reggere e governare la Chiesa universale, così come si contiene negli atti dei Concili ecumenici e nei sacri canoni” (DS 3059).
Risulta evidente anche in queste affermazioni, come in quelle precedenti, la sensibilità ecclesiologica propria del secolo scorso. Da parte sua il Vaticano II tornò a ribadire l’esistenza del servizio del papa alla Chiesa universale, ma volle collocarla nel contesto della nuova coscienza ecclesiale maturata durante la sua celebrazione. Perciò fece precedere la trattazione di tutti i diversi servizi pastorali, anche di quello del papa, dalla trattazione sul Popolo di Dio (LG 9-17). Inoltre, come si è visto sopra, completò l’esposizione del Vaticano I, che era rimasta monca per motivi storici, con la dottrina sul collegio episcopale.
In questo nuovo contesto, il Vaticano II riaffermò la dottrina sul primato del vescovo di Roma (LG 18b), ma lo spogliò da quella interpretazione in chiave di superiorità o di dignità alla quale secoli di storia avevano assuefatta la Chiesa, e anche da ogni interpretazione in chiave di potere nello stile del mondo. Lo presentò, invece, in una nitida linea di responsabilità e di servizio.
Riprendendo quanto esso disse, possiamo affermare quindi, in breve, che il papa è quel membro della comunità ecclesiale che ha ricevuto dallo Spirito, attraverso le mediazioni umane che cambiano lungo i secoli, il carisma della responsabilità ultima non soltanto nella sua Chiesa particolare, quella di Roma, della quale egli è vescovo, ma anche nella Chiesa universale, costituita dalla comunione di tutte le Chiese particolari (LG 23a). Perciò egli, come amava dire di sé il papa san Gregorio Magno (+ 604), è “il servo dei servi di Dio”.
Questo servizio implica alcune peculiarità, che scaturiscono dalla sua singolare situazione ecclesiale. Le indichiamo brevemente.
Nella linea dell’annuncio del messaggio evangelico, esso comporta ciò che è stato chiamato la infallibilità pontificia. Questa infallibilità non è, come a volte sostengono coloro che non appartengono alla Chiesa e talvolta perfino coloro che ne sono membri, una prerogativa assoluta e quasi dispotica del papa. Al contrario, già il Vaticano I, che la fece oggetto di una solenne definizione dogmatica, aveva precisato opportunamente le circostanze in cui va esercitata e le condizioni che ne limitano l’esercizio: solo quando il papa parla “ex cathedra”, cioè quando, “svolgendo il suo ufficio di pastore e dottore di tutti i cristiani, definisce con la sua propria autorità apostolica che una dottrina sulla fede e i costumi deve essere sostenuta dalla Chiesa universale” (DS 3074) come realmente evangelica.
Ci possiamo domandare che cosa significhi questo oggi, in un tempo così profondamente diverso, tanto da un punto di vista umano quanto da un punto di vista ecclesiale, da quello in cui furono pronunciate tali parole. Ci forniscono la chiave di risposta le affermazioni del Vaticano II: la comunità ecclesiale tutt’intera non può sbagliare sostanzialmente nella comprensione del messaggio di salvezza (LG 12a); l’assistenza dello Spirito di Gesù, promessa da lui stesso (Gv 16,23), la preserva dall’errore. L’infallibilità del papa e degli altri pastori (collegio episcopale: LG 25) stanno al servizio di questa giusta comprensione del Vangelo.
D’altronde occorre tener conto del fatto che l’infallibilità, tanto della comunità quanto dei pastori, non è un dono miracolistico o quasi magico. Essa suppone uno sforzo di ricerca per arrivare a scoprire la verità (LG 25d). In tale sforzo la funzione del papa e del collegio episcopale acquistano grande importanza. Essi sono coloro che conducono la comunità nella ricerca della verità evangelica da vivere e proclamare.
Così vista, l’infallibilità viene a costituire un vero carisma e resta spogliata da ogni prospettiva di magismo o autoritarismo.
Nella linea dell’organizzazione e del funzionamento della Chiesa universale abbiamo incontrato sopra alcune affermazioni riguardanti il primato di giurisdizione del papa, cioè, in concreto, la sua funzione di presidenza: secondo tali affermazioni, egli “governa” la Chiesa universale.
È opportuno ricordare in proposito quanto fu già detto precedentemente: l’esercizio concreto del servizio di conduzione della Chiesa universale da parte del successore di Pietro soffrì il condizionamento delle circostanze storiche. Il modo in cui Pietro in persona presiedeva la comunità primitiva non è certamente quello in cui lo fecero ai loro tempi Gregorio VII (s. XI) o Innocenzo III (s. XIII) che erano praticamente imperatori dell’Europa, o ancora i “papi umanisti” quali Leone X (s. XVI).
Indubbiamente, anche oggi la Chiesa deve conservare intatta l’affermazione dogmatica della necessità di un fondamento visibile nella comunione e nella fede (DS 3050), ma è importante che la contestualizzi nelle mutate circostanze presenti. Le prospettive aperte dal Vaticano II e dal modo di agire dei papi che, a partire da esso, si sono succeduti in questa responsabilità, hanno già indicato nuovi orizzonti in questo senso.
Tali prospettive si orientano verso la realizzazione simultanea di due obiettivi: da un lato, il rispetto profondo verso l’originalità, il ritmo di vita e di crescita, la problematica e la sensibilità delle singole Chiese locali o particolari; dall’altro, la convergenza di tutta questa ricchezza verso la comunione cattolica o universale.
Ma soprattutto è importante che il papa aiuti l’intera Chiesa a non perdere di vista ciò per cui essa è stata convocata. Che egli, come fece Simon Pietro ai tempi di Gesù, l’aiuti a dare risposta, più ancora con la vita e l’impegno che con la professione ortodossa della fede, alla domanda da lui fatta: “Voi, chi dite che io sia?” (Mt 16,15-16).