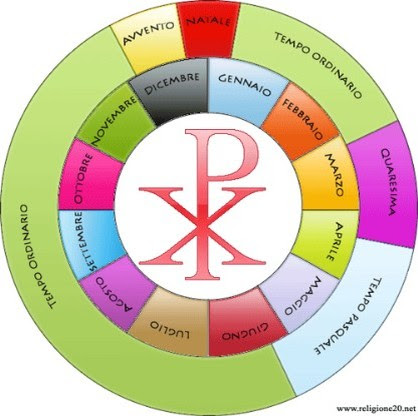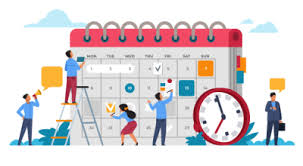Nuova evangelizzazione
e giovani:
lo spettacolo della croce
Bruno Maggioni
Se mi si chiedesse di definire il genere di questo intervento, oserei chiamarlo una «testimonianza». Per questa ragione è il penultimo capitolo del libro, prima delle riflessioni conclusive. Qui voglio fissare lo sguardo sul cuore stesso del cristianesimo. Questa sarà una testimonianza fatta solo di parole, ma di parole sincere e, ne sono persuaso, parole vere. Parole vere che raccontano una storia che è anzitutto da «contemplare», perché «bella». La prima caratteristica del mistero di Dio, infatti, è la bellezza. Tutte le volte che ripenso a questa storia e la ridico, la mia prima reazione è lo stupore. Sono molti anni che la sento raccontare, ma lo stupore non viene mai meno. È lo stupore di fronte alla grandiosa bellezza del volto di Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Nello stesso tempo ritrovo in questa narrazione, come in uno specchio, la mia esperienza, cioè le mie domande più profonde e le risposte che da solo non avrei mai trovato e che, dopo averle udite, sento vere. È anche questo un motivo di stupore.
Che cosa significa «nuova evangelizzazione e giovani»?
Intanto i giovani. I giovani sono, certamente, oggetto dell'evangelizzazione, ma devono anche essere soggetto: evangelizzatori e protagonisti. Se la prima parola di Gesù ai discepoli è «seguitemi», l'ultima è «andate». E quando diceva «seguitemi», già pensava all'«andate»: «Vi farò pescatori di uomini».
Chi sono i giovani? Li immagino attraversati da due grandi passioni; se mancasse l'una o l'altra di queste due passioni, avrei difficoltà a chiamare giovane un uomo.
La prima passione è una forte esigenza di giustizia concreta per tutti: la fame, la vita, la libertà. Una passione, questa, che deve farsi denuncia e impegno, e anche perché no? interrogativo di fede. È impensabile che un giovane, che sente la passione della giustizia, non faccia propria, se credente, la domanda del profeta Abacuc: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti [...], mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione?» (Ab 1,23). Oppure la domanda dei martiri dell'Apocalisse: «Fino a quando, Sovrano [...], non farai giustizia?» (Ap 6,10). Questa domanda è interna alla fede. Ed è, paradossalmente, il segno della giovinezza di un uomo. Giovane è chi, di fronte all'ingiustizia, continua a meravigliarsi e ad arrabbiarsi. Chi vi si adatta, osservandola con occhi distaccati, sarà (forse) un uomo lucido, ma certo non è più un uomo giovane.
Accanto alla passione per la giustizia, una seconda passione altrettanto forte, forse ancora più forte: la ricerca della verità dell'uomo e della storia. Mi viene in mente una grandiosa scena dell'Apocalisse, forse la più significativa di tutte (cap. 5). Colui che è seduto sul trono ha in mano un libro chiuso con sette sigilli. Chi può aprire questo libro? Nessuno. E allora l'uomo, Giovanni, piange: come si può vivere senza aprire quel libro, come si può vivere senza sapere il senso e la direzione, cioè la verità della vita e della storia? Quando parlo di verità intendo qualcosa di molto serio e di molto concreto. La verità, per la Bibbia, è la solidità: nel frastuono delle troppe parole che sento, nel frastuono delle molte idee, nella moltitudine delle proposte, c'è qualcosa di solido, qualcosa che resiste al mutamento, c'è una roccia sulla quale io posso poggiare i piedi e costruire la casa, la casa della mia esistenza, la casa della storia? Come nella parabola delle due case: quella costruita sulla sabbia e quella costruita sulla roccia. Questa è la grande domanda: qual è la sabbia? qual è la roccia?
Nel titolo del nostro capitolo c'è poi l'aggettivo nuova. Tale aggettivo lo possiamo intendere anzitutto in modo molto comune, direi quasi banale. E allora parliamo di evangelizzazione nuova, perché riteniamo necessario in un mondo scristianizzato come il nostro riprendere l'evangelizzazione da capo. O, anche, nuova nel senso che il vangelo deve oggi misurarsi su realtà nuove, deve far fronte a problemi nuovi. Oppure nuova perché l'annuncio del vangelo deve ritrovare colore e sapore. Può anche darsi, infatti, che il vangelo si sia scolorito in un annuncio scialbo, annoiato e svilito da una lunga assuefazione.
Ma con l'aggettivo nuova possiamo intendere anche molto di più. Non una novità cronologica, ma una novità teologica. Il vangelo è nuovo non perché non l'ho mai sentito, non perché affronta problemi nuovi; non perché lo ridico con parole nuove, ma perché è una notizia che rinnova e stupisce ogni volta che viene udita. La novità del vangelo è la perenne novità dell'amore di Dio. L'amore non invecchia, né stanca mai. È nuovo ogni giorno. Perché l'amore è la realtà di Dio che si visibilizza e si comunica, o, se preferiamo, è il mondo nuovo che, in qualche modo, si anticipa nel nostro mondo vecchio. Se intendiamo la nuova evangelizzazione secondo la prima linea, l'aggettivo nuovo indica semplicemente un'emergenza: siamo di fronte a un'emergenza, occorre una nuova evangelizzazione. Se la intendiamo, invece, nel secondo modo, allora abbiamo colto una nota intrinseca al vangelo, che è sempre nuovo e che deve sempre risultare nuovo. Se l'annuncio del vangelo appare vecchio e crea noia, allora vuol dire che non è stato annunciato il vangelo, ma qualcos'altro.
Infine la parola evangelizzazione. Di per sé indica portare un annuncio lieto e gradito. Ma quale annuncio? E come portarlo? Il vangelo è lieta notizia perché nel contempo «interrompe e compie». Interrompe la monotonia quotidiana, annoiata, insoddisfatta, che troppe volte sembra caratterizzare la nostra esistenza, e compie perché ci apre nuovi cammini, che magari cercavamo e desideravamo senza neppure saperlo. Di fronte a questa notizia comprendi che devi ripensare la vita, cambiare strada, ma comprendi anche che finalmente ti ritrovi. La reazione è la sorpresa, certo anche la fatica del cambiamento, ma soprattutto la gioia del compimento.
La buona notizia, in ogni sua forma di annuncio, ci porta a un'unica persona e a un unico evento: Gesù Signore, Figlio di Dio fatto uomo. Ma non è sufficiente dire «fatto uomo»; si è fatto quell'uomo, e ha dato quello spettacolo.
Lo spettacolo della croce
Arrivo così alla seconda parte di questo capitolo testimonianza, che non vuole essere altro che una contemplazione della grande memoria cristiana, la croce. La croce vista e compresa non attraverso i nostri occhi deboli, e spesso distratti, ma attraverso lo sguardo penetrante dei primi testimoni. Ricordo quattro affermazioni che considero di rara bellezza.
La prima si trova nel Vangelo di Giovanni, a conclusione di tutto il racconto della crocifissione: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37). Mi sembra una definizione della chiesa, popolo di coloro che guardano colui che è stato trafitto.
Molto bella anche una frase di Luca, pure a conclusione del racconto della croce: «Tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto» (Lc 23,48). «Spettacolo», in greco theoria.
La terza affermazione è dello stesso Gesù: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32). La croce è il centro dell'universalità, il luogo dell'incontro.
L'ultimo testo lo troviamo nell'Apocalisse: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto» (Ap 1,7). Alla luce di queste quattro grandi affermazioni si comprende subito che la croce è la grande icona, la memoria fissa del credente, lo spettacolo dal quale non si deve mai staccare lo sguardo. Theoria (il termine usato da Luca) non indica un'immagine ferma, ma un dramma in svolgimento. È uno spettacolo che occorre vedere e rivedere (theorein, dice ancora Luca), penetrare, scrutare e ripensare. E il grande dramma, l'unico che vale la pena di vedere, perché illumina tutti gli altri.
Dobbiamo ora osservare con attenzione i tratti principali di questo spettacolo.
1. È, anzitutto, uno spettacolo pubblico, che si svolge davanti a tutti: non solo davanti al discepolo e alla madre (e poi a tutti i credenti che «guarderanno»), ma anche davanti alla folla accorsa e davanti ai semplici passanti. La ragione della sua condanna precisa Giovanni era scritta in tre lingue: tutti potevano leggerla. Uno spettacolo, dunque, che si svolge di fronte alla chiesa e di fronte al mondo. Uno spettacolo pubblico che vuole restare pubblico.
2. Uno spettacolo che sorprende, persino scandalizza, ma proprio la ragione del suo scandalo è per il credente la ragione della sua bellezza. Sorprende (o scandalizza) doppiamente. Perché racconta di uno «sconfitto» che invece è un «vittorioso». La croce dovrebbe avere due facce: da una parte il Crocifisso dall'altra il Risorto. Una faccia dà senso all'altra. Sorprende, inoltre, perché si tratta di uno spettacolo in cui appare tutta la malvagità dell'uomo, che non esita a condannare l'innocente; ma nel contempo appare tutta la profondità e l'ostinazione del perdono di Gesù. La malvagità dell'uomo non annulla la solidarietà di Gesù verso l'uomo. Il perdono di Dio, svelato dalla croce, è la suprema garanzia della vita e della storia, ed è la prima ragione della speranza. Il peccato non è la realtà ultima, perché superato dal perdono di Dio. Il dramma della croce ti fa assistere all'arroganza della menzogna che sembra più forte della verità. Sulla croce vedi un innocente sconfitto e trafitto. E questo deve spingerti a vedere il male con sguardo serio. La croce insegna che il male c'è, che la malvagità esiste, e che occorre vederla, scoprirla, denunciarla, ammetterla. Il credente guarda il male con sguardo serio e preoccupato. Ma la croce è anche uno spettacolo in cui si scorge il perdono.
Una storia ebraica racconta che quando Dio decise di creare il mondo non riusciva a farlo stare in piedi, non stava ritto, cadeva e ricadeva, una volta, due volte. Allora Dio, accanto al mondo, creò il perdono e il mondo stette ritto. Se il mondo continua, è perché Dio ci perdona tutte le mattine e tutte le sere, e il Cristo in croce è la rivelazione di questo perdono. Se dunque la crocifissione è uno spettacolo perché mostra la malvagità, è ancor più uno spettacolo lieto perché mostra il perdono. Per questo il discepolo di Gesù è nel contempo serio e sereno.
3. Il dramma della croce è uno spettacolo che converte. Le folle accorrono, guardano, comprendono e «si battono il petto». Lo spettacolo della croce capovolge la vita. Osservandolo comprendi che la tua vita deve assomigliare alla vita di quel Crocifisso che, rifiutato, ama e perdona, e non rompe la solidarietà con chi lo rifiuta. Comprendi che la strada della vita non può essere che il dono.
L'Apocalisse e tutta la meditazione dei primi cristiani ci fanno poi capire che il dramma del Cristo morto e risorto non è un semplice momento della storia, un semplice lampo che improvvisamente l'ha attraversata: è la chiarezza, il senso che cercavi, la radice della speranza di cui avevi bisogno, il libro sigillato che si è finalmente aperto. Guardando lo spettacolo del Crocifisso, comprendi che la storia, la quale spesso pare non avere né capo né coda, ha in realtà un preciso destino.
4. E va detto, infine, che si tratta di uno spettacolo pericoloso. Pericoloso per il mondo che viene giudicato. Di fronte al Crocifisso il mondo si vede smascherato nella sua menzogna, e si arrabbia e reagisce e colpisce. Ma pericoloso anche per il credente, perché ormai non può più fare a meno di camminare lungo la strada che corre il rischio della solitudine e del martirio.
La conclusione, mi pare, è che il cristiano è tutto l'opposto di un discepolo tranquillo che scivola giorno dopo giorno nella banalità e nell'annoiata osservanza di alcuni doveri religiosi. È, invece, attore di un dramma che proietta al di fuori: al di fuori del mondo, perché propone di vivere secondo una logica del tutto diversa dalla logica mondana; al di fuori di se stessi, perché propone un'esistenza che alla conservazione di sé preferisce il dono di sé; e al di fuori anche della propria comunità, perché anche la comunità deve se vuole davvero porsi alla sequela del proprio Signore aprirsi al mondo e farsi universale.
Lo spettacolo che diventa realtà
A questo punto ho solo alcune domande a cui cercherò di dare qualche risposta.
La prima domanda: come assistere a questo spettacolo? Come guardarlo? Ho già detto e ripetuto che è uno spettacolo da guardare insieme, dentro una comunità. Non devo guardarlo da solo, non lo capi rei. Devo guardarlo dentro la chiesa.
È uno spettacolo che devo vivere. Non è concesso guardarlo da spettatore interiormente assente. La croce è uno spettacolo che devo «ridisegnare» dentro la mia vita, anche se so che non riuscirò mai a ridisegnarlo completamente, né io né la mia comunità. Per questo devo contemporaneamente viverlo ricordarlo, mostrarlo e raccontarlo. Non basta cioè mostrare al mondo la mia esperienza, né quella della mia comunità. Troppo inadeguate. Devo sempre raccontare la storia di Gesù Cristo. Lo spettacolo deve farsi contemporaneamente vita e parola, testimonianza e discorso. È, vero che l'evangelista Giovanni ha scritto che «la Parola si è fatta carne», ma, divenuta carne, è rimasta Parola. Non c'è missione senza annuncio.
Ho parlato di dono di sé e di esistenza pericolosa. Ma come calare tutto questo nella vita quotidiana? Ecco la seconda domanda. Il percorso che ci permette di ridisegnare nel quotidiano lo spettacolo che abbiamo ammirato è indicato dalle beatitudini evangeliche.
Beati i puri di cuore
La prima beatitudine riguarda la povertà, ma io preferisco iniziare da quella dei «puri di cuore», ai quali è promessa la visione di Dio. La purezza di cuore è la totalità della ricerca di Dio. Il puro di cuore è l'uomo che cerca Dio con tutto se stesso, con cuore indiviso, trasparente, tutto orientato in una sola direzione. La differenza tra il santo e il mediocre è tutta qui: il santo è tutto proteso nella ricerca di Dio, il santo è impegnato, persino indaffarato, e tuttavia è immobile, fisso in Dio. Il mediocre, invece, è un uomo diviso: qualcosa a Dio, qualcosa a se stesso. Il contrario del puro di cuore è l'uomo distratto, frantumato e disperso. Come l'uomo che cerca di servire due padroni: Dio e il denaro. O come l'uomo «dalle due anime», di cui parla la lettera di Giacomo. Un tale uomo assomiglia all'onda del mare, sempre in balia del vento e della risacca. È un uomo diviso e contraddittorio, perennemente oscillante, incapace di scelte ferme e radicali.
Ma la totalità della ricerca di Dio dicono le altre beatitudini deve avvenire dentro il circuito della solidarietà. Non c'è altro luogo in cui cercare totalmente Dio se non la solidarietà con l'uomo: la misericordia, la passione per la giustizia, l'impegno per la pace. Il puro di cuore è totalmente aperto a Dio e totalmente aperto ai fratelli.
Beati i misericordiosi
La misericordia è proprio quell'amore eccedente, ostinato, che rimane solidale anche se rifiutato. È il centro dello spettacolo. Naturalmente la misericordia non è un amore di parole, ma un amore che si fa carico, come l'amore del samaritano. Ed è un amore che non esclude nessuno, anche se resta vero che al centro ci sono gli ultimi, e per ultimi non si intendono solo i poveri, gli ammalati, gli stranieri, ma anche i peccatori, i colpevoli. Collocata al centro dello spettacolo, la misericordia diventa la misura della vita. Le cose solide della vita, quelle che rimangono perché salde come la roccia, sono l'amore, la solidarietà, la fedeltà ostinata, il perdono: in una parola, la misericordia evangelica.
Beati gli affamati e gli assetati di giustizia
Con queste parole Gesù non si rivolge in primo luogo ai ricchi e ai sazi perché diano le briciole del loro superfluo agli affamati. Si rivolge direttamente agli affamati, perché trovino la forza di rizzarsi in piedi e farsi protagonisti del loro cammino. A questi affamati la beatitudine non offre progetti economici né progetti politici, ma una speranza: «Sarete saziati». Una speranza solida, al sicuro, perché sostenuta e garantita dalla croce di Gesù. La speranza è indispensabile per uscire dalla rassegnazione (che annullerebbe ogni sforzo di cambiamento) e dalla disperazione (che porterebbe fatalmente alla violenza). Ma se in primo luogo la beatitudine è rivolta agli affamati perché ritrovino la speranza e la dignità di affacciarsi come protagonisti sulla scena del mondo, in secondo luogo la beatitudine è rivolta anche a noi, i sazi, impegnandoci in un discorso che richiede profonda conversione. Avere fame e sete di giustizia significa avere la passione della giustizia, non un languido e sporadico interessamento. L'assetato desidera l'acqua con tutto se stesso, un desiderio che di colpo ridimensiona tutti gli altri desideri. Così l'assetato di giustizia è chi si impegna a fondo per la giustizia, con tutto se stesso, dalla mattina alla sera. Né si dimentichi che la parola giustizia nel vangelo ha un significato globale: non indica tanto il rispetto dei diritti fra gli uomini ma, ancor prima, il rispetto dei diritti di Dio. Ed è, come sempre, universale: non solo giustizia per me, per noi, per quelli della mia parte, ma per tutti, senza distinzioni.
Beati i costruttori di pace
Il vangelo è consapevole di parlare di una pace che non è ovvia. C'è pace e pace, quella del mondo e quella di Gesù. L'antitesi non è fra pace materiale e spirituale, terrestre e celeste, ma fra pace evangelica e mondana. La pace di Cristo afferra tutto l'uomo, ma ha un'altra origine e si costruisce con un altro stile. L'uomo delle beatitudini non promette la pace facilmente, perché sa che essa esige un alto prezzo. Richiede infatti un coraggioso superamento di tutte quelle valutazioni che sembrano inesorabilmente imporsi. Le logiche ovvie (come quella che all'amore si debba rispondere con l'amore, alla forza con la forza, alla violenza con la violenza), comuni, razionalmente inattaccabili, non sono in grado di portare alla pace. Sono un vicolo cieco. La pace esige, come mostra Gesù appeso alla croce, che si risponda sempre con l'amore. E proprio perché discende dalla croce, la pace non è possibile senza la gratuità e il perdono.
Ma le beatitudini indicano anche uno stile, non solo un percorso. Anche lo stile fa parte dello spettacolo. Lo stile del discepolo è inconfondibile: rifiuta la violenza («beati i miti») e sa pagare il prezzo della persecuzione («beati i perseguitati»). I non violenti assomigliano a Gesù. Sono coraggiosi, si compromettono, suscitano problemi e anche disagi, ma non ricorrono alla violenza, perché credono nella forza dell'amore e della verità. Credono profondamente nello «spettacolo» che hanno ammirato, e perciò non ricorrono mai a mezzi non evangelici, neppure per far prevalere il vangelo. Non combattono l'arroganza del mondo con argomenti a loro volta arroganti.
Beati i poveri in spirito
Tutto questo fa già parte della prima beatitudine «beati i poveri in spirito», che però comprende anche altro: il povero in spirito è l'uomo che ha fiducia in Dio, conta su di lui e non su se stesso, e perciò sfugge alla passione dell'accumulo. Il povero in spirito è sobrio ed essenziale. Per due motivi: per essere libero e per condividere. E c'è di più: povero in spirito è l'uomo che concepisce tutto se stesso in termini di gratuità e non di possesso: una gratuità che, essendo dono nella sua origine, continua a farsi dono nel suo uso, e si fa servizio. La gratuità è la nota emergente dello spettacolo che abbiamo contemplato, e deve essere di conseguenza la nota emergente dello spet tacolo che il cristiano deve continuamente offrire al mondo con la sua vita.
L'amore gratuito che sempre vediamo al centro dello spettacolo, da qualsiasi punto lo osserviamo è una categoria che come poche altre sa unire due cose che alle volte noi scioccamente mettiamo in contrasto: l'identità e il dialogo. La carità è il cuore dello spettacolo, e dunque è il cuore dell'identità cristiana. Ma la carità è anche un'esperienza che ogni uomo in qualche modo comprende, che ogni uomo in qualche modo può condividere, sia pure a livelli diversi. Posti di fronte all'amore, all'amore gratuito e universale, tutti gli uomini comprendono che esso è verità. La verità di Dio e dell'uomo. La carità è per eccellenza una categoria missionaria. Inutile ricordare che, se vuole ridisegnare lo spettacolo, la carità deve imitare l'amore del Crocifisso, dunque deve apparire universale, gratuita ed eccedente. Direi soprattutto eccedente. Dio, infatti, ha manifestato sulla croce un amore misurato sulla sua grandezza, non semplicemente sui nostri bisogni. E così anche la carità cristiana non indugia troppo nel fare calcoli e nell'elaborare strategie: si abbandona alla generosità e alla fantasia dell'amore di Dio che è apparso sulla croce.
Non mancano, certo, le possibilità di offuscare lo spettacolo. Credere, ad esempio, come abbiamo detto e ripetuto, che il nostro spettacolo sia capace di ridisegnare completamente quello di Gesù. È invece sempre inadeguato e incompleto, è bene ricordarlo. Il nostro volto non riflette mai completamente quello di Gesù. Per questo occorre la parola che racconta ciò che Gesù ha fatto, non ciò che noi facciamo. C'è anche il rischio di sovrapporsi allo spettacolo di Gesù, impedendo agli uomini di vederlo compiutamente.
C'è una seconda possibilità di tradimento: dimenticare che lo spettacolo indica uno stile, un metodo. Si può infatti parlare della croce percorrendo strade che non sono quelle del Crocifisso. Gesù ha detto: «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me». Attirerò: questo verbo rifiuta ogni costrizione, ogni violenza, ogni ricorso a sotterfugi. Tutte cose che non occorrono, perché la forza di verità è dentro lo stesso spettacolo. Basta mostrarlo.
C'è una terza tentazione, a mio avviso non infrequente: l'angoscia della coerenza. Come invitare allo spettacolo, se io per primo lo tradisco? È certo importante sentire il dovere della coerenza, che tuttavia non deve mai trasformarsi in angoscia della coerenza. Il diritto e il dovere, infatti, di invitare allo spettacolo, non stanno nella nostra coerenza, ma nella bellezza di quello spettacolo che noi abbiamo ammirato e che non possiamo tenere per noi. L'importante è annunciare Gesù Cristo, non noi stessi. L'importante è invitare a guardare il suo spettacolo, non il nostro. Così possiamo annunciare anche se peccatori.
Ci resta una terza domanda: perché annunciarlo?
Le ragioni le abbiamo già dette e sono tutte dentro lo stesso spettacolo. Si tratta infatti di uno spetta
colo che è insieme bellezza, verità e amore. Tre realtà che generano dinamismo. Quando ti imbatti in una cosa bella, tu la racconti. Quando ti imbatti in una cosa vera, tu la ridici. Se hai capito che lo spettacolo del Crocifisso è come una folgore che ha illuminato
il cammino del mondo e di ogni uomo, allora tu lo dici a tutti, non puoi farne a meno. E se lo spettacolo ha cambiato la tua esistenza dandole forza e direzione, allora inviti tutti gli amici allo spettacolo. Non c'è forza missionaria semplicemente in un vangelo per sentito dire. Né c'è forza missionaria in un ordine che sopravviene dall'esterno. La missione nasce dal di dentro. La forza missionaria nasce dall'aver capito che non è la stessa cosa conoscere Cristo e non conoscerlo. La missione nasce dalla consapevolezza di avere incontrato una verità, che tutti gli uomini lo sappiano o no vanno cercando. Naturalmente la missione è sostenuta dall'amore per l'uomo, dal desiderio di salvarlo, di comunicargli quel dono che noi per primi abbiamo ricevuto. Ma non è tutto. Sono convinto che l'incoercibile bisogno di invitare tutti allo spettacolo nasca anche e soprattutto dal desiderio di mostrare ciò che Dio ha fatto. Utile o non utile, ciò che Dio ha fatto è troppo grande per non essere raccontato.
«Andate e proclamate»
Voglio terminare ricordando tre parole di Gesù, che mi sembrano molto significative. La prima è una domanda, ed è la prima parola che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni. Due uomini lo stanno seguendo, egli si volta e dice: «Che cosa cercate?» (Gv 1,38). E questa una grande domanda. Noi che cosa cerchiamo? Cerchiamo veramente Cristo? Non è scontato. Dietro la nostra ricerca di Dio può anche nascondersi una ricerca di noi stessi.
Anche la seconda parola di Gesù, che voglio ricordare, è una domanda, ed è la prima parola che Gesù rivolge ai discepoli nel Vangelo di Marco: «Perché avete paura?» (Mc 4,40). Serietà e impegno sì, mai però la paura. La paura blocca e rinchiude in se stessi. Lo spettacolo della croce che è spettacolo di amore e di perdono allarga il cuore e pone in movimento.
Prendo dal Vangelo di Marco anche la terza parola, una parola conclusiva, che Gesù rivolge ai discepoli inviandoli in missione. Scrive l'evangelista Marco: «Li rimproverò per la loro durezza di cuore [...J e disse loro: 'Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,1415). Che cosa c'è di più sorprendente e di più bello di questo «andate e proclamate»? I discepoli sono duri di cuore, è vero, e tuttavia sono «mandati». Il peccato non ha il diritto di rallentare la forza della missione.
(Bruno Maggioni, Nuova evangelizzazione. Forza e bellezza della parola, Messaggero 2012, pp. 142-158)